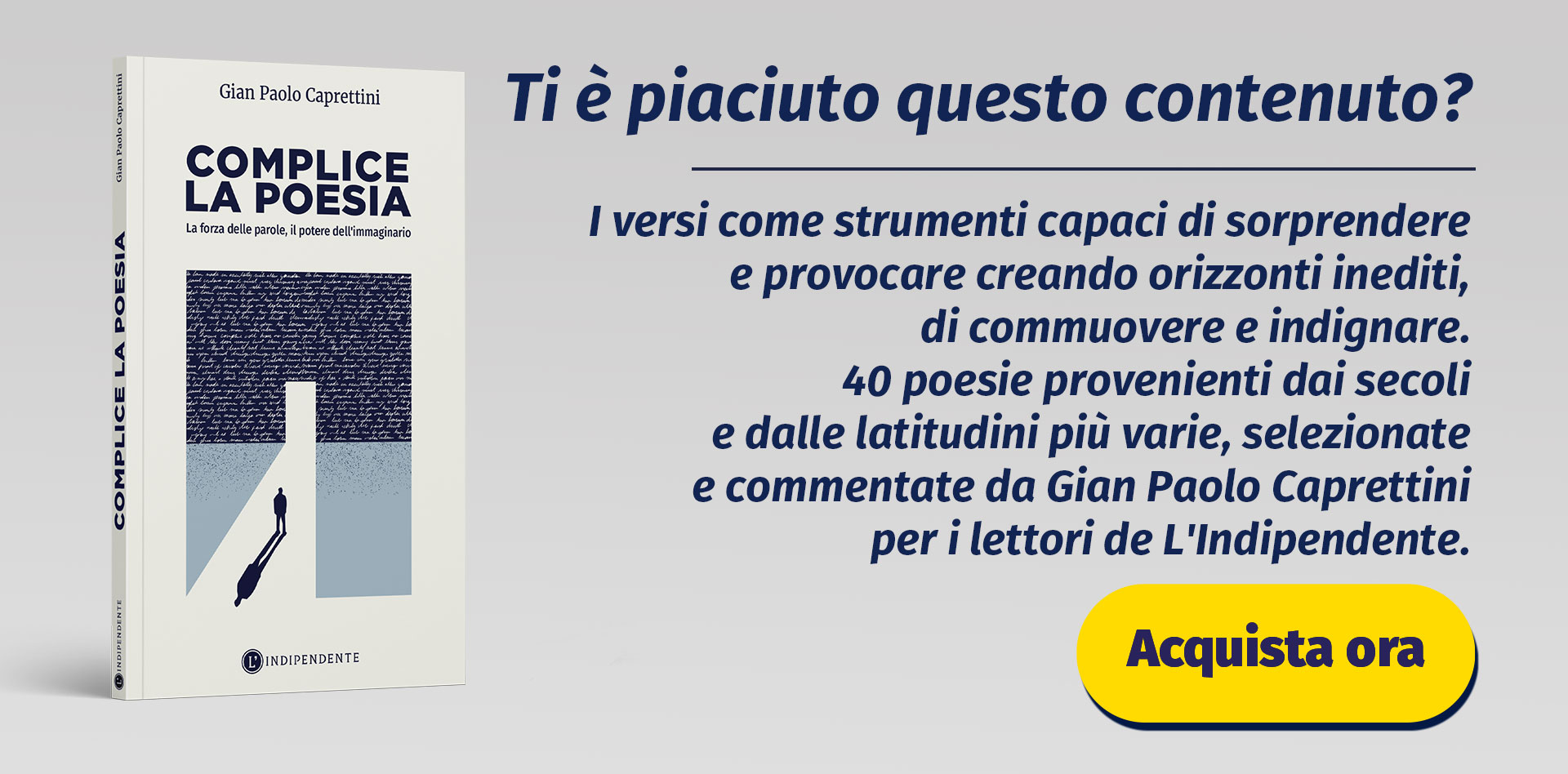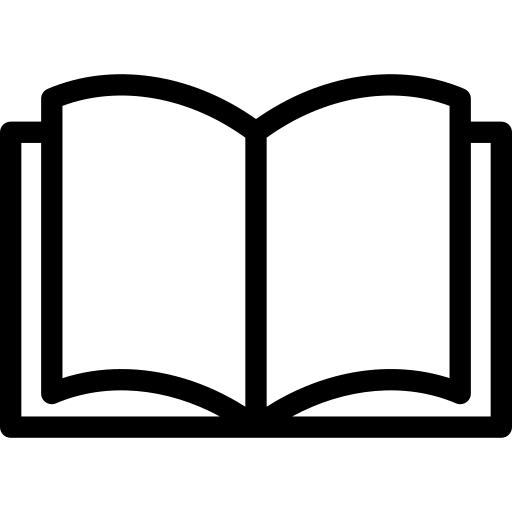Tre esplosioni in tre giorni hanno colpito altrettante raffinerie europee legate al petrolio russo: Ploiesti in Romania, Százhalombatta in Ungheria e Bratislava in Slovacchia. Un filo rosso collega i tre episodi: tutte e tre dipendono dal greggio di Mosca e sono state colpite in un momento cruciale della guerra energetica in atto. Mentre Washington vara nuove sanzioni contro i colossi energetici russi, Rosneft e Lukoil – “un atto ostile” secondo il presidente Putin – e l’UE approva lo stop al gas russo e il diciannovesimo pacchetto di misure punitive contro Mosca ma frena sull’uso degli asset russi congelati, le infrastrutture che ancora garantivano all’Europa un minimo margine di autonomia energetica vengono spazzate via da fiamme “inspiegabili”.
La stampa ufficiale liquida gli eventi come “incidenti tecnici”, ma l’impressione è che dietro ci sia molto di più: una strategia di sabotaggio sistematico, la stessa che tre anni fa fece saltare i gasdotti Nord Stream nel Baltico. Una guerra silenziosa, parallela a quella che avviene sul campo, che non mira solo a colpire Mosca, ma a piegare chi mantiene canali di approvvigionamento con Mosca e a ridisegnare gli equilibri di potere del Vecchio continente. Ricapitolando: il 20 ottobre un’esplosione ha devastato la raffineria di Ploiesti, in Romania, di proprietà di Lukoil Europe, filiale del colosso russo, ora sottoposto a sanzioni da parte di Washington. Poche ore dopo, un incendio ha colpito l’impianto ungherese di Százhalombatta, il più grande del Paese, sul Danubio a meno di 20 chilometri da Budapest, alimentato dal petrolio che arriva dal Druzhba. Due giorni più tardi, a Bratislava, in Slovacchia, una terza deflagrazione ha investito un altro impianto del gruppo MOL, della stessa compagnia ungherese colpita a Szazhalombatta, anche questa alimentata dal petrolio russo del Druzhba. Proprio con i dirigenti MOL si è confrontato il premier ungherese Viktor Orbán, che, in un’intervista alla radio Kossut, ha spiegato che l’Ungheria sta lavorando a un modo per “aggirare” le sanzioni USA contro le compagnie petrolifere russe. Budapest e Bratislava si sono imposte contro lo stop alle importazioni di gas russo. Entrambi i Paesi dipendono fortemente dalle forniture di Mosca e temono gravi ripercussioni economiche e sociali. Budapest ha definito il piano una minaccia alla sicurezza energetica nazionale, mentre Bratislava ha chiesto più tempo per adattarsi.
Tre episodi in 72 ore, nello stesso corridoio energetico che trasporta il greggio russo verso l’Europa centrale. I tre impianti hanno in comune che raffinano petrolio di fornitura russa e, ulteriore coincidenza, hanno registrato incidenti in una fase in cui i droni ucraini stanno intensificando gli attacchi alle raffinerie sul territorio russo. Se, citando Arthur Conan Doyle, «uUn indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova», quanto accaduto pare troppo perfetto per essere casuale. Gli episodi coincidono, infatti, con l’annuncio delle nuove sanzioni statunitensi e con l’aumento del prezzo del Brent: un tempismo talmente preciso da sollevare sospetti sulla reale dinamica di quanto accaduto. Anche i droni che in passato hanno colpito il ramo meridionale dell’oleodotto Druzhba – quello che rifornisce Ungheria e Slovacchia – evitano accuratamente il tratto diretto in Polonia, fedele alleata atlantica. Se si trattasse di sabotaggio, come sempre più osservatori ipotizzano, allora questi atti non sarebbero indirizzati soltanto contro la Russia – che ne soffre solo marginalmente – ma contro l’Europa, che perde ogni residuo di autonomia energetica e politica. La linea di frattura è sempre la stessa: punire i Paesi europei che tentano una politica energetica autonoma, colpire chi ancora mantiene legami con Mosca, costringere tutti gli altri a riallinearsi sotto il controllo di Washington.
A consolidare questa ipotesi, c’è come osserva Gianandrea Gaiani, quella che potremmo chiamare la “Dottrina Tusk-Sikorski”, dal nome del primo ministro e del ministro degli Esteri polacchi, che hanno di fatto sdoganato la legittimità degli attacchi terroristici a infrastrutture che rappresentino anche indirettamente interessi russi in Europa. Parafrasando il loro pensiero, infatti, sabotare infrastrutture legate alla Russia non sarebbe un crimine, ma un atto legittimo di difesa. Una teoria che giustifica atti di terrorismo sul suolo europeo, purché abbiano come bersaglio interessi russi – anche se quei bersagli coincidono con infrastrutture strategiche di Paesi dell’Unione. Sono esplicative, in questo senso, le dichiarazioni del premier polacco Donald Tusk: «Il problema con Nord Stream 2 non è che sia stato fatto saltare in aria. Il problema è che è stato costruito». Varsavia, che già nel 2022 aveva celebrato tramite un tweet di Radoslaw Sikorski, poi cancellato, la distruzione del Nord Stream con un eloquente «Grazie USA!», oggi legittima di fatto nuovi attentati. Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri polacco ha pubblicamente incoraggiato gli ucraini a distruggere l’oleodotto Druzhba, esprimendo in un post su X la speranza che il comandante delle forze di sistema senza pilota delle Forze armate ucraine, Robert Brovdi, disabilitasse l’oleodotto Druzhba, dopodiché l’Ungheria avrebbe ricevuto petrolio via Croazia. Il messaggio è chiaro: colpire raffinerie, oleodotti o gasdotti legati agli interessi russi non solo è tollerabile, ma auspicabile. Una posizione che apre la porta a ogni arbitrio e mette l’Europa su un crinale pericoloso, dove la sicurezza energetica diventa strumento di guerra politica.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il vero intento delle sanzioni contro il petrolio russo è ridisegnare il continente e produrre un vantaggio economico per il petrolio USA. Non a caso, l’energia in Europa costa tre volte e mezzo più che negli Stati Uniti, le industrie chiudono o delocalizzano e la dipendenza dal gas e dal petrolio “alleato” cresce ogni giorno. Le raffinerie esplose non sono semplici infrastrutture danneggiate, ma simboli di un equilibrio che si vuole distruggere. Se le esplosioni in Romania, Ungheria e Slovacchia non sono state accidentali ma frutto di sabotaggio, vanno annoverate nella stessa categoria degli attentati ai gasdotti Nord Stream e vanno intese come tentativi di riorientare gli equilibri del continente attraverso una ridefinizione delle sue politiche energetiche: ridurre l’influenza dei Paesi fondatori, a cominciare dalla Germania – un tempo collegata direttamente alla Russia tramite il Nord Stream – e aumentare, invece, il peso dei Paesi di più recente adesione, quelli più strettamente legati agli Stati Uniti. In questa guerra energetica senza dichiarazioni né fronti ufficiali, l’Europa rischia di restare non un attore, ma il campo di battaglia.