Ogni società va a tavola, consuma rapido, semplice cibo in – quasi – solitudine oppure si raduna per feste e libagioni senza limite, fissa norme per la scelta e il consumo degli alimenti e nello stesso tempo condanna tonnellate di cibo alla grande distruzione dopo averle consegnate alla grande distribuzione.
C’è chi fa la fila per un piatto di pasta, c’è chi festeggia con giusta allegria in gastronomiche feste di paese, c’è chi allestisce tavoli nell’ambito di una ritualità rigorosa, c’è chi si affretta a servire e a consumare veloci pasti nelle pause delle attività di lavoro. C’è chi attende ospiti sconosciuti preparando un coperto in più per un eventuale pellegrino, c’è chi sistema accuratamente le sale del suo ristorante augurandosi che i posti vengano esauriti. C’è chi mangia camminando, c’è chi sgranocchia qualcosa in una sala d’attesa.
Dovremmo davvero accedere al mondo del cibo, alle realtà della alimentazione, agli orizzonti del gusto con una speciale attitudine, sapendo saggiamente mescolare la routine alla sorpresa, la varietà disponibile alla limitatezza delle scelte, la fastosità alla semplicità, la tradizione alla innovazione, proprio perché il cibo è linguaggio e bisogna attendersi frasi banali, perfino sconcertanti, ma anche momenti magici di poesia dove la fantasia vuole una sua estetica e un suo appagamento. E sapere ricavare piacere, conoscenza, stupore, sensazioni da una vasta gamma di esperienze.
Il piatto – ha scritto una psicanalista francese (G. Harrus-Révidi, Psicanalisi del goloso, trad.it. Editori Riuniti 1998) – “funziona da territorio esclusivo di ciascuno, trasformandosi in spazio simbolico privilegiato… Il piatto contiene il pezzo di mondo che ci è riservato. Rappresenta materialmente la nostra possibilità di sopravvivere perché l’oscura angoscia della mancanza, contrariamente alle apparenze della nostra civiltà consumistica, permane nel fantasma arcaico”. E Gaston Bachelard, nei suoi lavori sul simbolismo, aveva sostenuto che la conquista del superfluo provoca una eccitazione spirituale superiore a quella della conquista del necessario.
La mancanza e il sovrappiù, dunque, la privazione e l’eccesso, come in una relazione sentimentale, come nella proiezione di un desiderio. Il cibo rappresenta una concreta metafora del percepire, elaborare, assimilare, del mordere e poi ingoiare bocconi fisici, sociali, mentali, reali e virtuali, come ha scritto genialmente Frederick Perls ottant’anni fa (Io, la fame, l’aggressività, trad. it. Franco Angeli 1995), perché insomma il metabolismo in senso lato è coinvolto in qualsiasi esperienza.
In effetti la modernità, e l’economia capitalistica, lavorando sulla tensione e la pulsione verso il superfluo, l’eccessivo, hanno fatto mettere in secondo piano gli elementi antropologici, etnografici legati al cibo, neutralizzandoli con una serie di prescrizioni e omologazioni, per ridurre poi il futuribile a scene fantascientifiche, prive di vera sensorialità e soggettività.
Le questioni sociali sono tuttavia ancora ben presenti. I pitocchi e i mendicanti dei secoli medioevali sono in effetti ritornati, i “birbanti affamati”, i “geniali furfanti” che popolavano le strade nel Quattro e Cinquecento, e che Piero Camporesi ha fatto rivivere nei suoi splendidi libri, sono stati e sono all’ordine del giorno, manipolati anche dalla malavita organizzata, ma anche i reali orizzonti della fame si sono moltiplicati, le necessità essenziali, di base premono fortemente, rendono quasi incomprensibile un panorama – quello del cibo – pieno di travolgenti contraddizioni.
La scarsità, anche se non proprio la carestia, ha centrato in pieno la nostra storia simbolica nazionale: sognare una bistecca, assaltare un deposito di pasta, vincere un pollo sono episodi del nostro cinema del dopoguerra (Il bandito, di Alberto Lattuada, 1946; L’onorevole Angelina, di Luigi Zampa, 1947; Miracolo a Milano, di Vittorio De Sica, 1951).
Le antiche metafore pantagrueliche del ventre come centro del mondo hanno senso, ora proprio come allora, in un mondo di realtà opposte e radicalizzate, dove la convivenza di situazioni estreme, di spreco e di carenza, inevitabilmente convivono ma con l’aggravante insanabile dell’ipocrisia mercatistica: quella che celebra l’opulenza della disponibilità nelle grandi superfici della distribuzione, in quegli edifici che hanno assunto la dimensione di luoghi di culto, dove la merce alimentare viene santificata e nello stesso tempo sottratta alla sua dimensione naturale da uno sfoggio di contenitori e allestimenti illusionistici, il tutto prigioniero della data di scadenza, vanificata nel caso dei prodotti freschi, destinati la notte, dopo la chiusura dei punti vendita, a un destino ignoto ai più.
“Un tempo – osserva Fernand Braudel in Capitalismo e civiltà materiale (trad.it. Einaudi) – mangiare e bere non erano soltanto necessità o, al caso, lussi sociali ma veri e propri giochi comunitari, rapporti fra l’uomo e la società, fra l’uomo e il mondo materiale, fra l’uomo e l’universo soprannaturale”. Ma nulla è cambiato, se pensiamo che il mondo soprannaturale, nel campo del cibo, è rappresentato oggi, ad esempio, dall’Olimpo di certi chef che si sentono depositari di un ruolo sacrale e sviluppano una esasperata ricerca di perfezione. Esistono fortunatamente anche molti professionisti che si impegnano sia nel recupero delle tradizioni e del ruolo immaginario e nostalgico del cibo, sia nelle combinazioni creative di gusti fino ad ora lontani, anche inconciliabili, costruendo destini gustativi che formano vere e proprie narrazioni, storie di produzione e lavorazione che vogliono rispettare determinati, espliciti criteri di affidabilità. E che rendono l’esperienza del pranzare una avventura sensoriale, una esplorazione estetica, narrativa, “il solo modo di viaggiare che abbia senso oggigiorno”, ha scritto Italo Calvino.
Pellegrino Artusi, autore di quel ricettario capolavoro che è La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene (1891-1909), opera fondamentale per comprendere attraverso le realtà culinarie regionali lo spirito alimentare italiano – e anche la nostra unità nazionale costruita su divergenze e convergenze – scriveva che “la cucina è una bricconcella; spesso e volentieri fa disperare, ma dà anche piacere, perché quelle volte che riuscite o che avete superata una difficoltà, provate compiacimento e cantate vittoria”. Si intravede in queste parole d’altri tempi uno spunto sentimentale, quello che aveva fatto dire a Brillat- Savarin, nella sua Fisiologia del gusto (1825), che la gastronomia “governa la vita intera”, così da mettere seriamente in discussione qualsiasi distinzione tra alimentazione e gastronomia, tra ambito della necessità e ambito della scelta, tra bisogno e piacere. I comportamenti a tavola, a loro volta, mostrano una enorme varietà di stili, di atteggiamenti e riflettono condizioni psicologiche molto differenti, in rapporto sia alle circostanze sia alla personalità dei soggetti coinvolti.
Si presenta dunque una complessità, una vastità di problemi e orizzonti parlando del cibo, dalle tavolate sontuose, con connesse prescrizioni di etichetta, alla rumorosa ristorazione on the road, dalle abbuffate ai digiuni, prescritti da norme religiose (e dunque espressione del rapporto tra ciò che è naturale e ciò che è trascendente), oppure dettati, come forme di protesta, dalla necessità di attirare l’attenzione.
C’è stato poi, e c’è, un vero e proprio regime filosofico nell’affrontare il tema. Nella Retorica di Aristotele un tale chiedeva al fornaio come utilizzasse la pasta per l’impasto, se dura o molle. E Aristotele paragona ciò al modo della argomentazione mediante parole: né troppo rapida, perché l’impasto non avrebbe tempo di sfibrarsi, né troppo tirata per le lunghe, come una sfoglia che rischia di lacerarsi: quel che va bene non risiede nel veloce o nel lento ma nel giusto mezzo. Si tratta dunque di “cucinare parole” (F. Rigotti, La filosofia in cucina, Il Mulino 1999), non soltanto nell’arte della retorica ma nella vita di tutti i giorni, dando ancora una volta al cibo uno straordinario potere metaforico.Apprezzabile, però, questo potere su differenti piani, superficiali e profondi, gustativi e affettivi, psicologici e politici, realistici e utopistici.
La cucina del senso, e dei sensi, non ha quattro pareti, guarda tutt’intorno a sé, non ha un soffitto che la limiti e la soffochi, i suoi profumi devono invadere ogni contrada, forse ha un pavimento esteso come il mondo intero, oltrepassa i condizionamenti economici e le restrizioni oggettive, sa parlare alle profondità dell’essere, all’inconscio e al palato, ha bisogno continuamente di ospiti per darsi una ragione di vita, reclama che tutti possano accedervi, ma non soltanto a ciò che è essenziale, per non morire, ma a una qualche forma di dismisura, di sproporzione.
La cucina del senso rifiuta una programmazione da remoto, sa mettere in difficoltà quei soggetti politici ed economici che vorrebbero preordinare tutto, forzando i vari destini per produrne uno solo indiscutibile. Ama le materie prime, e la loro qualità, come scriveva lo stesso Artusi, le materie prime, sì, quelle che sono anche sostanze di un vivere e di un pensare, libero, aperto e responsabile. E soprattutto derivanti da modi di produzione accettabili e non dannosi. Il cibo si prepara per se stessi ma anche per gli altri, è attorniato da responsabilità, e bisogna essere capaci di accettare qualsiasi risposta, essere pronti a spiegarsi.
“La schizofrenia antica fra privazioni e sperperi, fra oculata parsimonia e follie liberatorie è evidentemente incompatibile con la nuova situazione. L’irresistibile attrazione dell’eccesso… ha cominciato a colpirci… Ed ecco farsi strada un’inedita forma di paura che ribalta l’atavica paura della fame”. La psicologia degli individui, il loro modo di pensarsi vengono aggrediti. A proposito della “fear of obesity“, paura della obesità, come l’hanno battezzata gli americani, “le inchieste dimostrano che oltre la metà delle persone che si mettono a dieta ritenendosi sovrappeso non lo sono affatto” (M. Montanari, La fame e l’abbondanza, Laterza 1997, p. 212).
Forse fa parte della globalizzazione consumare cibo senza orario, ingurgitare continuamente qualcosa: cibo, parole, immagini, condizionamenti, suggestioni, prescrizioni mediante tivù e social, subire l’esempio di corpi diafani nei media e di passanti fuori peso nella realtà.
La democrazia non ci avrebbe dovuto insegnare ad accettare le differenze? Ma anche il cibo rivela che c’è un’altra democrazia, quella della fame e insieme dello spreco, senza alternative.
[di Gian Paolo Caprettini – semiologo, critico televisivo, accademico]



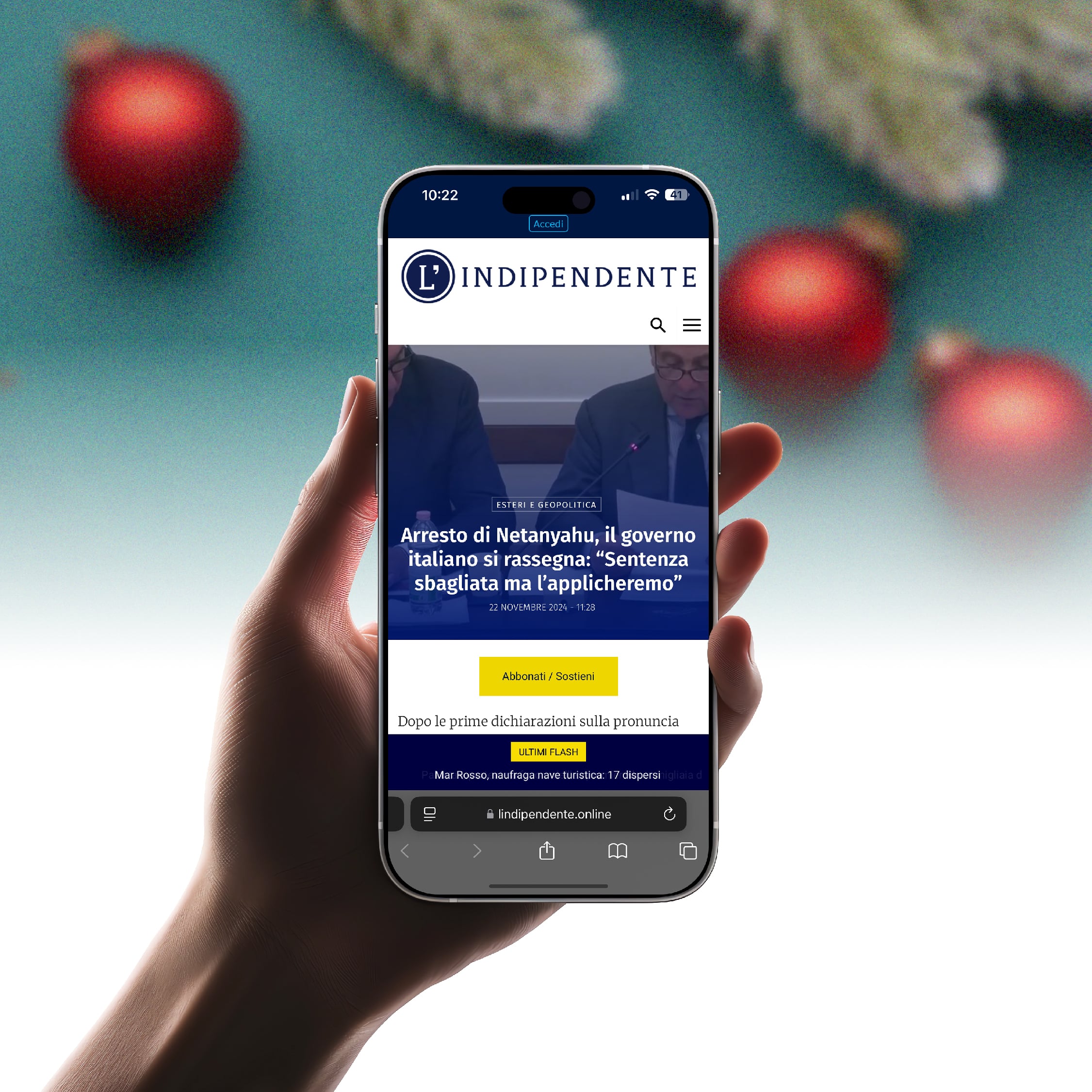

Certo che la foto solita con il bambino nero e di quello bianco di fianco che vuol dare la parvenza del viziato potevate risparmiarvela. O volete anche voi perseguire la cosiddetta propaganda white guilt (colpa dei bianchi)? Io dico basta avete stancato qualunque sia.