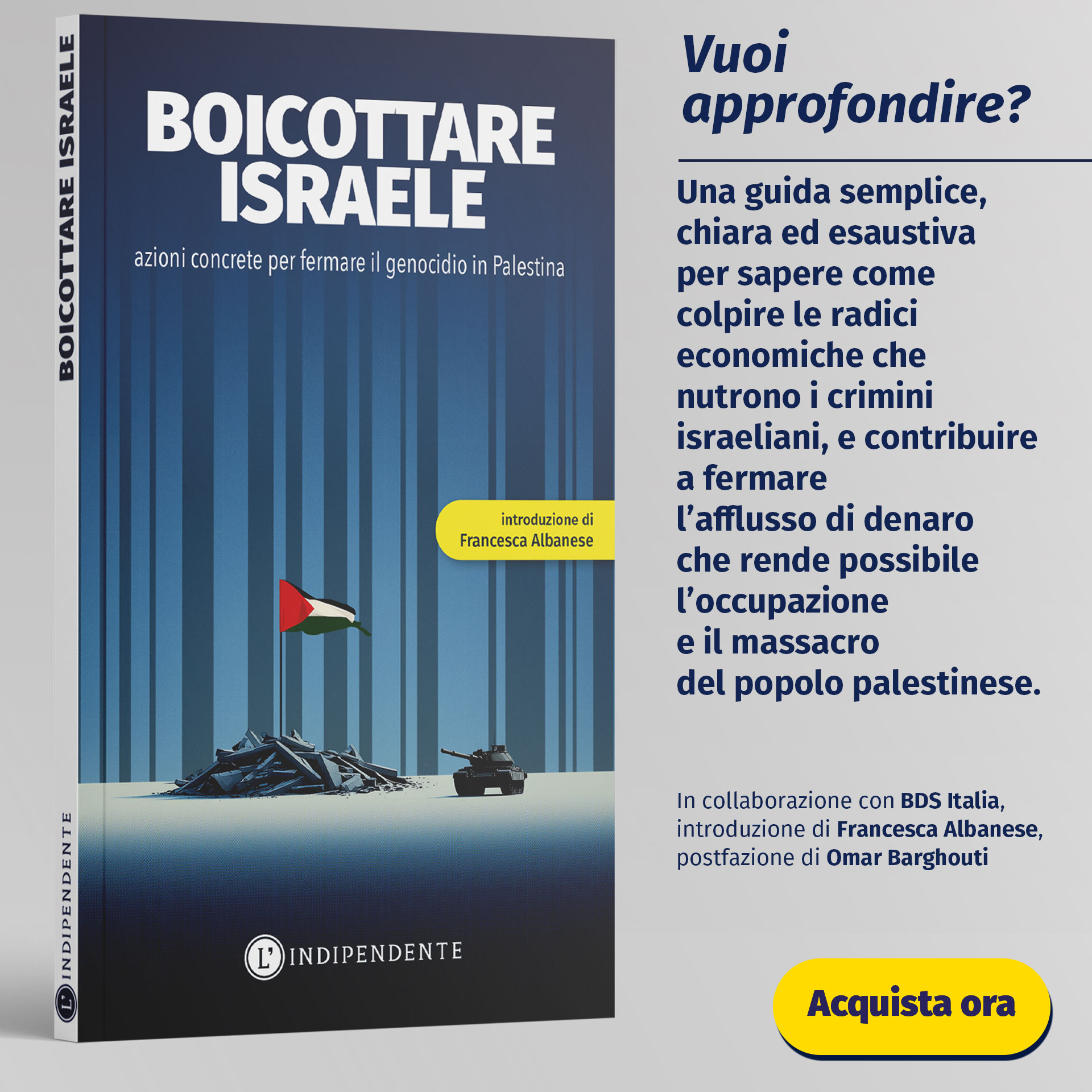Al termine della seduta del Consiglio dei Ministri, svoltosi nella serata di martedì 22 luglio, il governo ha annunciato un nuovo pacchetto di misure volto a rendere più efficiente la gestione delle carceri e risolvere l’annoso problema del sovraffollamento. I piani sono, in particolare, di costruire nuovi edifici destinati a ospitare i detenuti, oltre ad ampliare quelli già esistenti, velocizzare le procedure di scarcerazione anticipata e «offrire concrete possibilità di riabilitazione ai detenuti con dipendenza da stupefacenti o da alcol». A fronte del tasso di sovraffollamento medio superiore al 130% (che in alcuni istituti arriva a sfiorare il 200%), l’esecutivo propone dunque misure emergenziali che, secondo le associazioni di tutela dei diritti dei detenuti, si riveleranno presto inefficienti – come successo ogni volta che si è proposta l’edilizia come soluzione all’emergenza carceraria.
In particolare, il governo ha approvato un ddl che introduce disposizioni per disporre la detenzione in strutture socio-sanitarie residenziali per il recupero dei detenuti tossicodipendenti cui rimangano da scontare non più di 8 anni di pena (4 nel caso di reati con pericolosità sociale). Si tratta di realtà che esistono già nel sistema attuale, motivo per il quale l’annuncio del governo ha suscitato perplessità in merito alla natura delle nuove strutture e il timore che, nei piani dell’esecutivo, vi sia quello di delegare la problematica a istituti privati (in maniera analoga a quanto già accade con i Centri di Permanenza e Rimpatrio).
Su proposta del ministro della Giustizia Nordio, inoltre, sono state approvate modifiche al decreto presidenziale n.230 del 30 giugno 2000, con l’introduzione di procedure più rapide per ottenere la scarcerazione anticipata e aumentare il numero di colloqui telefonici settimanali e mensili. Per il biennio 2025-2027 sono inoltre previsti lavori di edilizia penitenziaria, con interventi finalizzati alla costruzione di nuove strutture e al recupero di quelle esistenti, con l’obiettivo di «aumentare la capienza complessiva del sistema penitenziario». Sono 60, in tutto, gli interventi in programma: 3 sono già conclusi, 27 sono in corso e altri 30 sarebbero «prossimi all’avvio». In questo modo, secondo l’esecutivo, in due anni saranno creati 3.716 nuovi posti grazie agli ampliamenti, mentre altri 5.980 si otterranno grazie alle ristrutturazioni e alla manutenzione, per un totale di 9.696 posti.
L’investimento complessivo, fa sapere Meloni, è di oltre 750 milioni di euro. «Stiamo lavorando per aggiungere altri 5 mila posti, in modo da poter colmare il divario esistente tra le presenze e i posti disponibili. In passato si adeguavano i reati al numero di posti disponibili nelle carceri, noi invece riteniamo che uno Stato giusto debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena». Un ragionamento perfettamente in linea con la logica di questo esecutivo, il quale, con provvedimenti quali il decreto Cutro o il decreto Sicurezza, ha enormemente aumentato il numero di reati per i quali è prevista la pena detentiva, oltre che aggravato le pene per molti di quelli già esistenti. Per Meloni questo significa garantire, «finalmente, la certezza della pena». In parallelo è previsto un piano per aumentare gli agenti di polizia penitenziaria, con l’obiettivo di prevedere ulteriori mille assunzioni con la prossima legge di bilancio.
In Italia sono 190 gli istituti penitenziari esistenti, per un totale di 51.300 posti disponibili. Tuttavia, i detenuti presenti, al 30 giugno 2025, ammontano a 62.728. A questi, specifica l’associazione per i diritti dei detenuti Antigone nel suo ultimo rapporto, vanno aggiunti gli oltre 4 mila posti non disponibili, che portano a circa 16 mila i detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare delle carceri – con un tasso di sovraffollamento medio pari ad oltre il 130%. Di questi, solamente 47.302 stanno scontando una condanna definitiva, mentre sono sono 9.307 (il 15%) le persone sottoposte a misura cautelare preventiva in carcere (e quindi ancora in attesa del primo giudizio), mentre altre 5.776 sono in attesa di una condanna definitiva. Un terzo del totale (21.490) si trova in carcere per reati legati alla droga.
In questo contesto, nel 2024, 91 persone si sono tolte la vita in carcere, il dato peggiore di sempre, mentre nel 2025 i suicidi ammonterebbero già a 44. Un ultimo dato da tenere in considerazione è quello per il quale, nel 2024, il tasso di recidiva era al 60%: per oltre la metà dei detenuti, insomma, il sistema carcerario si è dimostrato fallimentare nel suo proposito di rieducazione e reinserimento in società.
Secondo il parere di Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione per i diritti dei detenuti Antigone, rivolgersi all’edilizia per risolvere i problemi delle carceri è un escamotage di lunga data, che rischia di «aggravare la situazione del sistema penitenziario». Dall’insediamento del governo Meloni, il numero dei detenuti è cresciuto rapidamente (sono 5 mila in più negli ultimi tre anni): se tale tendenza rimane costante, è prevedibile che, nel 2027, il numero dei posti eventualmente creati sia insufficiente. «Molti dei nuovi posti poi saranno in container, strutture totalmente inadeguate ad ospitare persone detenute anche per lunghi periodi. Generalmente queste vengono utilizzate per affrontare emergenze e non come soluzioni definitive, come invece sembra ovvio nel piano carceri del governo. Piano carceri che, peraltro, non fornisce alcuna informazione sul personale che sarà necessario a gestire le nuove strutture, quando già oggi si registra un drammatico sotto-organico in tutti i ruoli: direttori, educatori, poliziotti, medici, psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali, personale amministrativo», specifica Gonnella, che critica anche la mancanza di chiarezza sul funzionamento della detenzione differenziata per detenuti tossicodipendenti. «Il governo è interessato agli istituti di pena solo in termini edilizi e di custodia di corpi, senza alcuna visione moderna e umana della pena», conclude Gonnella.
Ricorrere all’edilizia penitenziaria, come sottolinea la stessa Antigone, è una soluzione di tipo emergenziale che, dal 2000 in poi, si è rivelata fallimentare proprio per via della rapida saturazione dei nuovi posti. Anche la Corte dei Conti ha criticato questa strategia, sottolineando come, a fronte dell’ingente consumo di risorse finanziarie, non vi siano miglioramenti nella vita dei detenuti proprio a causa del rapido esaurirsi dei posti disponibili.