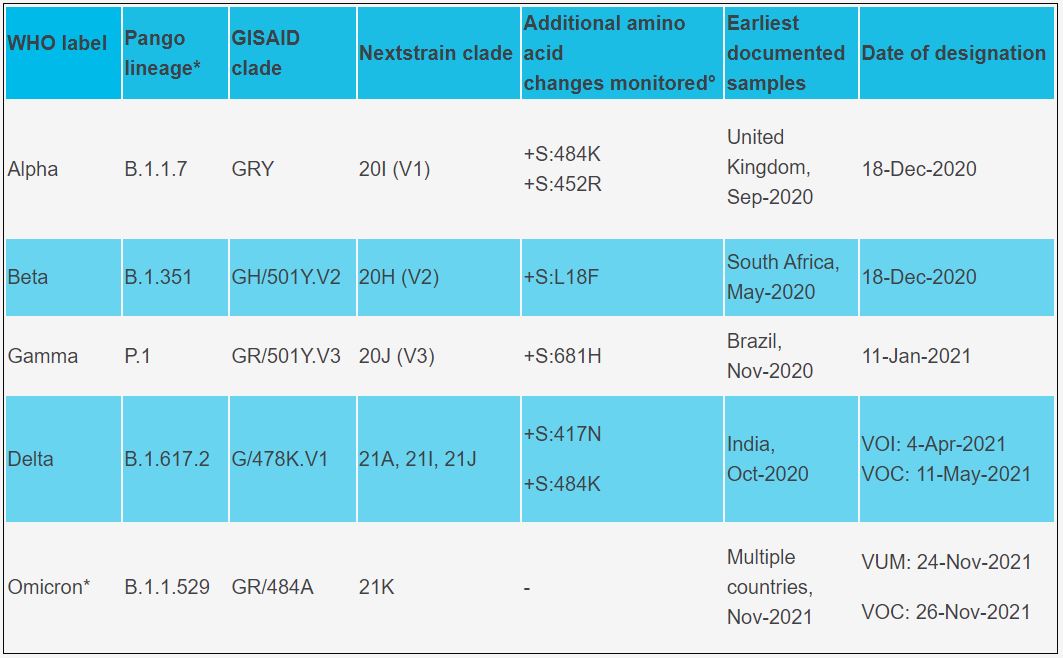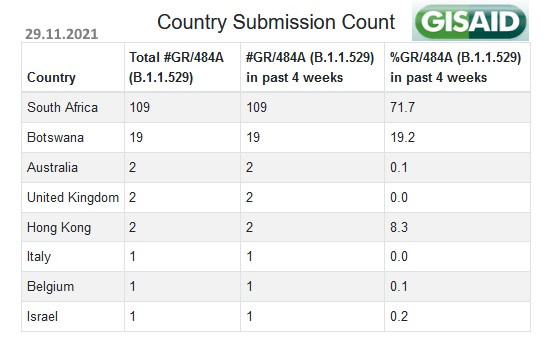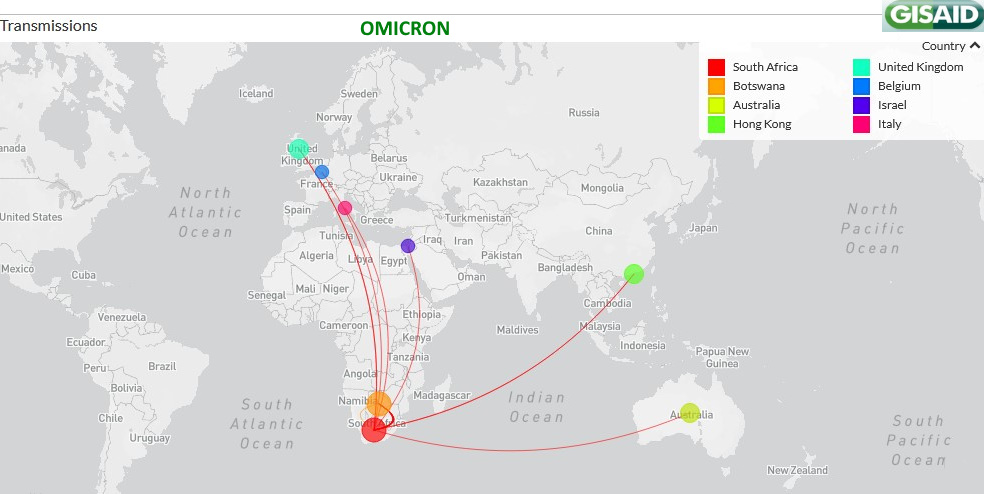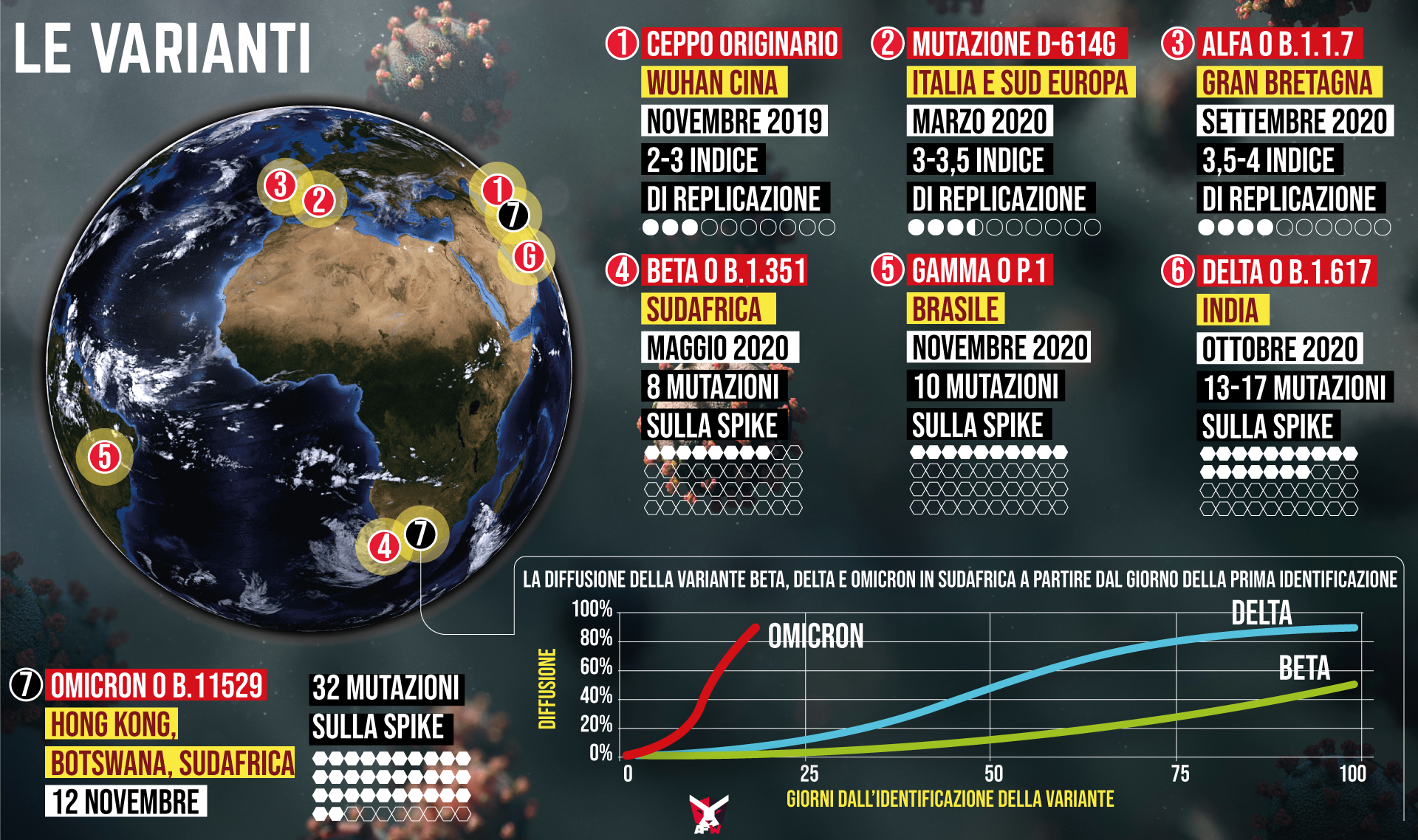Il Thanksgiving, o Giorno del Ringraziamento, è una festività statunitense che viene celebrata ogni anno l’ultimo giovedì di novembre: i festeggiamenti di giovedì scorso sono stati occasione per riaccendere il dibattito sulla storia della società statunitense, scritta – come sempre – dai vincitori, da parte di coloro che sono i vinti della colonizzazione del Nord America. Diversi media hanno accostato in questi giorni, in maniera molto sbrigativa e superficiale, questo movimento di decolonizzazione del pensiero, dell’immaginario e dei costumi, soprattutto in atto tra le comunità tribali indigene, alla così detta cancel culture (o call-out culture).
La cancel culture è nata a partire dal 2014 ma ha avuto un esponenziale espansione tre anni più tardi con l’esplosione del movimento MeToo che riunisce moltissime donne che denunciano casi di violenze e abusi sessuali subite da parte di uomini molto spesso famosi. La cancellazione avviene tramite una campagna di ostracismo mediatico che mette alla gogna pubblica personaggi celebri che hanno approfittato della loro posizione di potere per mettere in atto comportamenti inappropriati o veri e propri abusi sessuali. Il movimento, sotto l’effetto mediatico, si è poi ingrandito fino a toccare ogni strato sociale, specie negli USA, in Canada e nel mondo Occidentale.
Quindi, niente a che vedere con i movimenti di sovranità culturale, politica e sociale che i popoli nativi del continente Nordamericano portano avanti da un secolo a questa parte, ovvero da quando – nel 1924 – sono stati ammessi alla società statunitense come cittadinanza di seconda classe. Il “movimentismo indiano” è la lotta per la difesa di diritti umani, politici e sociali che sono calpestati da cinquecento anni da parte del colonialismo di matrice europea. Risulta essere la risposta alla deportazione, al massacro e allo sterminio, al concentramento, all’assimilazione e alla cooptazione forzosa all’interno della società statunitense, fin dalle sue origini: sotto la forma della Repubblica, i coloni hanno imposto l’Impero della Libertà e dell’universale a coloro che ancora vivevano liberi la loro comunità particolare al di là dei monti Appalachi.
La decolonizzazione dal pensiero Occidentale in favore della riscoperta dei valori tradizionali, della propria spiritualità e del proprio linguaggio, sono da sempre alla base di ogni movimento e organizzazione sociale di comunità indigene che lottano per la sopravvivenza della propria identità e cultura, e non sono certo un’apparizione nuova che fa comodo strumentalizzare a favore di una o l’altra parte politica. Non è quindi “da ieri” che tali movimenti si battono, anche con l’utilizzo delle armi. Ne è un esempio l’American Indian Movement, nato nel 1968 a Minneapolis, che nel 1973 mise in essere la rivolta di Wounded Knee in cui, sotto l’assedio dell’FBI e delle forze speciali, occupò il luogo per quasi tre mesi dichiarando l’indipendenza e la sovranità della comunità locale: Wounded Knee è il luogo in cui, nel 1890, avvenne l’ultimo grande massacro (a danno delle popolazioni delle praterie) che pose fine ad ogni speranza di “resistenza indiana”.
E se il “Giorno del ringraziamento” fosse conosciuto fin dai primordi, si capirebbe semplicemente che non vi è alcun bisogno di cancellare niente. Anche perché, anche qualora così fosse, come si possono realmente cancellare cinquecento anni di storia e di sofferenza? Ciò che i movimenti sociali indigeni vogliono è una onesta narrazione degli eventi storici.
Se molti dicono che il Thanksgiving è il giorno in cui si ringrazia Dio per i suoi abbondanti doni della terra, e certamente lo sarà, è senz’altro vero che la sua istituzione da parte dei Padri Pellegrini ebbe una precisa motivazione e il suo carattere risulta essere molto più terreno, umano. I Pilgrim Fathers arrivarono sulle coste dell’attuale Massachussetts, ove fondarono la cittadina di Plymouth, portando con sé i semi per coltivare il cibo ma che si rivelarono inadatti alle condizioni climatiche del territorio in cui si erano insediati. Ben presto, i coloni si trovarono a dover affrontare una terribile mancanza di cibo a cui cercarono di sopperire con furti alle scorte di cibo delle tribù locali che certamente non gradivano la cosa. Massasoit, uno dei leader della nazione Wampanoag, cercò di mantenere relazioni pacifiche e decise di aiutare le persone venute da ciò che chiamavano “la grande acqua” per far sì che potessero vivere del loro lavoro e in armonia con le altre popolazioni. Massasoit fece dono ai Padri Pellegrini di semi di zucca, mais e di altri prodotti coltivabili in quel territorio. Fu solo così che i Padri Pellegrini poterono procurarsi il cibo che gli avrebbe fatto superare il secondo inverno. L’aiuto dei Wampanoag fu salvifico e permise di sopravvivere a quanti erano riusciti a superare la precedente stagione fredda. Per tale motivo, il Thanksgiving venne celebrato la prima volta nel 1621 insieme alla tribù Wampanoag, con una tavola colma delle verdure coltivate nell’estate dai Pilgrim Fathers e la carne di cervo portata in dono da coloro che gli avevano insegnato cosa e come coltivare in quella terra.
La celebrazione sarà però unica e mai più si ripeterà poiché col passare del tempo i legami si deteriorarono a tal punto che nel 1636 scoppiò la guerra Pequot (1836-1838). Durante il conflitto, dopo l’uccisione di un uomo che i coloni hanno creduto fosse stato ammazzato dai Wampanoag, per rappresaglia, un villaggio venne distrutto e bruciato e 500 tra uomini, donne e bambini morirono. Sul finire della guerra, William Bradford, governatore di Plymouth, scrisse che per «i successivi 100 anni, ogni Giorno del Ringraziamento ordinato da un governatore era in onore della sanguinosa vittoria, ringraziando Dio che la battaglia era stata vinta».
[di Michele Manfrin]