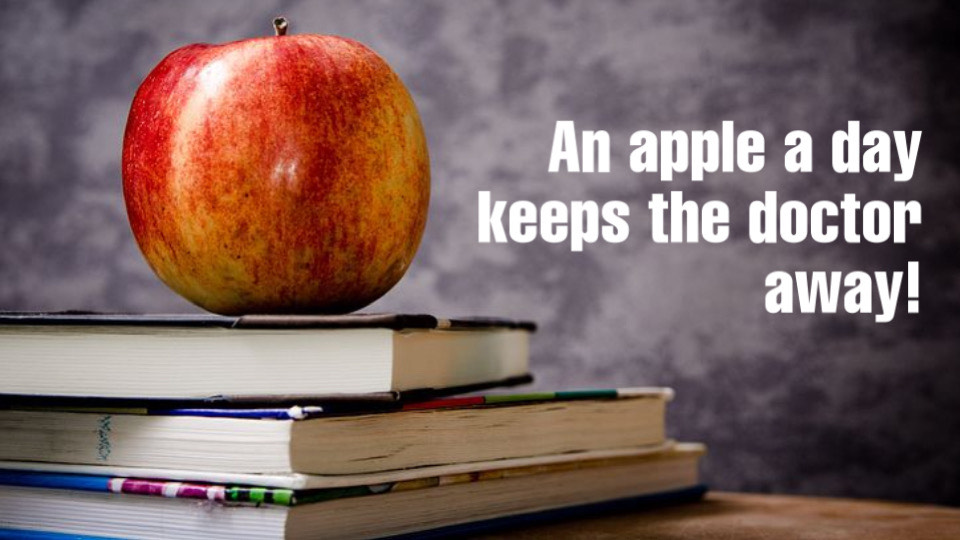A dispetto della varietà di cibi che si trovano sui banchi del reparto ortofrutta del supermercato, varietà che però è sinonimo di cibo industriale e di processi produttivi a forte impatto ambientale, ciò a cui in realtà bisognerebbe puntare e poi trasmettere alle nuove generazioni a livello di educazione alimentare è l’importanza di mangiare il cibo di stagione, in quanto è questo il comportamento alimentare più rispettoso per l’Ambiente. Per una serie di motivi, in primis quelli riguardanti la tutela degli ecosistemi. Vediamo insieme alcune buone motivazioni per mangiare più cibo di stagione e meno cibi industriali:
- Più nutrienti. Le piante che seguono il loro ciclo stagionale presentano una quantità maggiore di nutrienti e principi attivi e apportano la giusta quantità di calorie in relazione al periodo dell’anno. Questo significa che le proprietà nutrizionali di un determinato alimento, se è coltivato fuori dalla sua stagione abituale, potrebbero risultare “falsate” e quindi esserci meno utili. Facciamo 2 esempi per capirci: la stagione naturale di crescita dei pomodori è l’estate, non a caso questo frutto è ricchissimo di vitamina C e di un antiossidante chiamato licopene, entrambe sostanze fortemente protettive per la retina e per la pelle in generale contro le radiazioni solari che in estate sono più forti e aggressive nei nostri confronti. In Inverno invece maturano i cavoli, che hanno alti livelli di vitamina C e di sostanze di rinforzo del sistema immunitario, necessarie per il naturale calo delle difese immunitarie che si verifica nella stagione del clima più freddo. Tutto ciò non è un caso, ma una sagace opera della Natura che mira a mantenere le cose in equilibrio. Ecco che mangiare pomodori in inverno al posto di cavolfiore e broccoli non è una buona idea, come non lo sarebbe mangiare questi ultimi in estate al posto del pomodoro, melanzane e altri ortaggi estivi.
- Pochi o zero pesticidi. Questo è vero, in particolar modo, per gli ortaggi biologici e biodinamici. Anche quelli non bio, tuttavia, se sono di stagione richiedono una quantità nettamente inferiore di prodotti chimici per eliminare i parassiti. Le piante che vengono “costrette” a crescere in periodi diversi dalla loro normale stagione, infatti, risultano indebolite e sono più facilmente preda di insetti indesiderati, necessitando dunque di trattamenti chimici aggiuntivi.
- Costa meno. Dato che gli ortaggi di stagione non hanno bisogno di serre, non si consuma energia aggiuntiva per farli crescere e maturare: sfruttano già quella del sole. Se poi scegliamo prodotti a km zero, coltivati cioè vicino al luogo di residenza, il risparmio è ancora maggiore, perché abbatteremo anche i costi di trasporto.
- Più gusto. I prodotti di stagione sono più buoni, profumati, aromatici. Avete fatto caso al sapore di un pomodoro in inverno? Praticamente non ha sapore e si è costretti ad esagerare coi condimenti.
- Più rispetto per la Terra. I peperoni o le zucchine a dicembre hanno un costo ambientale elevatissimo: per farli crescere servono grandi serre riscaldate e illuminate che richiedono molta energia, spesso proveniente da combustibili fossili (petrolio). Anche i pesticidi e fertilizzanti utilizzati per i cibi fuori stagione sono di sintesi, quindi derivati dal petrolio. Gli ortaggi fuori stagione, dunque, risultano molto inquinanti. Se poi provengono da altri Stati lontani e aggiungiamo il costo ambientale dei trasporti (su strada o aerei), ecco che risultano ancora più inquinanti! Tutto ciò significa anidride carbonica che si va ad aggiungere a quella già presente in atmosfera, incrementando l’effetto serra e peggiorando la situazione globale.
Perché supportare, da consumatori, un sistema produttivo distruttivo dell’Ambiente e della vita, anziché uno che sia favorevole alla vita stessa e che sia biologico?
Qui sotto in foto, potete memorizzare tutta la frutta e verdura di stagione in Dicembre. Acquistate e mangiate solo questi vegetali in questo mese, ci sarà un guadagno in salute e nel rispetto dell’ecologia!

Un frutto di stagione eccezionale: la mela
La mela è un frutto straordinario dalle tante proprietà nutrizionali ed è considerato dagli studiosi un farmaco naturale. A titolo di curiosità si sappia che attualmente i ricercatori hanno individuato all’interno delle mele circa 170 molecole chimiche differenti, ma non sono ancora riusciti a descrivere con esattezza le caratteristiche di tutte e 170 queste molecole chimiche, cioè a capire l’effetto chimico di ognuna di esse.
Sappiamo che le mele contengono vitamina C, acido malico e molte altre molecole ormai note, ma non si conoscono ancora tutte le sostanze presenti all’interno del frutto e il loro ruolo a livello nutrizionale nel nostro organismo. Probabilmente sono tutte sostanze benefiche per la nostra salute, la ricerca riuscirà a studiarle e comprenderle appieno solo nel tempo.
Per adesso, possiamo essere certi che il detto “una mela al giorno leva il medico di torno” non è assolutamente farlocco bensì alquanto veritiero da un punto di vista scientifico. Infatti, proprio uno studio recente del 2013 che arriva dall’università di Xi’an in Cina e pubblicato sulla banca dati ufficiale delle ricerche scientifiche Pubmed, indica la sperimentazione da parte dei medici di alcune delle sostanze contenute nella mela nella cura di un carcinoma umano del colon (tumore dell’intestino) e con grande sorpresa i risultati hanno mostrato che gli oligosaccaridi delle mele sono stati in grado di uccidere più cellule cancerogene del miglior farmaco chemioterapico conosciuto contro il tumore del colon. Gli oligosaccaridi sono delle fibre particolari contenute nelle mele che sono sostanze chimiche più complesse rispetto al fruttosio (monosaccaride) o al saccarosio (disaccaride). In pratica stiamo parlando delle fibre solubili della mela, come la famosa pectina.
L’esperimento scientifico sul tumore al colon
L’esperimento è stato fatto in vitro (che significa: in laboratorio) e l’interesse è altissimo in quanto se l’effetto fosse replicato anche in vivo (che significa: negli animali o sull’uomo) la scoperta porterebbe a delle conseguenze positive di enorme importanza nella cura del tumore al colon, dal momento che gli oligosaccaridi sono molecole biologiche naturali che l’organismo umano recepisce in maniera indolore e processa in maniera biocompatibile, al contrario del farmaco chemioterapico, il quale viene recepito sempre malissimo dall’organismo e spesso scatena reazioni collaterali tossiche nel paziente.
Gli oligosaccaridi di mele hanno ucciso fino al 46 per cento delle cellule del cancro del colon umano in vitro e superato il farmaco chemioterapico più comunemente usato. A soli 0,9 microgrammi per mL (circa 0,9 PPM), gli oligosaccaridi hanno ucciso il 17,6 per cento delle cellule del cancro dopo 36 ore, mentre il farmaco chemio ha ucciso solo il 10,9 per cento (ad una concentrazione più elevata di 1,3 microgrammi per mL).
Se non vi fidate dei detti antichi dei vostri nonni e antenati, sappiate che esistono svariati importanti studi scientifici che confermano i pregi di questo frutto in termini di salute. Ne citiamo qui ancora un paio.
La prima ricerca è degli anni Duemila ed è stata pubblicata sulla rivista medica Annals of Oncology con il titolo Does an apple a day keep the oncologist away? Un team di ricercatori italiani ha analizzato i dati provenienti da studi caso-controllo condotti tra il 1991 e il 2002 in Italia. Uno studio caso-controllo è utilizzato per identificare i fattori che possono contribuire ad una condizione medica, confrontando soggetti con una certa malattia con un gruppo simile ma privo della patologia. In questo caso si voleva indagare il rapporto tra consumo di mele e cancro e i risultati hanno riscontrato un’associazione inversa coerente tra le mele e il rischio di vari tipi di cancro. Secondo i ricercatori, infatti, molti tumori del tratto digerente in Italia sarebbero associati ad un basso consumo di frutta e verdura.
Infine, lo studio A statin a day keeps the doctor away: comparative proverb assessment modelling study, pubblicato dall’Università di Oxford nel 2013, ha constatato come il consumo giornaliero di mele potrebbe prevenire e contrastare circa 8500 decessi nel Regno Unito, legati a malattie cardiovascolari nelle persone dai 50 anni in su.
Un risultato paragonabile all’uso delle statine, ma certamente con un maggior contributo nutrizionale e senza effetti collaterali.
È importante mangiarle con la buccia
Come molti altri frutti anche le mele andrebbero mangiate con la buccia perché è proprio nella parte più esterna di esse che si racchiudono in maggiore quantità i nutrienti principali. Naturalmente per poter fare questo è preferibile acquistare mele da agricoltura biologica o da aziende che producono con il metodo della lotta integrata, in modo da evitare di assumere insieme alle sostanze benefiche anche pericolosi pesticidi. Quando questo non è possibile, si può almeno in parte risolvere il problema dei pesticidi lavando le mele molto bene con il bicarbonato di sodio.
La mela è uno spuntino sano e con la buccia lo diventa ancor di più per diversi motivi:
- La buccia contiene la maggior parte delle fibre, fondamentali per il benessere e la regolarità del nostro intestino e dei batteri che lo abitano, i quali costituiscono l’esercito più importante di cui è costituito il sistema immunitario. Una mela mangiata con la buccia contiene in media 4,5 grammi di fibra, senza la buccia invece solo 2 grammi.
- La buccia contiene anche la maggior parte delle vitamine. Una mela con la buccia contiene in media 8,4 milligrammi di Vitamina C e 98 Unità Internazionali di vitamina A. Senza, invece, queste vitamine scendono rispettivamente a 6 milligrammi e a 61 UI.
- La buccia delle mele contiene Quercetina, una sostanza antiossidante dalle molte proprietà: allevia i problemi respiratori, protegge la memoria e dagli ultimi studi sembra essere in grado di combattere i danni ai tessuti cerebrali che nel tempo possono portare a sviluppare Alzheimer o altre malattie degenerative.
- Nella buccia delle mele sono contenute delle sostanze considerate antitumorali. Si tratta dei triterpenoidi che secondo uno studio del 2007 condotto dalla Cornell University “inibiscono o uccidono le cellule tumorali in colture di laboratorio” soprattutto quelle che si sviluppano in fegato, colon e seno.
- Via ai chili di troppo. La buccia della mela contiene acido ursolico, composto importante per tenere a bada il peso corporeo. Sembra infatti che questa sostanza sia in grado di aumentare il grasso bruno considerato un “grasso buono” perché permette di bruciare più calorie, riducendo così il rischio obesità.
Sembra proprio vero, quindi, che una mela al giorno (con la buccia) toglie il medico di torno.
[di Giampaolo Usai]