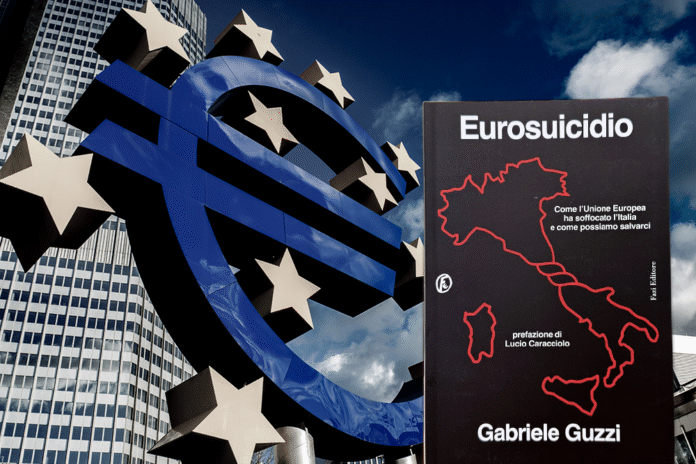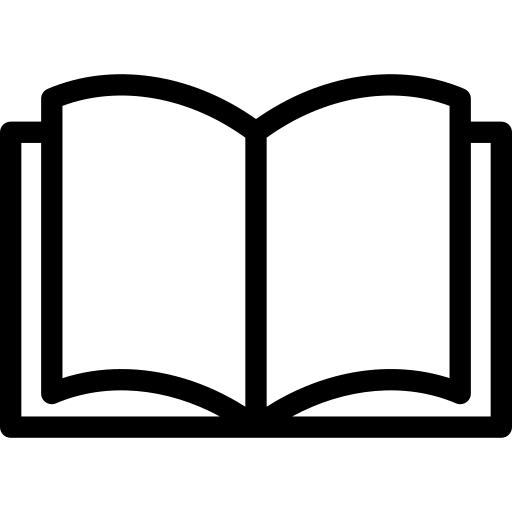Dall’ex premier britannico Tony Blair, al presidente della Banca Mondiale Ajay Banga, passando per l’investitore miliardario americano Marc Rowan, l’immobiliarista israeliano-cipriota Yakir Gabbay e gli immancabili Steve Witkoff, Marco Rubio e Jared Kushner, genero di Trump e CEO di Affinity Partners. Sono alcuni dei nomi scelti dal presidente americano Donald Trump per il “Consiglio Esecutivo fondatore” del Board of Peace di Gaza, l’organismo incaricato di supervisionare il nuovo governo tecnico palestinese, la ricostruzione della Striscia e il percorso di smilitarizzazione. All’ex inviato ONU ed ex ministro degli Esteri bulgaro Nickolay Mladenov, sarà affidato il ruolo di “alto rappresentante” per Gaza. Più che un organo di mediazione, il board si presenta come una cabina di comando del potere economico, dove banchieri e tecnocrati riducono la pace in una pratica amministrativa e Gaza in uno spazio da ridisegnare secondo le logiche dei mercati e delle lobby statunitensi.
I nomi sono stati annunciati mentre in Egitto prende avvio la cosiddetta “Fase 2” dei negoziati tra Israele e Hamas, tramite una lettera di invito che lo stesso Trump ha indirizzato ai leader di oltre 50 Paesi e che è stata resa pubblica su X dal presidente argentino Javier Milei. «È il momento di trasformare i sogni in realtà», si legge nella convocazione. Secondo una nota della Casa Bianca, a ciascun membro sarà affidato un portafoglio «essenziale per la stabilizzazione di Gaza e per il suo successo a lungo termine». Il Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza (NCAG) sarà guidato da Ali Sha’ath, già viceministro dei Trasporti dell’Autorità Nazionale Palestinese. Il consiglio di amministrazione opererà sotto la guida del Consiglio per la pace, che sarà presieduto dallo stesso Trump e comprenderà membri chiave e al di sopra del governo tecnocratico palestinese. Il comitato dovrebbe includere anche leader di diversi Paesi occidentali, tra cui l’Italia, rappresentata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
A opporsi pubblicamente alla composizione del Consiglio tecnico è stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui l’organigramma non sarebbe stato «coordinato con Israele ed è in contrasto con la sua politica». Indiscrezioni dei media riferiscono che la pietra dello scandalo sarebbe la presenza del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Secondo Haaretz, invece, l’opposizione di Netanyahu sarebbe un mero “teatro politico” per l’opinione pubblica interna, dopo un via libera dato dietro le quinte. In risposta alle critiche di Tel Aviv, nelle ultime ore, secondo Ynet, Trump avrebbe esteso l’invito a far parte del Board for Peace allo stesso primo ministro israeliano o a qualcuno che lo rappresenti.
La scelta dei componenti del consiglio rivela una mappa dei poteri diversa da quella che di solito caratterizza le mediazioni internazionali, comprendendo anche figure provenienti dal mondo della finanza globale e delle grandi aziende. Il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga – già CEO di Mastercard, ex presidente di Exor e figura di spicco dell’economia internazionale – siede nel direttorio accanto al miliardario Marc Rowan, leader di Apollo Global Management, uno dei principali colossi del private equity statunitense e fermo sostenitore di Tel Aviv. Presenti anche il ministro del Qatar Ali Al-Thawadi, il capo dell’intelligence egiziana, generale Hassan Rashad, il ministro degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti Reem Al-Hashimi; l’imprenditore e magnate immobiliare israeliano-cipriota Yakir Gabbay e l’ex inviato ONU a Gaza Sigrid Kaad. La loro partecipazione conferma come a Washington l’agenda di ricostruzione sia strettamente intrecciata a interessi economici e strategici, che rischiano di trasformare la Gaza del futuro in un terreno di sperimentazione e spartizione per i grandi capitali. Le critiche convergono su due punti: la scarsa presenza palestinese in un organismo dominato da attori esterni e grandi interessi economici, e il timore che il Board of Peace diventi una sorta di “ONU di Trump”, un direttorio parallelo più funzionale al soft power globale, capace di aggirare la diplomazia multilaterale in favore di un club di potere guidato da Washington. La vera sfida non sarà ricostruire edifici, ma restituire voce e dignità a Gaza, evitando che la pace venga ridotta a un’operazione finanziaria decisa da banchieri e affaristi su una popolazione rimasta, ancora una volta, senza potere.