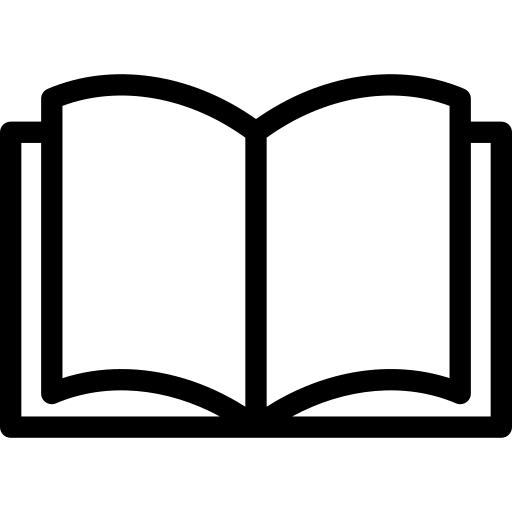Un’imponente operazione di polizia coordinata a livello globale dall’Interpol ha inflitto un duro colpo ai network criminali dediti alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti. Come comunicato dalla stessa organizzazione, nell’ambito della più vasta azione del suo genere mai condotta, oltre 14.000 agenti hanno operato in 119 Paesi tra il 10 e il 21 novembre, portando all’arresto di 3.744 sospetti e alla protezione di 4.414 potenziali vittime. L’operazione, denominata “Liberterra III”, ha inoltre permesso di identificare quasi 13.000 persone coinvolte in schemi di migrazione illegale e di avviare 720 nuove indagini, segnando un punto di svolta nella lotta contro tale crimine transnazionale.
L’Organizzazione internazionale di polizia criminale, con sede a Lione, ha reso noti i risultati dell’operazione, sottolineando la portata e la complessità dello sforzo congiunto. «Le reti criminali si evolvono, sfruttando nuove rotte, piattaforme digitali e popolazioni vulnerabili», ha dichiarato in un comunicato il segretario generale dell’Interpol Valdecy Urquiza, aggiungendo che «identificare questi schemi permette alle forze dell’ordine di anticipare le minacce, distruggere le reti prima e proteggere meglio le vittime». Dei 3.744 arresti effettuati, oltre 1.800 sono specificamente legati a reati di tratta e traffico di migranti. Un aspetto particolarmente significativo emerso dall’operazione riguarda l’evoluzione delle dinamiche criminali. L’Interpol ha evidenziato un cambiamento emergente nei flussi, con casi che coinvolgono vittime sudamericane e asiatiche trafficate verso o attraverso l’Africa: si tratta di un’inversione rispetto ai modelli storici che vedevano principalmente il trasferimento di vittime africane verso l’estero. Lo sfruttamento sessuale rimane la forma più diffusa, ma si registra un forte aumento dei casi di lavoro forzato, criminalità organizzata, servitù domestica e persino traffico di organi.
Le autorità dei Paesi dell’Africa occidentale e centrale, tra cui Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Senegal e Sierra Leone, hanno riferito di azioni di grande impatto, comunicando che le forze dell’ordine hanno salvato centinaia di vittime e smantellato «molteplici centri di reclutamento e sfruttamento». In queste regioni, le vittime vengono spesso adescate con la falsa promessa di un impiego all’estero. I trafficanti applicano tariffe elevatissime e, in una modalità che ricorda uno schema piramidale, costringono le vittime a reclutare a loro volta amici e familiari in cambio di condizioni migliori. L’operazione ha intercettato migranti su rotte pericolose lungo le coste di Senegal, Guinea-Bissau, Marocco e Algeria, nonché all’interno di reti terrestri in Perù, Brasile e altri Paesi. Le attività investigative hanno anche rivelato operazioni su vasta scala in altri continenti. In Asia, ad esempio, le autorità hanno scoperto 450 lavoratori in un unico raid in un complesso in Myanmar.
A porre la lente di ingrandimento sui numeri della tratta di esseri umani è stato, recentemente, il Rapporto Globale sulla Tratta di Persone 2024 dell’UNODC. L’analisi ha fotografato un peggioramento del fenomeno, alimentato da povertà, conflitti armati e crisi climatiche che aumentano la vulnerabilità allo sfruttamento. La ricerca ha coperto 156 Paesi e i casi rilevati tra il 2019 e il 2023. Nel 2022 le vittime di tratta sono risultate aumentate del 25% rispetto al 2019, con un incremento del 31% nel traffico di minori, fenomeno presente anche nei Paesi più ricchi. Donne e ragazze rappresentano il 61% delle vittime, prevalentemente sfruttate sessualmente, mentre per i ragazzi prevalgono il lavoro forzato e altre forme di sfruttamento, come criminalità forzata e accattonaggio. Un focus specifico è stato dedicato all’Africa, evidenziando flussi complessi e un forte aumento del traffico di minori nell’Africa subsahariana.