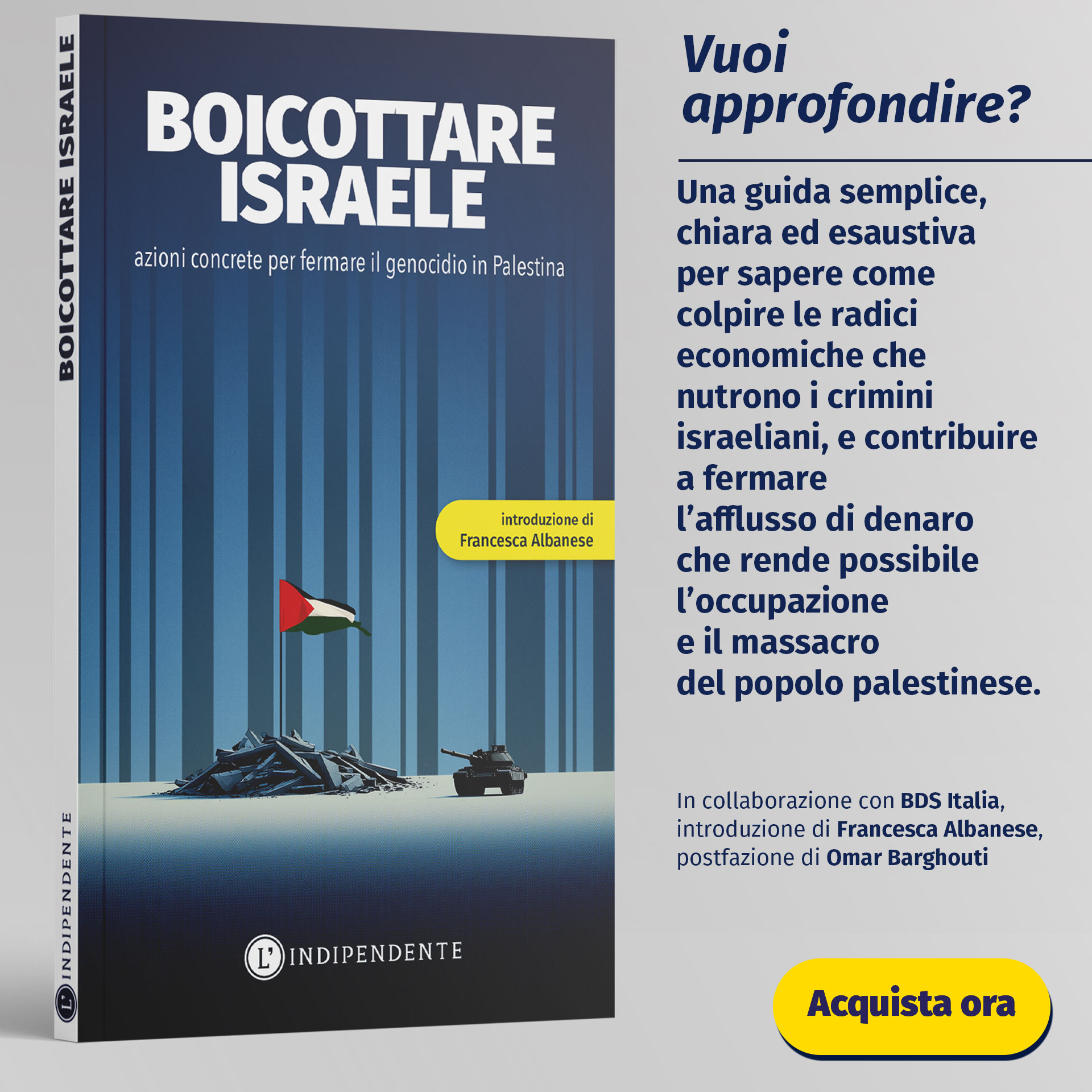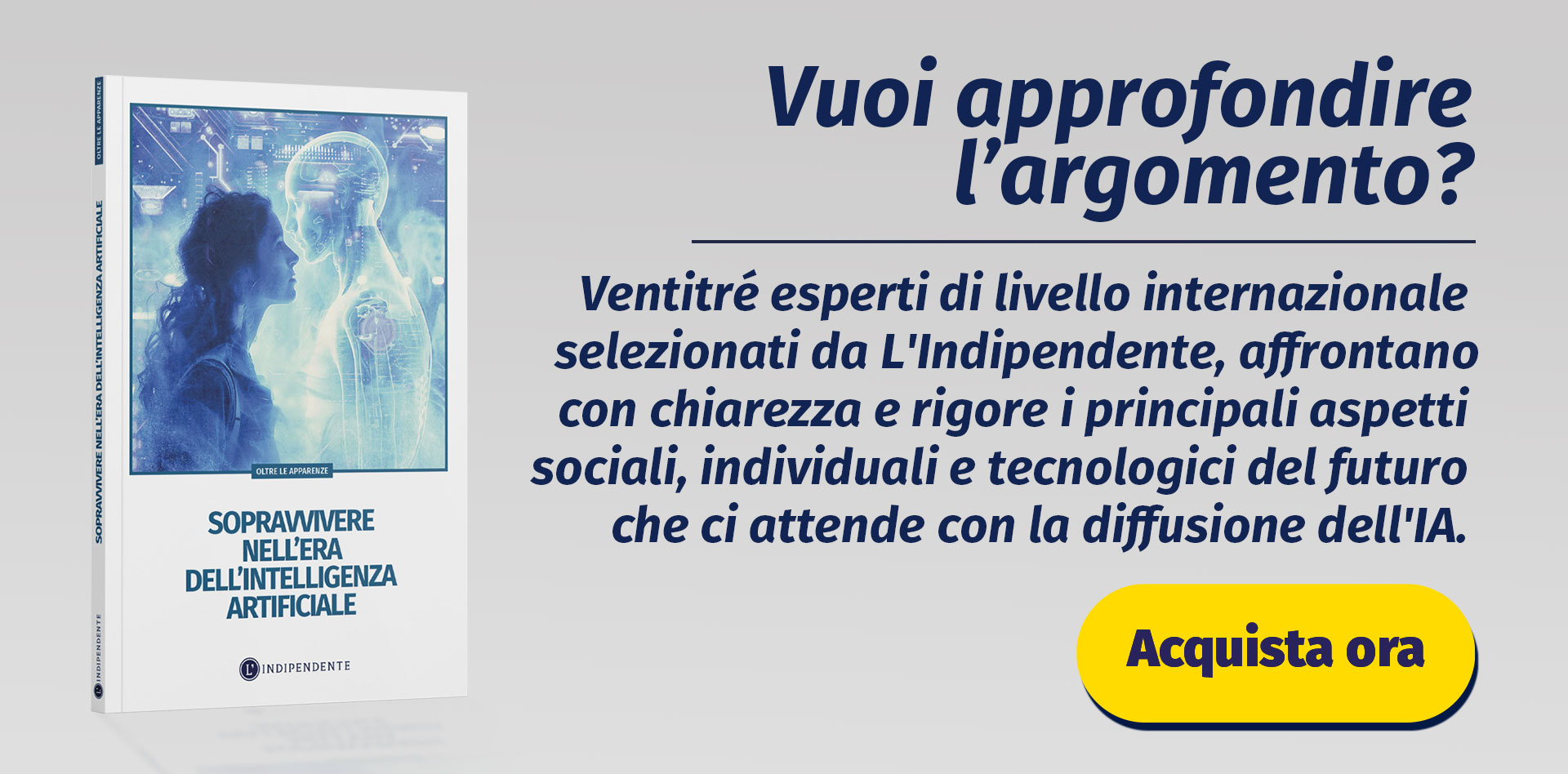L’Ungheria ha presentato una causa davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea contro il Consiglio dell’Unione Europea, contestando gli aiuti all’Ucraina. Di preciso, Budapest contesta il programma del Fondo Europeo per la Pace, con il quale l’UE ha consegnato 11 miliardi a Kiev prendendoli dagli interessi generati dai beni russi congelati. Secondo l’Ungheria, l’approvazione della misura non avrebbe rispettato il principio di uguaglianza degli Stati e il principio del funzionamento democratico dell’UE, perché non ha preso in considerazione il suo veto. Il Consiglio ritiene invece che l’Ungheria non potesse partecipare alla votazione in quanto non era uno «Stato membro contributore». La Corte ha ha rinviato la causa al Tribunale dell’Unione Europea.
La vera origine del Pachino: il pomodoro “tipico” che in realtà è israeliano
Un pomodorino il cui nome è indissolubilmente legato alla piccola città nell’estremo sud della Sicilia dove si produce. Rosso, tondo e dolce al punto da essere diventato uno dei più apprezzati in Italia e non solo. Stiamo parlando del pomodorino di Pachino, dal lontano 2003 riconosciuto come marchio di Indicazione geografica protetta (IGP) ed emblema stesso del made in Italy al punto che il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, si è spinto a prendere ad esempio la sua promozione come simbolo dell’attenzione del governo italiano per «il nostro cibo» e la «sovranità alimentare». Tuttavia, quello che molti non sanno, è l’origine tutt’altro che italiana e tipica di questo pomodoro, arrivato a Pachino negli anni ’80 del secolo scorso grazie alla manovra di un’azienda tecnologica israeliana, che continua ad arricchirsi grazie a questo pomodoro, di varietà quasi sterile e quindi con i semi che vengono ricomprati ogni anno dagli agricoltori.
Arrivato dall’estero

Le prime coltivazioni nella zona di Pachino, in provincia di Siracusa, datano 1925. Negli anni ’60 nascono le prime serre di copertura in polietilene, che ancora oggi caratterizzano queste produzioni. In quegli anni le varietà locali di pomodoro che si coltivavano erano prevalentemente i pomodori insalatari a frutto grosso, e il piccolo ciliegino e datterino che si coltiva oggi era invece completamente assente e sconosciuto.
E qui veniamo al nocciolo della nostra storia: come ci è arrivato in Sicilia il pomodoro ciliegino tondo e succoso? Ci è arrivato direttamente da Israele, alla fine degli anni 80 del secolo scorso. Il pomodoro di Pachino, infatti, è nato in Israele nel 1989, presso una delle più importanti aziende al mondo nel settore delle ricerche genetiche in campo agricolo: la Hazera Genetics. Si tratta di una pianta ottenuta da incroci e ibridi di semi di diverse varietà di pomodoro, un modo velocizzato e artificiale di ricreare l’evoluzione e gli incroci delle specie, che avvengono in natura in tempi lunghi.
In pochi anni questi frutti, grazie anche ad una sapiente pubblicizzazione e agli accordi commerciali con la Grande Distribuzione, raggiungono una enorme popolarità ed entrano nelle case di tutti gli italiani e la tipologia ciliegino diventa sinonimo di «pomodoro di Pachino». Perché questo pomodoro ha avuto grande successo? Essenzialmente per alcune caratteristiche che gli sono state date dal lavoro in laboratorio dei biologi genetisti. Secondo il divulgatore e docente universitario Dario Bressanini infatti «determinante per il successo di questi pomodori è stata l’introduzione, da parte delle aziende sementiere, di due geni chiamati rin e nor (ripening inibitor e no ripening), che permettono di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di 2 o 3 settimane dopo la raccolta.
Per potersi conservare nel tempo i precedenti pomodori da insalata dovevano essere raccolti prima che cambiassero colore dal verde al rosato. I ciliegino invece si possono raccogliere quando sono rossi e completamente maturi». In pratica, grazie alle modifiche a livello genetico sui semi dei pomodori, il pomodoro di Pachino rimane perfettamente maturo per 2 o 3 settimane e non marcisce nel giro di pochi giorni come fanno altre varietà più naturali e autoctone. Un altro motivo per il successo del pomodoro di Pachino è legato alla stagionalità – o meglio alla non-stagionalità – poiché si riesce a coltivarlo tutto l’anno, moltiplicando le rendite.
Semi da ricomprare ogni anno
Quello che però in pochi sanno è che i pomodori progettati dalla multinazionale israeliana Hazera Genetics danno semi che non permettono di riprodurre le caratteristiche originarie del pomodoro. Sempre secondo Bressanini «questo significa che ogni anno gli agricoltori devono ricomprare i semi ibridi registrati, di proprietà della Hazera, per non perdere le caratteristiche agronomiche desiderate. Anzi, ormai gli agricoltori comprano direttamente le piantine dal vivaio, visto il costo delle sementi». In sostanza, non possono ripiantare le stesse piantine cresciute nei loro campi l’anno prima, determinando così un continuo enorme business a vantaggio della multinazionale israeliana. Nei sistemi di agricoltura più naturale sono invece gli agricoltori stessi a creare nuove varietà, selezionando e incrociando i migliori esemplari trovati nei campi, derivanti da mutazioni naturali dovute al clima, al vento, al terreno.
4 tipologie diverse

Uno dei luoghi comuni più diffusi identifica il Pomodoro di Pachino IGP con la varietà detta comunemente «ciliegino», ma in realtà il disciplinare classifica e tutela ben quattro tipologie diverse di pomodoro. Tali tipologie sono: il «tondo-liscio», che si presenta piccolo e rotondo, di colore verde scuro, inconfondibile per il gusto molto marcato e dai frutti di forte consistenza; il pomodoro «a grappolo», che può essere verde o rosso e si presenta tondo, liscio, dal colore brillante, con il colletto verde molto scuro; il «costoluto», di grandi dimensioni, dalle coste marcate, di colore verde molto scuro e brillante e che ha conquistato il favore del consumo nazionale sostituendo nel periodo invernale (periodo ottimale per la produzione di questa tipologia) il «tondo insalataro»; e infine il «ciliegino», conosciuto anche come «pomodorino», varietà di piccole dimensioni, a grappolo o a frutto singolo, di colore rosso intenso, profumatissimo e dal sapore estremamente dolce e succoso. Inoltre il pomodoro di Pachino non si coltiva solo a Pachino ma nei territori comunali di Pachino, Portopalo di Capo Passero, Noto e Ispica, quindi in un’ampia zona delle province di Siracusa e Ragusa.
Pachino al McDonald’s
Nel 2023 il pomodoro di Pachino IGP è entrato nel menù del colosso americano del fast food, grazie ad un protocollo firmato tra il Consorzio di Tutela del pomodoro di Pachino IGP e McDonald’s Italia. Previsto l’acquisto di 250 mila chili di pomodoro ogni anno. Questo accordo è stato favorito dal ministro Lollobrigida e dal Ministero dell’Agricoltura italiano. Questo accordo potrebbe aiutare tutti i produttori della zona di Pachino ad avere più garanzie e un reddito più stabile e sicuro? Forse si, ma tutto dipende alla fine da quanto viene pagato al Kg la fornitura di pomodori agli agricoltori. Se il prodotto è sottopagato, allora non sembra essere un grande affare. Ricordo che negli anni scorsi, per le stesse politiche intraprese dal ministero dell’agricoltura italiano (quando nel 2018 era ministro Maurizio Martina) i produttori di Pachino ebbero grossi contraccolpi e difficoltà economiche per l’importazione di pomodori dal Camerun venduti proprio nei supermercati della Sicilia, oltre che nel Nord Italia. Ad oggi però non è dato sapere quale sia il prezzo al chilo che viene riconosciuto e quali siano i reali vantaggi economici di rifornire il colosso McDonald’s (oltre ad un evidente ritorno di immagine) per i produttori della zona di Pachino. Di sicuro è un’operazione mediatica efficace da parte dell’attuale governo italiano, nel mostrare una propagandistica difesa e valorizzazione del made in Italy. Ricordo infatti che allo stesso tempo lo stesso governo promuove l’importazione di centinaia di altri ortaggi e cibi dall’estero, o per lo meno non fa nulla per limitarla, mettendo così in difficoltà le produzioni nostrane.
Come ai tempi delle colonie: USA, GB e Israele decidono a porte chiuse il futuro di Gaza
«Non ci sarà alcuno Stato palestinese». Sono queste le parole pronunciate dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar a margine del misterioso vertice alla Casa Bianca tenutosi ieri, mercoledì 27 agosto. Alla riunione, Trump ha accolto anche l’ex premier britannico Tony Blair, e il proprio stesso genero, nonché inviato per il Medio Oriente durante il suo primo mandato, Jared Kushner. Del contenuto delle conversazioni si sa poco e niente: «Una semplice riunione politica», avrebbe detto un ufficiale della Casa Bianca, smentendo le parole del braccio destro diplomatico di Trump, l’inviato speciale Steve Witkoff, che definiva l’incontro «largo» e volto a proporre un «piano esaustivo». Blair e Kushner, in effetti, sarebbero coinvolti nelle discussioni sul futuro di Gaza da parecchio tempo. Kushner fu il primo ad abbozzare l’idea di deportare i palestinesi in aree desertiche, e Blair, attraverso la sua fondazione, avrebbe elaborato un progetto per trasformare Gaza in un polo commerciale.
Le informazioni sugli incontri di ieri scarseggiano. Il vertice non è stato annunciato pubblicamente e non ha ricevuto la copertura mediatica che ci si aspetterebbe da una simile iniziativa. Le riunioni si sono tenute a porte chiuse e, in seguito a esse, non c’è stata alcuna conferenza stampa. Ad annunciarlo era stato l’inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che viene attualmente impiegato nelle squadre diplomatiche in diversi scenari di guerra. Ne ha parlato brevemente martedì 26 agosto, in un’intervista all’emittente Fox News, dedicata per la prima metà alla situazione a Gaza e per l’altra a quella in Ucraina: al termine della prima parte dell’intervista, gli è stato domandato se ci fosse un piano per il «giorno dopo» a Gaza, e il diplomatico ha risposto affermativamente, annunciando i colloqui che sarebbero arrivati il giorno seguente.
Marco Rubio si è incontrato con Sa’ar e il collega Ron Dermer, ministro degli Affari Strategici israeliano. Dopo il vertice, Sa’ar è stato intercettato dai giornalisti, che gli hanno chiesto quale fosse il piano per uno Stato palestinese. «Non ce ne sarà alcuno», ha risposto. Non è chiaro se gli stessi ministri abbiano partecipato anche all’incontro a porte chiuse tra Trump, Kushner e Blair, ancora più avvolto nel mistero. Un funzionario della Casa Bianca, citato dall’agenzia di stampa Reuters, avrebbe descritto gli incontri come ordinari, smentendo tuttavia le parole di Witkoff, che li aveva definiti di ben maggiore portata. Secondo il funzionario, il vertice ha discusso di Gaza sotto tutti gli aspetti: dall’aumento delle consegne di aiuti alimentari alla questione degli ostaggi, fino ai piani postbellici.
La vastità degli argomenti trattati e la partecipazione di figure come Blair e Kushner suggeriscono che le parole di Witkoff non fossero un’esagerazione. Tony Blair, infatti, è molto vicino al ministro Dermer, uno dei più fidati uomini di Netanyahu, nonché principale figura di riferimento per le discussioni sul piano postbellico; i due, insieme al ministro degli Esteri emiratino, hanno già lavorato sul piano di pace per Gaza durante l’amministrazione Biden. Da quanto riporta il sito di informazione Axios, inoltre, sembra che Blair sia stato invitato alla Casa Bianca a luglio, quando Trump stava ricevendo Netanyahu. Qualche giorno dopo si è incontrato con il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas per aggiornarlo sugli incontri. Blair, infine, è coinvolto nell’inchiesta del Financial Times sulla Gaza Humanitarian Foundation: secondo il quotidiano britannico, il Tony Blair Institute avrebbe infatti collaborato con il Boston Consulting Group per elaborare un progetto per trasformare Gaza in un polo commerciale; esso prevedrebbe la costruzione di isole artificiali al largo della costa, simili a quelle di Dubai, un porto in acque profonde per collegare Gaza al corridoio economico India-Medio Oriente-Europa e l’istituzione di zone economiche speciali a bassa tassazione.
Kushner, invece, è noto per aver ricoperto il ruolo attualmente assegnato a Witkoff durante il primo mandato di Trump. Il genero del presidente fu il primo a suggerire l’idea di deportare i palestinesi, che lanciò nel febbraio 2024 in occasione di un incontro della Harvard Middle East Initiative. Secondo Axios, anche Kushner si trovava in Israele all’inizio di agosto, dove avrebbe incontrato Netanyahu per discutere di Gaza. Tanto Kushner quanto Blair sarebbero coinvolti nelle discussioni per il piano postbellico da tempo, e sembra che entrambi parlino con Witkoff da diversi mesi. Viste le proposte e i progetti avanzati da febbraio a oggi, e considerate le parole di Sa’ar, tutto fa pensare che durante l’incontro abbiano discusso di come implementare il piano Trump per Gaza. Questo prevede una prima occupazione della Striscia da parte degli Stati Uniti, che poi cederebbero il controllo a Israele o a un’amministrazione palestinese che abbia il beneplacito dello Stato ebraico, smilitarizzata, e non costituisca alcuna minaccia ai piani coloniali di Tel Aviv. Questo significa, nell’ottica israeliana, né Hamas né l’ANP. I palestinesi, intanto, verrebbero deportati.
Russia-Ucraina, attacchi incrociati: 10 morti a Kiev
Le forze russe hanno lanciato un attacco notturno con droni e missili su Kiev, uccidendo 10 persone, ferendone 38 e danneggiando edifici in sette distretti. Lo riferiscono funzionari ucraini, citati da Reuters. L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato di aver abbattuto 563 dei 598 droni e 26 dei 31 missili lanciati dalla Russia in un attacco su scala nazionale. L’agenzia russa Tass, citando il Ministero della Difesa russo, ha riferito che le difese aeree di Mosca hanno intercettato e distrutto 102 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, e che un incendio di 200 metri quadrati è scoppiato in una foresta dopo la caduta di detriti di un drone a Gelendzhik.
La Danimarca convoca il massimo diplomatico USA nel Paese
Il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, ha convocato l’incaricato d’affari statunitense a Copenaghen. Il ministro ha spiegato che, secondo un rapporto di intelligence, gli USA starebbero portando avanti operazioni di influenza in Groenlandia. Il presidente degli USA Donald Trump ha spesso affermato pubblicamente che l’isola, territorio danese, costituisce una risorsa strategica importante per gli Stati Uniti e che Washington vuole impossessarsene. L’incaricato d’affari è generalmente considerato la seconda carica più importante di una ambasciata, ma, dopo il termine del mandato del precedente ambasciatore, gli USA non lo hanno sostituito.
La Norvegia disinveste dalla statunitense Caterpillar: “complice del genocidio a Gaza”
Con una mossa che creerà un precedente rilevante, il fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo – con un patrimonio stimato in oltre 2 trilioni di dollari – ha annunciato la dismissione di investimenti dall’azienda statunitense di macchinari edili Caterpillar, oltre che da altre sei aziende. Le motivazioni, spiega il fondo, riguardano la complicità diretta nelle violenze commesse da Israele contro i palestinesi, quali la distruzione delle case e la costruzione degli insediamenti israeliani, considerati illegali dalla comunità internazionale. La decisione segue di poche settimane il rapporto della relatrice speciale ONU Francesca Albanese, nel quale Caterpillar viene citata proprio come azienda complice del governo israeliano.
Norges Bank Investment Management (NBIM), che gestisce il fondo per conto della popolazione norvegese ed è valutato circa 2 trilioni di dollari, ha detto che c’è un «rischio inaccettabile che le società contribuissero a gravi violazioni dei diritti degli individui in situazioni di guerra e conflitto». La decisione si è basata sulle raccomandazioni del suo consiglio etico, ha detto. Oltre alla statunitense Caterpillar (nota anche come CAT), NBIM disinvestirà anche da First International Bank of Israel e il suo proprietario di maggioranza FIBI Holdings, Bank Leumi Le Israel BM, Mizrahi Tefahot Bank e Bank Hapoalim BM. Le aziende avevano fornito i servizi finanziari necessari per l’attività di costruzione negli insediamenti israeliani in Cisgiordania, che erano stati «stabiliti in violazione del diritto internazionale».
In merito alla società USA di macchine pesanti da lavoro, come riportato dal Financial Times, il Consiglio di NBIM ha dichiarato: «I bulldozer prodotti da Caterpillar vengono utilizzati dalle autorità israeliane nella diffusa distruzione illegale delle proprietà palestinesi. Non c’è dubbio che i prodotti Caterpillar vengano utilizzati per commettere violazioni estese e sistematiche del diritto umanitario internazionale. L’azienda inoltre non ha implementato alcuna misura per prevenire tale uso».
La decisione arriva neanche due mesi dopo che la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha pubblicato un report in cui compaiono tutti i nomi delle grandi aziende che contribuiscono all’economia israeliana, quella che ha chiamato “economia del genocidio”. In questa lista c’è proprio anche Caterpillar. NBIM aveva una partecipazione di 2,4 miliardi di dollari nella società alla fine del 2024, rappresentando circa l’1,2% della proprietà. Il disinvestimento non è un atto isolato da parte del fondo norvegese ma si inserisce nella rigorosa politica di investimento supervisionata da un Comitato Etico indipendente che formula raccomandazioni al Ministero delle Finanze norvegese.
La mossa è molto più di una semplice transazione finanziaria: è un forte segnale politico ed etico per la comunità internazionale. Essa fornisce una validazione istituzionale significativa al movimento globale che spinge per una maggiore responsabilità aziendale nelle aree di conflitto, in particolare in Palestina. L’azione del fondo norvegese indica che la pressione degli attivisti e delle organizzazioni per i diritti umani sta finalmente traducendosi in conseguenze finanziarie concrete. L’episodio pone un precedente rilevante e mette in guardia le multinazionali che operano in contesti sensibili: la reputazione e la responsabilità sociale non sono più semplici appendici del bilancio, ma fattori cruciali che influenzano direttamente la fiducia degli investitori e, di conseguenza, la loro stabilità finanziaria.
Nuove tecnologie, vecchi stereotipi: nella moda, l’IA non reinventa nulla
Giornalmente non consumiamo solo prodotti. Ci nutriamo di parole, foto, video, suoni. Tutto quello che ci circonda ed entra in contatto con la nostra persona in qualche modo contribuisce a nutrire (o avvelenare) la nostra mente e, di riflesso, il nostro corpo. Il potere delle immagini è spesso sottovalutato ma, di fatto, quello che vediamo costantemente sotto forma di fotografie, video, campagne pubblicitarie, tendenze social, diventa parte di un linguaggio comune: codici estetici e visivi ai quali siamo abituati e che disegnano la realtà. Una realtà che, al momento, è popolata di immagini reali ed altrettante artificiali, prodotte da quelle intelligenze che, nutrite ad arte da milioni di elaborati generati dall’ingegno umano, sfornano remix di tutto rispetto. A volte. A volte le foto realizzate con l’AI producono reazioni controverse, come nel caso dell’ultima campagna di Guess pubblicata sul numero di agosto di Vogue America.
Una ragazza bionda, lineamenti perfetti, pelle liscia come quella di una bambola, vestita con un abito a zig zag beige e nero abbinato a una borsa e a un rassicurante sandalo tacco 10. La posa è quella tipica di milioni di campagne pubblicitarie di moda: spontanea ma con gli accorgimenti giusti, sorridente ma non troppo (nella moda le espressioni devono essere sempre un po’ sofferenti), maliziosa ma senza esagerare. Immagine patinata, ogni dettaglio al suo posto, dalle luci alle ombre funziona tutto. Se non fosse per quella minuscola dicitura a margine – alla quale solo certosini sfogliatori di riviste possono fare caso – che dichiara: «Prodotta da Seraphinne Vallora con l’intelligenza artificiale». Ed eccola lì, la prima campagna pubblicitaria con una modella “fantasma” ad atterrare sulla rivista di moda più famosa del mondo. Un momento effettivamente «storico», come lo hanno definito le fondatrici dell’agenzia di comunicazione incaricate di questo lavoro direttamente da Paul Marciano, sul quale, però, sono sorte polemiche su più livelli (nonostante l’apparizione sul web di modelle e influencer completamente generate con l’AI non sia certo una novità – ne avevamo parlato qui). Tutti si aspettavano che questo momento, prima o poi, sarebbe arrivato. Allora perché così tanto scalpore?

Il modo cambia, effettivamente, con un discreto risparmio di risorse, anche economiche, e con un impatto ambientale minore (spesso per fare shooting si muovono truppe di venti/trenta persone da un capo all’altro del mondo). La sostanza, però, rimane la stessa. Quello che fa rabbrividire in questa pubblicità è la totale incapacità di uscire dai canoni. Di fatto, la modella creata dall’intelligenza artificiale non è nient’altro che la copia spudorata di un modello stereotipato che le case di moda propinano da anni e anni.
Una bambola bionda, capello sapientemente ondulato (guai ai ricci!), giovane, magra ma con le curve (quelle piatte usavano negli anni ’90 sulla scia di Kate Moss), rigorosamente bianca e con gli occhi chiari, più rassicuranti di un profondo, inquietante ed anche un po’ banale iride color nocciola. E quella pelle liscia oltre ogni filtro di Photoshop, che pure si è sempre usato nella fotografia di moda, ma almeno ultimamente era limitato a ritocchi leggeri che lasciassero alle modelle un alone di umanità. Eppure, dopo anni di battaglie, dopo qualche apparizione di modelle curvy e anche agé (over 60), la moda ha fatto il giro, rimettendoci davanti agli occhi una perfezione totalmente artificiale. Una sconfitta!
Il vero problema, qui, non è tanto la “finzione”, quanto il fatto che a dare gli input per la creazione di questo nuovo personaggio così banale da essere noioso nella sua vuota perfezione, sono state due donne, due “creative” che non sono state in grado di generare niente di più né di meno di quello che ha sempre funzionato. È quello che ancora vende, sostengono, quello su cui si clicca, quello che attira l’attenzione. E così, invece di sfruttare l’AI in maniera originale, lo si fa copia-incollando canoni estetici riesumati dagli anni ’90. Facili, sicuri, socialmente accettati, a prova di maschio medio.
La domanda da porsi, dunque, non è se le modelle artificiali sostituiranno quelle reali, ma: «perché, pur avendo a disposizione uno strumento che permette di creare qualsiasi cosa, dando vita alle estetiche più variopinte e visionarie, non riusciamo a immaginare nuove bellezze?» Forse dobbiamo accettare il fatto di essere così: umani e tremendamente convenzionali.
Gaza, 86 palestinesi morti a causa di raid e carestia in 24 ore
Gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza hanno ucciso 76 persone e ne hanno ferite 268 nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute di Gaza. Tra queste, 18 persone sono state uccise mentre cercavano aiuto. Al contempo, il dicastero ha registrato 10 decessi dovuti a carestia e malnutrizione nello stesso arco temporale, tra cui due bambini, portando il numero totale dei decessi correlati alla fame a 313, di cui 119 bambini. Il bilancio complessivo delle vittime di Israele nella Striscia supera così la quota di 62.900, con quasi 159mila feriti.