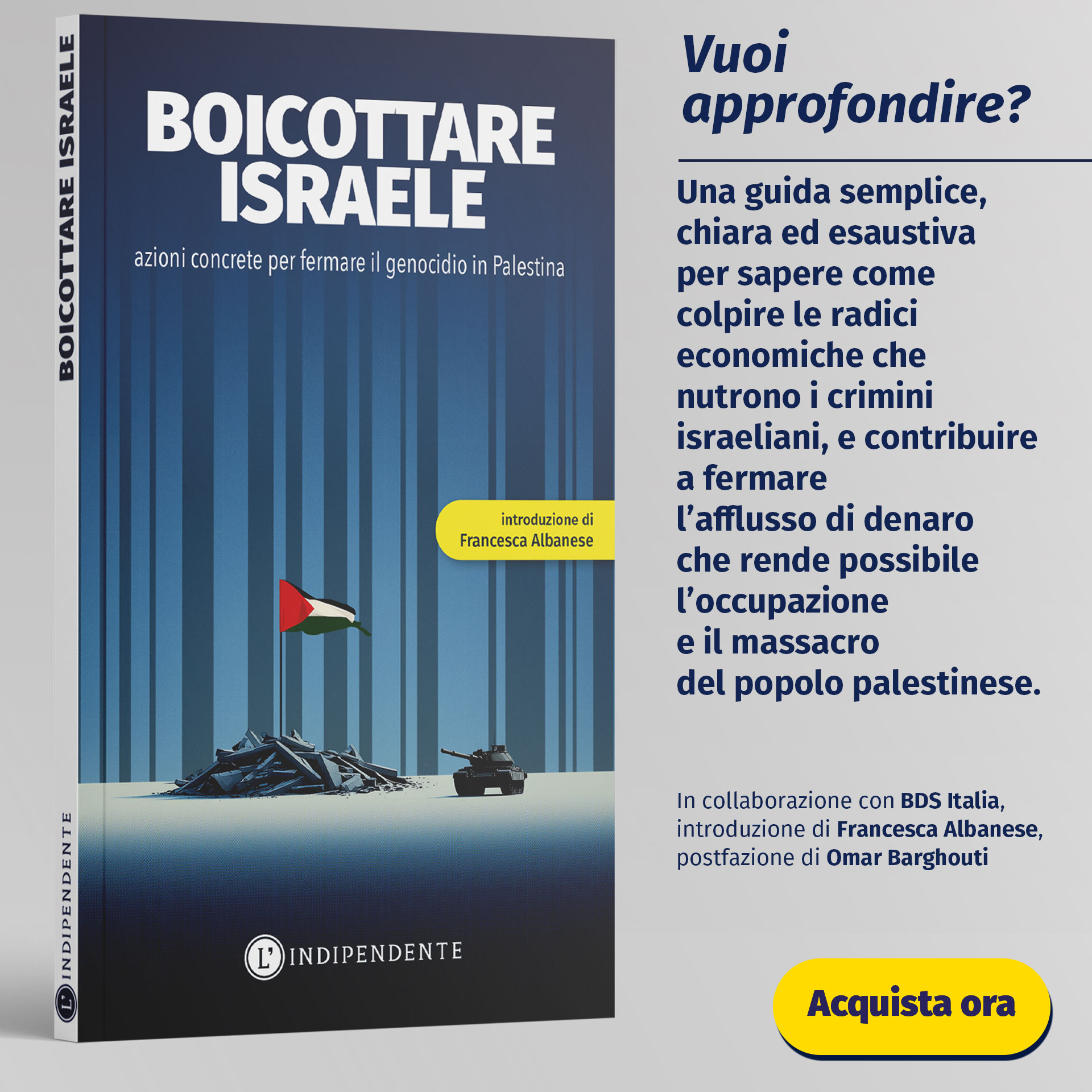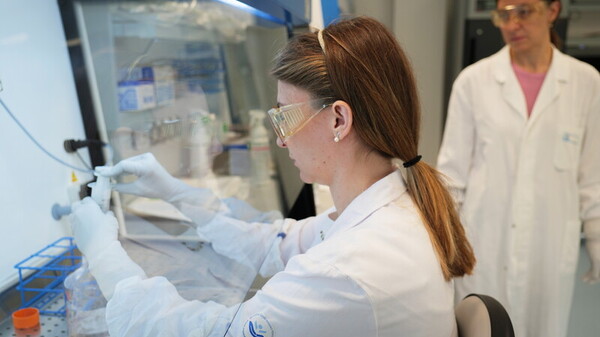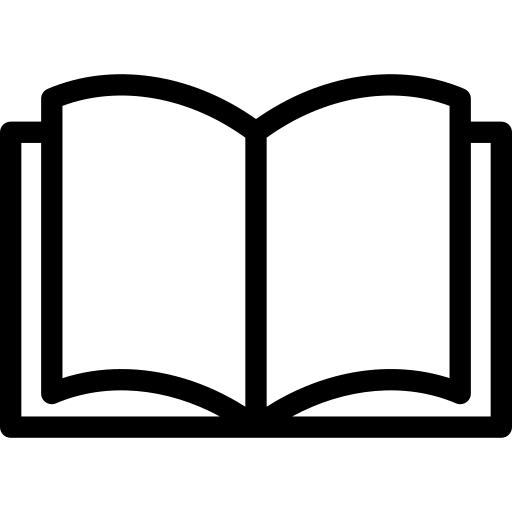Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio a Roma con l’accusa di evasione fiscale per circa 20 milioni di euro, somme che secondo l’accusa non sarebbero state versate tra il 2018 e il 2022 quando era amministratore di fatto dell’Università Niccolò Cusano. Il processo inizierà il 4 giugno davanti al tribunale monocratico e coinvolgerà altre tre persone. Le indagini della Guardia di finanza contestano una gestione con modalità commerciali, pur beneficiando di agevolazioni fiscali per atenei, e l’utilizzo dell’università come un «bancomat» per spese personali di lusso.
Evasione fiscale, sindaco di Terni Stefano Bandecchi rinviato a giudizio
Latte in polvere per neonati con tossine: continuano i sequestri anche in Italia
Il ministero della Salute ha pubblicato negli ultimi giorni la lista dei richiami di più di 70 lotti di latte in polvere distribuiti dalla multinazionale francese Danone. La decisione è stata presa per l’adeguamento alle nuove linee guida EFSA sui limiti della cereulide, tossina prodotta dal batterio Bacillus cereus: la revisione dei parametri europei ha spinto l’azienda ad avviare un ritiro precauzionale dei prodotti coinvolti. Si tratta dell’ennesimo richiamo registratosi negli ultimi mesi nel comparto dei prodotti lattiero-caseari destinati alla prima infanzia, in seguito a numerosi casi di intossicazione denunciati in Europa.
Nello specifico, i lotti di latte per neonati e bambini richiamati – in tutto 76 – sono marcati Aptamil, Mellin e Profutura, commercializzati nel nostro Paese da Danone Nutricia Spa Società benefit. Il provvedimento si colloca in un quadro di allerta su scala internazionale che ha coinvolto decine di Paesi e numerosi marchi di latte per lattanti e di proseguimento, tra cui Nestlé, Lactalis, Danone e, per quanto riguarda l’Italia, Granarolo. Già all’inizio di gennaio Nestlé aveva disposto il ritiro di diversi lotti di latte in formula, compresi Nidina 1 e Nidina Optipro 1. Nei giorni scorsi, inoltre, l’allerta è stata ulteriormente ampliata ad altri lotti, estendendo così il perimetro del richiamo.
Nelle ultime settimane, autorità sanitarie in diversi paesi europei hanno segnalato casi di bambini con sintomi compatibili con intossicazione da cereulide, come vomito e diarrea. In Spagna, cinque neonati sono stati ospedalizzati per disturbi gastrointestinali associati al consumo di formule ora sotto indagine, mentre nel Regno Unito sono state effettuate oltre 30 segnalazioni di possibili casi legati alla contaminazione. Due inchieste giudiziarie sono inoltre state aperte a Bordeaux e ad Angers dopo la morte di due neonati, avvenuta a pochi giorni di distanza. I bambini, deceduti rispettivamente il 23 dicembre e l’8 gennaio, erano stati entrambi alimentati con latte in polvere Guigoz, prodotto da Nestlé (allo stato attuale, non esiste ancora un nesso causale accertato tra i prodotti e i decessi). La scorsa settimana, le autorità sanitarie di Svizzera e Belgio hanno emesso avvisi ai genitori dopo che è stata riscontrata la contaminazione del latte artificiale di diversi produttori con cereulide.
La situazione ha suscitato preoccupazione tra i genitori e ha portato le istituzioni di controllo alimentare di diversi paesi a intensificare i controlli sulla filiera produttiva del latte artificiale per neonati, con campagne di ispezione e l’invito a segnalare prontamente eventuali lotti sospetti. L’Entrata in gioco dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) è un elemento chiave: l’ente ha stabilito un limite molto più rigoroso per la presenza di cereulide nei prodotti per l’infanzia (0,014 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno per lattanti) e ha aggiornato le sue linee guida tecniche a seguito delle ampie campagne di richiamo. Questo nuovo parametro ha spinto diversi produttori, tra cui Danone e Nestlé, a riesaminare i loro lotti e ad allargare le misure di ritiro rispetto a quanto annunciato inizialmente.
Le autorità segnalano che i prodotti oggetto di richiamo non devono essere somministrati a neonati e bambini nella prima infanzia: i consumatori sono invitati a restituirli ai punti vendita, dove potranno ottenere la sostituzione o il rimborso. Qualora un neonato abbia manifestato episodi di vomito o diarrea dopo aver consumato i lotti interessati, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) raccomanda di contattare tempestivamente il pediatra e, in presenza di sintomi severi, rivolgersi direttamente al pronto soccorso.
USA: è morto Jesse Jackson, icona dei diritti civili
È morto a 84 anni il reverendo Jesse Jackson, storico attivista per i diritti civili e due volte candidato alla presidenza USA. La famiglia, annunciandone la scomparsa a NBC, lo ha ricordato come un leader al servizio degli oppressi e degli emarginati. Nato a Greenville, nella Carolina del Sud, emerse accanto a Martin Luther King Jr. negli anni Sessanta. Fondò a Chicago Operation PUSH e la National Rainbow Coalition e fu inviato speciale in Africa per il presidente Bill Clinton. Nel 2017 aveva reso pubblica la diagnosi di Parkinson.
Board of Peace, governi e speculatori riuniti a decidere il futuro di Gaza: Italia “osservatrice”
Napoli, in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro
Nella notte si è sviluppato un incendio a Napoli, interessando il quartiere Chiaia. È andata in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. All’origine dell’incendio, che ha interessato un condominio vicino, vi sarebbe un corto circuito. Intossicate per il fumo alcune persone, resta da capire l’entità del danno per il teatro fondato nel 1847, tra i simboli del panorama artistico napoletano.
È morto Robert Duvall
Oggi, lunedì 16 febbraio, è morto l’attore Robert Duvall. Duvall, 95 anni, era noto per avere interpretato Tom Hagen, l’avvocato di Vito Corleone nel film il Padrino di Francis Ford Coppola, e William “Bill” Kilgore in Apocalypse Now. A dare la notizia della sua scomparsa, la moglie Luciana in un post sul social network Facebook. È morto nella sua casa a Middleburg, in Virginia.
Sottopagato, insicuro, a cottimo: un nuovo rapporto fotografa il lavoro dei rider
È passato in sordina l’ultimo rapporto che fotografa le condizioni lavorative dei rider, a pochi giorni dallo scandalo Glovo. Paghe basse, alti tassi di infortunio e ritmi elevati riassumono lo status di decine di migliaia di lavoratori in Italia, impiegati nel settore delle consegne del cibo. Nell’indagine condotta dalla NIDIL CGIL viene posta l’attenzione sul guadagno medio per consegna, compreso tra i 2 e i 4 euro: «non esistono indennità aggiuntive automatiche per il tempo di viaggio, per le attese o per le spese sostenute». La retribuzione è solo uno dei risvolti della precarietà strutturale cui vanno incontro i rider, inquadrati quasi sempre con contratti di lavoro autonomo e, in via residuale, attraverso rapporti di lavoro parasubordinato.
«Attorno al lavoro dei rider si è strutturato un vero e proprio sistema di illegalità e sfruttamento, spesso definito “caporalato digitale”, che colpisce in modo particolare i lavoratori migranti», circa la metà della forza lavoro totale impegnata nel settore. Lo afferma la NIDIL CGIL, commentando l’inchiesta della Procura di Milano che ha portato al controllo giudiziario di Foodinho-Glovo con gravi accuse di sfruttamento del lavoro e paghe sotto la soglia di povertà. Nell’indagine “La condizione di lavoro dei rider del food delivery”, condotta su 500 persone impegnate nel settore, emergono «salari a cottimo e non dignitosi, condizioni contrattuali senza tutele attraverso l’utilizzo improprio del lavoro in autonomia e allarmanti condizioni di insicurezza sul lavoro». Quasi il 40% dei rider intervistati dichiara di aver subito almeno un infortunio durante il lavoro; soltanto una minoranza ha scelto di denunciare l’accaduto alle autorità competenti per il timore di ritorsioni economiche imposte dagli algoritmi delle piattaforme. A causa delle paghe basse — si parla di una cifra compresa quasi sempre tra i 2 e i 4 euro a consegna — circa la metà dei rider è costretto a lavorare per più aziende, impegnando 6/7 giorni a settimana anche per 10 ore al giorno.
«Qui emerge che il tempo non pagato è un elemento cruciale: le attese al ritiro nei ristoranti possono superare i 10-20 minuti (nel 50,5% dei casi è questa la media dichiarata) e riducono sensibilmente il valore effettivo del compenso», si legge nell’inchiesta della NIDIL CGIL. Per questo motivo, per superare il sistema del cottimo che retribuisce in base al numero di consegne, i rider chiedono l’introduzione di minimi garantiti. Le altre richieste spaziano da una maggiore valorizzazione economica del lavoro all’introduzione di rimborsi per carburante e manutenzione dei mezzi, passando per i contratti di subordinazione che cancellino i falsi autonomi. Parte di queste istanze sono contenute nella direttiva europea sul lavoro tramite piattaforme, che l’Italia deve ancora recepire.