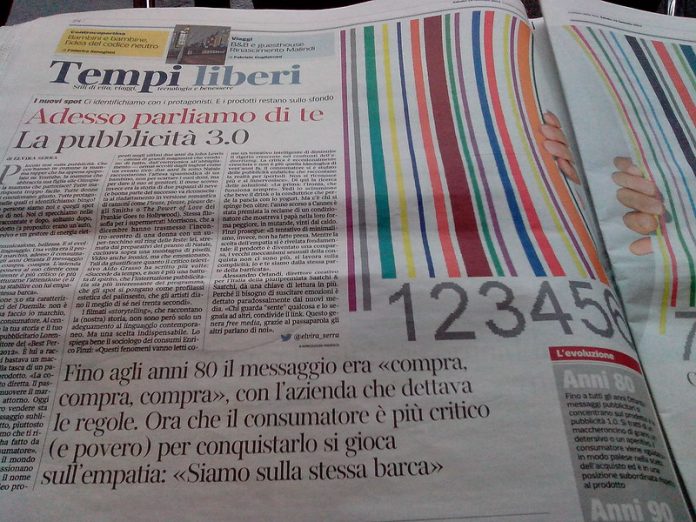E’ la pubblicità, bellezza. O per meglio dire, l’invasione pubblicitaria delle pagine dei quotidiani. E, soprattutto, il vizio – per essere gentili – dei quotidiani stessi di mescolare le notizie con la reclame. Di fare il gioco delle tre carte tra articoli e redazionali, tra titoli e inserzioni, in modo che il confine tra il giornalismo e il commercio sia sempre più sottile. Sempre meno percepibile. Il problema è etico, di etica e deontologia della professione, ma è anche sostanziale, perché se diversi contenuti sono ispirati o orientati verso prodotti di consumo o servizi, invece che verso tematiche o argomenti “veri”, la qualità complessiva dell’informazione decade pesantemente.
Le pagine col trucco, potrebbero essere chiamate cosi, i pezzi che ammiccano a qualche marchio o sigla di cui si leggono a volte intere pagine a pagamento, si sono intensificate negli ultimi anni per motivi vari. Il primo dei quali riguarda ovviamente le condizioni economiche e finanziarie dei giornali, aziende che in buona parte hanno bilanci in rosso o comunque in forte affanno. Il crollo della diffusione e della vendita ha spostato sulla pubblicità e sugli introiti commerciali l’unica fonte di reale sopravvivenza delle testate, che per questo hanno aperto le porte agli inserzionisti senza badare più alle regole della professione, anzi calpestandole sempre più spesso.
Il cavallo di Troia, uno di essi perlomeno, è stato l’avvento dell’infografica che ha ribaltato i rapporti di forza dentro le redazioni e nei menabò: al primato dei contenuti, della forma, diciamo della “ciccia” che si mette in pagina, è subentrato quello della forma, della bella forma. Tabelle, grafici, colori: un ciclone che ha reso molto complicato continuare a produrre pagine leggibili, prima di tutto, e appunto tenere ben distinti i confini tra ciò che è giornalismo e ciò che invece è commercio.
I redazionali di antica memoria, cioè gli articoli a pagamento che un committente commissionava ai giornali e che i giornali impaginavano mettendo molto in chiaro che si trattava appunto di un contenuto “a pagamento”, si sono trasformati in rubriche che in modo più o meno sibillino camminano sul confine tra l’uno e l’altro. E’ il caso, per Repubblica e Corriere della Sera, delle rubriche “Le Guide” e “Eventi”, nelle quali il lettore non ha nessuna indicazione grafica o testuale per capire che si trova di fronte a qualcosa di molto diverso di un articolo di cronaca o un’inchiesta.
Nei grandi giornali si accavallano sempre più spesso pagine o pezzi di pagine comprate da un inserzionista, e interviste o articoli su quello stesso inserzionista. Cosa che l’etica della professione ha ovviamente sempre considerato tra i peccati più gravi. Capita allora che sul Corriere della Sera e Sole 24 Ore l’amministratore delegato della banca Illimity venga intervistato sulla stessa edizione del quotidiano, a poche pagine di distanza, da una pubblicità della stessa banca: la reclame e l’articolo dedicati allo stesso argomento. Più sottilmente, Repubblica e Stampa (gruppo Gedi) si sono divise il compito, forse per annacquare un po’ il brodo e diluire il “connubio”: la prima ha pubblicato la pubblicità Illimity, la seconda una chiacchierata con lo stesso AD della banca.
Stesso discorso le poderose pubblicità per un nuovo negozio milanese di Armani, due pagine, che Repubblica ha pubblicato nella stessa edizione del giornale in cui si leggeva una ricca intervista che si occupava, guardacaso, proprio di quel nuovo punto vendita. Il Corriere non è stato da meno, ma ha pubblicato la pubblicità e l’approfondimento in giorni diversi. Oltre tutto, questo dimostra che l’appiattimento delle testate è ormai granitico: nell’ottica temuta da molti di una specie di “giornale unico” con testate diverse, questi contenuti “doppi” sono stati presentati praticamente uguali su quattro giornali diversi.
Ci sono anche metodi più classici e meno sottili, come dimostra il Corriere della Sera quando si occupa con titoli di favore e di celebrazione, nelle sue pagine di economia, della banca Fineco che, curiosamente, proprio in quei giorni aveva comprato diversi spazi sulle pagine del quotidiano milanese. L’intervista o il pezzo compiacente non sono una novità di questa epoca, per carità, ma diciamo che il loro utilizzo è diventato decisamente sfrontato e senza gli imbarazzi di un tempo. Vale ovviamente, e purtroppo, anche il contrario. Ossia il fatto che ben difficilmente un quotidiano farà inchieste o si occuperà giornalisticamente di aziende, istituzioni o enti da cui trae sostentamento tramite inserzioni, nel caso che questi balzino alla ribalta della cronaca per qualche motivo. Un giornale che, per esempio, ha pagine intere comprate da Eni, potrà mai commissionare ai propri giornalisti inchieste su Eni?
[di Salvatore Maria Righi]