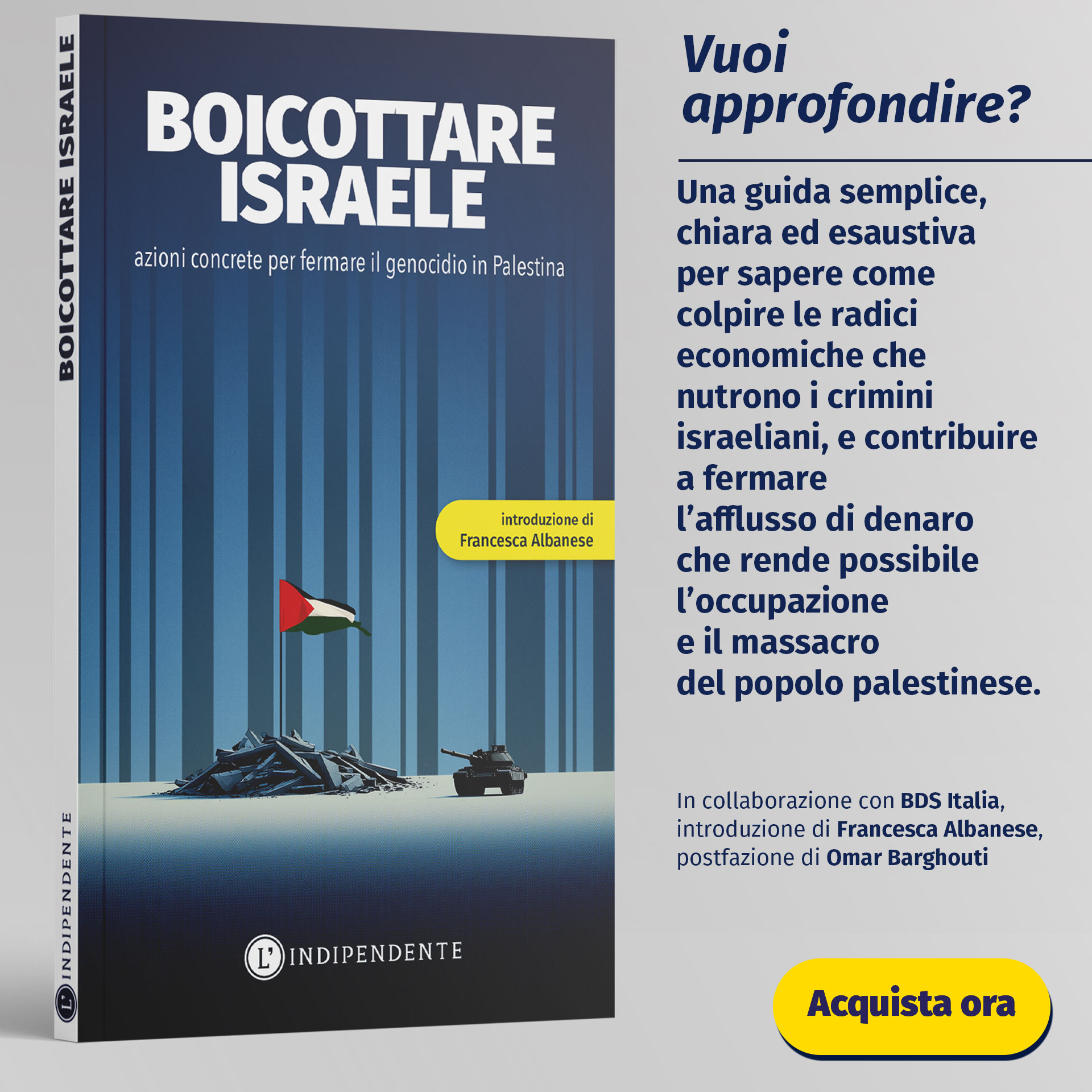I bombardieri strategici russi Tu-95MS delle Forze Aerospaziali hanno effettuato un volo pianificato di oltre sette ore sopra le acque internazionali dei mari di Barents e di Norvegia, a nord della Scandinavia. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa russo. Gli aerei, in grado di trasportare armi nucleari, sono stati scortati da jet da combattimento di Paesi stranieri e monitorati dagli aerei della NATO presenti nella regione. Mosca ha sottolineato che queste missioni avvengono regolarmente e nel rispetto del diritto internazionale.
Ucraina, Zelensky presenta il piano di pace USA: “non prevede la rinuncia alla NATO”
Elezioni dopo la firma dell’accordo, garanzie di sicurezza per prevenire future aggressioni russe, creazione di una zona demilitarizzata nell’Ucraina orientale, linee guida per la ricostruzione del Paese. Sono questi alcuni dei 20 punti dell’ultimo piano per la pace tra Russia e Ucraina, illustrato martedì dal presidente Volodymyr Zelensky alla stampa. Il documento, elaborato con gli Stati Uniti nei colloqui a Miami che si sono tenuti nei giorni scorsi, non contiene alcuna clausola che imponga all’Ucraina di rinunciare alla prospettiva di aderire alla NATO, che resta per la Russia una linea rossa invalicabile, rendendo il piano largamente irricevibile.
La versione attuale della proposta, più snella rispetto a una prima bozza in 28 punti, è stata trasmessa formalmente alle autorità russe attraverso canali diplomatici statunitensi. Se Zelensky ha dichiarato di attendere una risposta di Mosca in giornata, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha escluso commenti pubblici: la Russia valuterà il piano USA dopo il report dell’inviato Kirill Dmitriev, che ha incontrato a Miami gli emissari di Donald Trump. Le reazioni a Bruxelles e Washington oscillano tra cauta speranza e pragmatismo, tuttavia, l’assenza di un accordo con Mosca sulle linee territoriali rende incerto l’esito finale. Il testo prevede un congelamento delle linee del fronte attuali, con monitoraggio internazionale e la possibilità di istituire zone demilitarizzate e libere zone economiche nell’est del Paese, condizionate al ritiro reciproco delle forze e all’approvazione di un referendum ucraino dopo un effettivo cessate il fuoco. In parallelo, il piano prevede una serie di misure economiche e istituzionali: accelerazione dell’accesso all’Unione Europea, un ingente pacchetto di aiuti e investimenti per la ricostruzione postbellica e la formazione di un Consiglio di Pace internazionale che includa USA, Europa, NATO, Russia e Ucraina per supervisionare l’attuazione dell’accordo. La bozza stabilisce garanzie di sicurezza ispirate all’Articolo 5 della NATO fornite da USA, Europa e Paesi firmatari. Queste previsioni sono intese a proteggere l’Ucraina da future aggressioni, senza che sia necessario aderire formalmente all’Alleanza Atlantica. Zelensky ha escluso la rinuncia alla prospettiva di adesione: «Spetta alla NATO decidere», ha sottolineato, ricordando che l’Ucraina non intende modificare la Costituzione per inserire una clausola specifica.
Se il nodo centrale rimane quello dell’adesione alla NATO, resta aperta la partita sul futuro del Donbass e della centrale nucleare di Zaporizhzhia, due temi su cui Kiev e Washington divergono dalle richieste russe. Zelensky ha anche chiarito che la bozza dell’accordo non prevede il ritiro delle sanzioni contro Mosca da parte degli Stati Uniti, ma che Washington intende revocarle gradualmente dopo la fine della guerra. Più che una piattaforma di compromesso, il piano presentato da Zelensky appare come una cornice politica che cristallizza le posizioni di Kiev e dei suoi alleati, scaricando sul tavolo negoziale condizioni che Mosca considera, da tempo, inacettabili.
I 20 punti del piano di pace USA
Ecco l’elenco sintetico dei 20 punti presentati da Zelensky:
- Conferma della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina.
- Stipula di un patto di non aggressione totale e incondizionato tra Russia e Ucraina.
- L’Ucraina riceverà solide garanzie di sicurezza.
- Le Forze armate ucraine manterranno una forza in tempo di pace di 800.000 effettivi.
- Garanzie di sicurezza fornite da Stati Uniti, NATO e Paesi europei secondo criteri simili all’Articolo 5.
- Impegno della Russia a formalizzare politiche di non aggressione verso Ucraina ed Europa.
- Impegno per l’accesso e l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea con tempi definiti.
- Un programma di sviluppo globale per l’Ucraina, da definire in un accordo separato sugli investimenti e la prosperità futura.
- Creazione di fondi dedicati alla ripresa dell’economia ucraina, alla ricostruzione del Paese e alle questioni umanitarie
- Dopo l’accordo, l’Ucraina accelererà la conclusione di un trattato di libero scambio con gli USA.
- Creazione di zone demilitarizzate nelle aree di conflitto con controllo internazionale.
- Gestione congiunta della centrale di Zaporizhzhia tra Ucraina, USA e Russia.
- Impegno congiunto su educazione e inclusione, con programmi contro razzismo e pregiudizi e adeguamento dell’Ucraina agli standard UE su tolleranza religiosa e tutela delle lingue minoritarie
- Riconoscimento dell’attuale linea di contatto con monitoraggio internazionale, ritiro russo da altre regioni come condizione dell’accordo e pieno rispetto delle Convenzioni di Ginevra.
- Avendo concordato futuri accordi territoriali, la Federazione Russa e l’Ucraina si impegnano entrambe a non modificare tali disposizioni con la forza.
- La Russia non impedirà all’Ucraina di utilizzare il fiume Dnepr e il Mar Nero per scopi commerciali.
- Costituzione di un comitato umanitario per garantire l’attuazione dell’accordo e per le questioni in sospeso. Scambio di prigionieri e ricongiungimento delle famiglie.
- Elezioni libere e plurali subito dopo la firma dell’accordo.
- Il presente accordo è giuridicamente vincolante.
- Cessate il fuoco completo immediatamente dopo l’accettazione formale da tutte le parti.
Sea-Watch: naufragio al largo della Libia, 116 morti
Almeno 116 migranti sarebbero morti nel naufragio di un’imbarcazione partita dalla Libia la sera del 18 dicembre, secondo la ONG Sea-Watch. L’unico sopravvissuto sarebbe stato tratto in salvo da un pescatore tunisino, dopo che l’imbarcazione sarebbe andata in avaria e sarebbe affondata poco dopo la partenza, in condizioni meteorologiche critiche con venti forti. La Sea-Watch e il network Alarm Phone avevano lanciato l’allarme per l’imbarcazione con circa 117 persone a bordo, di cui non si avevano più notizie dopo il distacco dai porti libici. Proseguono le operazioni di ricerca.
A 15 anni da Fukushima il Giappone riaprirà la centrale nucleare più potente al mondo
Il 22 dicembre 2025 resterà una data spartiacque nella storia energetica del Giappone. Con un voto di fiducia cruciale, l’assemblea della prefettura di Niigata ha rimosso l’ultimo ostacolo politico alla riapertura della centrale di Kashiwazaki-Kariwa, l’impianto nucleare più potente del pianeta. Il gestore dell’impianto è Tokyo Electric Power Company (TEPCO), lo stesso operatore della centrale di Fukushima, colpita da terremoto e maremoto nel 2011 e i cui scarti radioattivi sono stati sversati da TEPCO, su autorizzazione del governo nipponico, nell’Oceano Pacifico. Kashiwazaki-Kariwa, colosso da 8,2 gigawatt, si appresta a riaccendere i propri reattori dopo quindici anni.
Questa decisione non è un evento isolato, ma il culmine di una metamorfosi strategica che vede il Sol Levante abbandonare la prudenza post-disastro per abbracciare nuovamente l’atomo come pilastro della propria sicurezza nazionale e della transizione ecologica. Tuttavia, il ritorno all’operatività di Kashiwazaki-Kariwa riapre ferite mai del tutto rimarginate e solleva interrogativi critici sulla capacità di TEPCO di garantire una sicurezza infallibile in una delle aree più sismiche del mondo. La centrale di Kashiwazaki-Kariwa è un gigante addormentato dal 2011. E non fu il solo. A seguito del disastro di Fukushima, l’intero parco nucleare giapponese fu messo a revisione. Decine di reattori sono stati disattivati, alcuni definitivamente, altri in attesa di lavori drastici. Per TEPCO, il percorso di riabilitazione è stato costellato di ostacoli non solo tecnici, ma anche etici.
Nel 2021, l’Autorità di Regolamentazione Nucleare (NRA) aveva imposto un divieto operativo all’impianto a causa di gravissime falle nella sicurezza antiterrorismo, tra cui l’uso improprio di tesserini identificativi e il malfunzionamento dei sistemi di monitoraggio degli accessi. Solo dopo anni di riforme interne e la revoca del ban nel tardo 2023, la società ha potuto compire le procedure finali di riavvio. La priorità è ora fissata sul reattore n. 6, con l’obiettivo di riportarlo in rete entro il 20 gennaio 2026. Mentre TEPCO lotta per recuperare credibilità, la Kansai Electric Power (KEPCO) ha già tracciato una rotta ancora più ambiziosa. Nel corso del 2025, KEPCO ha annunciato l’intenzione di costruire un nuovo reattore di “prossima generazione” presso il sito di Mihama, nella prefettura di Fukui. Si tratta del primo progetto di costruzione di un reattore ex novo dal 2011, un segnale inequivocabile del cambio di paradigma nel Paese.
Questo dinamismo è alimentato dal Settimo Piano Strategico per l’Energia approvato dal governo giapponese nel febbraio 2025. Il documento ha ufficialmente rimosso l’obiettivo di ridurre il più possibile la dipendenza dal nucleare, sostituendolo con la direttiva di massimizzarne l’uso. Entro il 2040, il Giappone punta a far sì che il nucleare copra il 20% del mix elettrico nazionale per sostenere la crescente domanda derivante dai data center e dalle industrie legate all’intelligenza artificiale.
La decisione della prefettura di Niigata non è stata priva di tensioni. Lunedì scorso, mentre i legislatori votavano, centinaia di manifestanti si sono radunati davanti agli uffici governativi con cartelli che ricordavano l’incubo di Fukushima. Per molti residenti, la sfiducia nei confronti di TEPCO rimane un dogma insuperabile. La preoccupazione principale riguarda i piani di evacuazione: l’area di Kashiwazaki è stata colpita in passato da forti terremoti (come quello del 2007) e la vulnerabilità delle infrastrutture stradali resta un punto critico.
Non si è trattato solo di una manifestazione di dissenso, ma del riflesso di una nazione profondamente spaccata tra le necessità economiche imposte da Tokyo e una memoria collettiva ancora segnata dal trauma di Fukushima. Le proteste che hanno accompagnato il “sì” della prefettura non sono nate dal nulla. Rappresentano il culmine di mesi di mobilitazione silenziosa, assemblee cittadine e battaglie legali. Il cuore del dissenso risiede in una domanda fondamentale che ha risuonato più volte nei megafoni dei manifestanti: TEPCO è davvero qualificata per gestire l’impianto più potente del mondo?.
Il Governatore di Niigata, Hideyo Hanazumi, ha giustificato il proprio appoggio alla riapertura citando la necessità di stabilizzare i prezzi dell’energia, schizzati alle stelle a causa della dipendenza dalle importazioni di gas naturale e carbone, e la promessa del governo centrale di finanziare nuove vie di fuga d’emergenza. Tuttavia, ha ammesso apertamente che «esiste ancora un’ansia profonda tra i cittadini che non può essere ignorata».
Inoltre, la scelta di puntare su impianti che hanno ormai superato i 40 anni di vita (con estensioni fino a 60 anni approvate recentemente per altri reattori) solleva dubbi sull’invecchiamento dei materiali in un contesto di rischio geologico permanente. Il Giappone si trova in un vicolo cieco: per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e mantenere la competitività industriale, il nucleare appare come l’unica soluzione immediata, ma il prezzo sociale di questa scelta potrebbe essere un’ulteriore erosione della fiducia verso le istituzioni.
Camorra: arrestato Ciro Andolfi, tra i 100 uomini più pericolosi
I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato Ciro Andolfi, 49 anni, ricercato dal 2022 e inserito nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi del Ministero dell’Interno. Andolfi, ritenuto esponente del clan di camorra “Andolfi-Cuccaro” e destinatario di un ordine di carcerazione per oltre 8 anni per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione, è stato trovato in un nascondiglio in muratura ricavato in un appartamento nel quartiere Barra di Napoli durante una perquisizione. Il provvedimento è stato eseguito su mandato della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli e segna il 22º arresto di un latitante nell’anno.
Israele non ammette critiche: censurati tutti i media che “minano la sicurezza nazionale”
Il Parlamento israeliano ha approvato lunedì in via definitiva la proroga di un disegno di legge che consente alle autorità del Paese di chiudere i media stranieri qualora questi ultimi siano accusati di minare la sicurezza dello Stato. La legge, promossa dal parlamentare Ariel Kallner del Likud, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2027 e rappresenta l’estensione di una misura approvata il primo aprile 2024 durante la campagna militare israeliana a Gaza. Il provvedimento appena emanato include diversi emendamenti tesi a eliminare il controllo giudiziario e, a differenza della legge approvata nel 2024, potrà essere applicata anche se Israele non si trova in stato di emergenza, rappresentando una vera e propria forma di censura. La legge, in particolare, prende di mira il media qatariota Al Jazeera, accusato da Israele di essere uno strumento di propaganda della causa palestinese e anche di aver partecipato attivamente al massacro del 7 ottobre. Tutte accuse smentite perentoriamente dall’emittente qatariota che ha parlato di «accuse diffamatorie» e di una soppressione della libertà di stampa che «contraddice il diritto internazionale e umanitario». Sia il sito web che il canale televisivo Al Jazeera restano vietati per legge in Israele.
Nel dettaglio, la legge stabilisce che il Ministro delle Comunicazioni ha il diritto, con il consenso del Primo Ministro e con l’approvazione del Governo o del Comitato ministeriale per la sicurezza nazionale (Gabinetto politico di sicurezza), di disporre che vengano adottate misure per limitare le trasmissioni e l’attività di un’emittente straniera, qualora, sulla base di un parere delle agenzie di sicurezza, si ritenga che il suo contenuto arrechi un danno reale alla sicurezza dello Stato. In questo caso, le autorità potranno prendere una serie di provvedimenti, tra cui l’interruzione delle trasmissioni, la chiusura di uffici in Israele, il sequestro di apparecchiature utilizzate per la trasmissione, la chiusura di un sito web o la limitazione dell’accesso allo stesso, nonché interventi tecnologici per impedire la ricezione di trasmissioni via satellite. La direttiva avrà una validità di novanta giorni, con la possibilità di prorogarla per ulteriori periodi fino a 90 giorni ciascuno.
Già nel maggio 2024, il governo aveva approvato la chiusura di Al Jazeera – l’unico media che raccontava la guerra a Gaza con propri corrispondenti sul campo – ordinando anche alle forze dell’ordine di fare irruzione presso la sede di Nazareth dell’emittente, così da confiscarne le apparecchiature e realizzarne la chiusura effettiva. Nonostante lo Stato ebraico giustifichi le sue decisioni con la motivazione della «sicurezza nazionale», il suo rapporto con la stampa è così ostile che le sue azioni legislative appaiono più un modo di silenziare chi racconta gli eventi in diretta che non un modo per tutelare la sicurezza nazionale. Non solo, infatti, Israele ha adottato una legge per chiudere i media stranieri, ma ha anche prorogato il divieto di accesso per i giornalisti internazionali alla Striscia di Gaza. Cosa che ha indotto la FPA (Foreign Press Association) – rappresentante di circa 400 testate – a presentare una petizione all’Alta corte di Gerusalemme per ottenere l’accesso indipendente dei media internazionali a Gaza. Ciò significa che il mondo non può avere notizie dirette e indipendenti di ciò che succede in Palestina, ma solo quelle filtrate e selezionate da Israele. Inoltre, secondo due importanti organizzazioni di giornalisti – la IFJ (International Federation of Journalists) e la RSF (Reporter Sans Frontières) – la metà dei giornalisti uccisi nel mondo nel 2025 è stata assassinata a Gaza da Israele.
Al Jazeera riporta che molti suoi collaboratori – e in alcuni casi anche le loro famiglie – sono stati ammazzati durante gli ultimi due anni durante l’assedio a Gaza: secondo le stime, sono oltre 200 i cronisti e gli inviati uccisi in Palestina in questo lasso di tempo. Tuttavia, la tendenza a sopprimere la libertà di stampa e a sopprimere fisicamente gli addetti alla comunicazione non è qualcosa di confinabile sono agli ultimi due anni, in seguito all’attacco palestinese del 7 ottobre: già nel 2017, infatti, Netanyahu aveva minacciato di chiudere la sede di Gerusalemme di Al Jazeera e un missile israeliano aveva distrutto l’edificio che ospitava gli studi dell’emittente a Gaza nel 2021. Mentre nel maggio 2022, era stata freddata a colpi d’arma da fuoco la giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh da soldati israeliani nella Cisgiordania occupata.
Con l’ultima legge approvata lunedì sera dalla Knesset, il Parlamento di Israele, lo Stato ebraico conferma la sua tendenza alla censura dell’informazione, continuando a ostacolare la diffusione di ciò che accade realmente in Palestina e adottando misure che sono apertamente in contrasto con la definizione di Israele come «unica democrazia del Medio Oriente».
Belgio: intervento per genocidio contro Israele alla Corte Penale
Il Belgio ha depositato un intervento nella causa contro Israele per genocidio presso la cancelleria della Corte Penale Internazionale. La memoria è stata presenta ai sensi dell’articolo 63 della Corte, che permette agli Stati firmatari dello Statuto di Roma di intervenire nei procedimenti attivi per crimini perseguiti dalla Corte. Sudafrica e Israele sono stati invitati a depositare osservazioni sull’intervento di Bruxelles. L’intervento del Belgio si aggiunge a quelli di Colombia, Libia, Messico, Palestina, Spagna, Turchia, Cile, Maldive, Bolivia, Irlanda, Cuba. Belize, Brasile e isole Comore.
Thailandia-Cambogia: via ai dialoghi per una tregua
Oggi, 24 dicembre, i funzionari militari di Thailandia e Cambogia hanno iniziato i colloqui per una ripresa del cessate il fuoco. I colloqui arrivano due giorni dopo un incontro avvenuto a Kuala Lumpur, capitale della Malesia, mediato dall’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico e da Trump. Il dialogo avviato oggi durerà tre giorni. L’incontro rappresenta il passo più significativo da quando sono riesplosi i combattimenti e arriva sullo sfondo di scontri non ancora terminati, che finora hanno portato alla morte di almeno 86 persone.