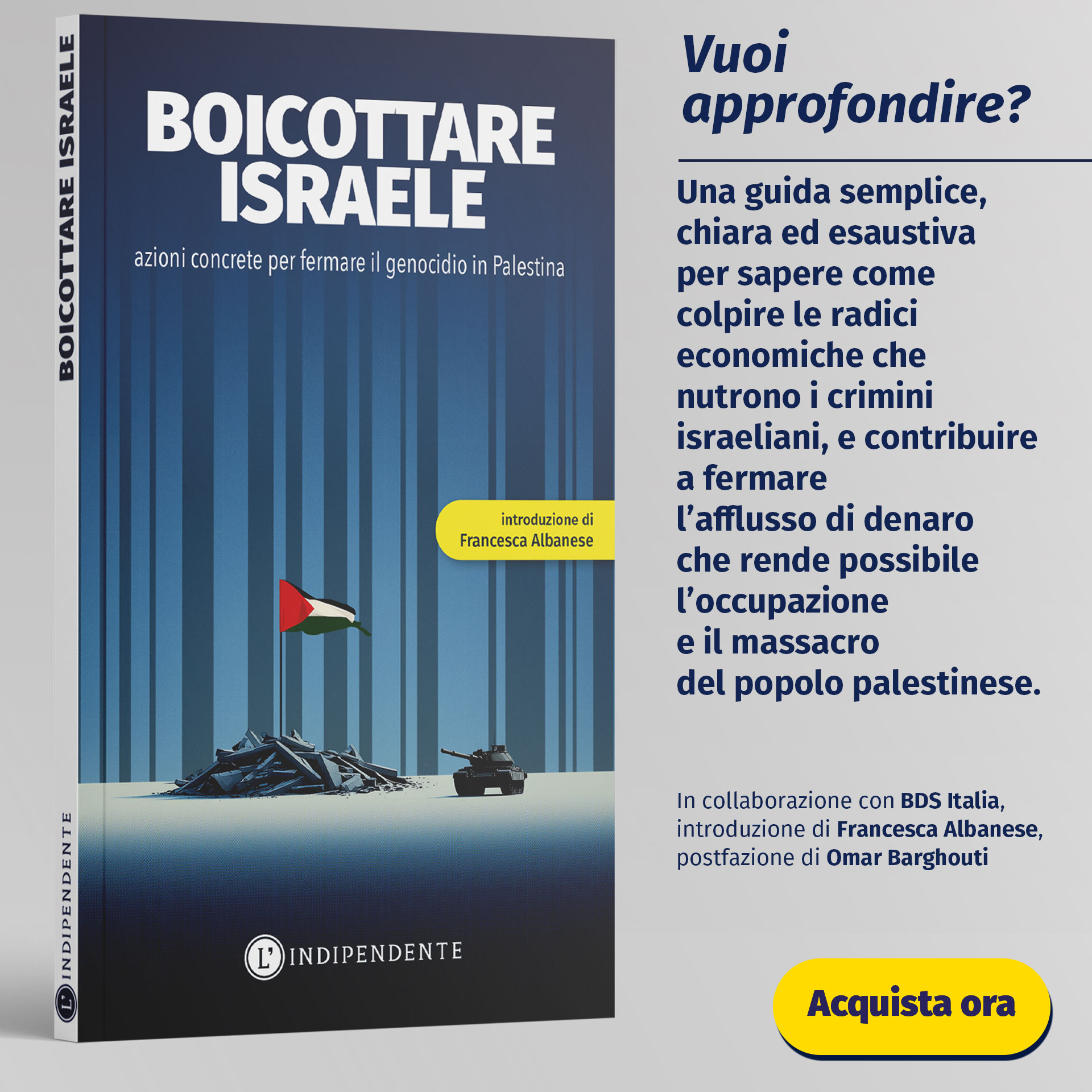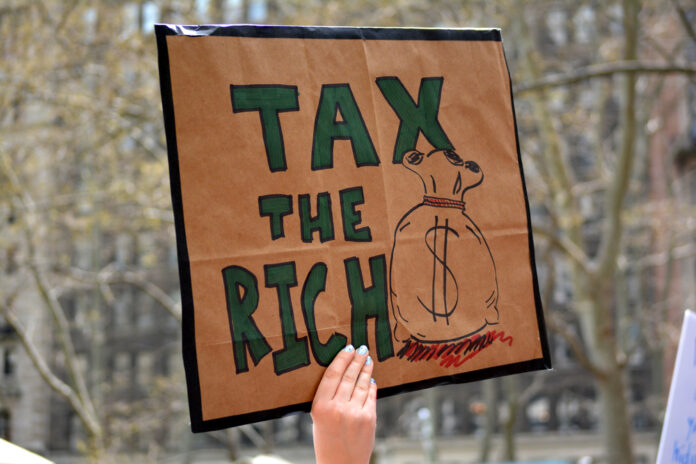Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha sciolto il parlamento del Paese. La decisione di sciogliere il Parlamento arriva in un clima politico di sfiducia per il premier, a causa di una serie di discussioni sul cambio della Costituzione in corso da tempo; i cittadini saranno chiamati a votare nei prossimi 45-60 giorni. L’annuncio di dimissioni da parte di Anutin va in parallelo con i continui scambi di attacchi con la Cambogia; dal nuovo scoppio del conflitto, la scorsa settimana, almeno 20 persone sono state uccise e 200 ferite.
Palestina occupata: Israele approva altre 800 case negli insediamenti illegali
Israele ha dato l’approvazione definitiva a un piano che prevede la costruzione di 764 nuove unità abitative in tre distinti insediamenti nella Cisgiordania occupata. A dare la notizia è il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, uno dei più arditi sostenitori del piano coloniale di Israele (oltre a essere colono egli stesso). «Israele continua la rivoluzione», ha commentato con tono trionfale il ministro. Di preciso, le nuove unità saranno distribuite tra Hashmonaim, situata oltre la Linea Verde (il confine pre-1967), nel centro di Israele, e Givat Zeev e Beitar Illit vicino a Gerusalemme. Esse andranno ad aggiungersi ai diversi progetti approvati nel corso di quest’anno, nell’ambito di quella che lo stesso Smotrich ha definito una «mossa strategica» per rafforzare le unità coloniali. Smotrich ha inoltre ricordato che dall’inizio del mandato dell’ultimo governo Netanyahu, a fine 2022, lo Stato ebraico ha approvato la costruzione di oltre 51mila unità abitative nei territori palestinesi occupati.
Delle 764 unità abitative previste dal nuovo piano di insediamento annunciato da Smotrich, 478 saranno costruite a Hashmonaim, 230 nella colonia ultra-ortodossa di Betar Illit e 56 a Givat Ze’ev. La decisione è stata presa dal Consiglio Superiore di pianificazione, l’organismo del Ministero della Difesa responsabile dei piani di costruzione degli insediamenti in Cisgiordania, ed è stata promossa dallo stesso Smotrich, colono residente nell’insediamento di Kedumim, riconosciuto come illegale dalla comunità internazionale. Lo scopo del nuovo piano è esplicito: «Rafforzare gli insediamenti e garantire la continuità della vita, della sicurezza e della crescita» nelle colonie. Lo stesso Smotrich ha spesso definito la politica della colonizzazione, di cui risulta uno dei più arditi promotori, una tattica efficace per avvicinare Israele all’annessione totale della Cisgiordania; è anche per tale motivo che la scelta di aumentare ulteriormente le unità abitative attorno a Gerusalemme e nella Cisgiordania centrale è stato criticato dall’Autorità Palestinese, che ha chiesto l’intervento di Trump per garantire che la legge internazionale venga rispettata.
L’iniziativa annunciata ieri, spiegano i giornali israeliani, è parte di un più ampio piano di espansione nelle aree designate. Il riferimento è al piano di insediamento E1, che interesserà una vasta area nei pressi di Gerusalemme con lo scopo dichiarato di spaccare a metà la Cisgiordania. Esso di preciso prevede la costruzione di oltre 3.000 unità abitative tra Gerusalemme Est e Maale Adumim, che isolerebbero i quartieri palestinesi di Gerusalemme Est dalle aree della Cisgiordania non occupate, e separerebbero di fatto Betlemme, la stessa Gerusalemme Est e Ramallah. Il piano è stato pensato oltre trent’anni fa, ed è stato duramente criticato da diversi Paesi e istituzioni internazionali; nonostante ciò, questa estate Israele ha fatto ripartire l’iter per la sua approvazione, congelato proprio a causa della generale opposizione internazionale.
Il piano di espansione E1 è solo uno dei tanti progetti di allargamento delle colonie israeliane in Cisgiordania. I vari schemi, inoltre, non si limitano a costruire nuove unità abitative, ma spesso riguardano l’implementazione di servizi, se non direttamente la costruzione di insediamenti nuovi. L’ultimo è stato annunciato qualche giorno fa dallo stesso ministro Smotrich, e prevede lo stanziamento di 2,7 miliardi di shekel – circa 720 milioni di euro – per la creazione di 17 nuove colonie in Cisgiordania nei prossimi cinque anni e lo sviluppo di infrastrutture coloniali in diverse aree dei territori occupati.
Truffa da 30 milioni: arrestate 9 persone
Nove persone sono state arrestate nell’ambito di una indagine della procura di Brescia riguardante un sistema di frodi e truffe informatiche dal valore di 30 milioni di euro. L’indagine è iniziata su segnalazione della onlus Opera di Santa Maria del Fiore, che gestisce il Duomo di Firenze, il campanile di Giotto e il battistero di San Giovanni, che nell’agosto del 2024 aveva subito una truffa da 1,5 milioni di euro. Secondo l’inchiesta, il sistema avrebbe funzionato tramite l’emissione di fatture da società false, che avrebbero poi trasferito il denaro su conti esteri.
Sciopero generale in Portogallo: treni e voli bloccati
Oggi in Portogallo c’è stato il primo sciopero generale degli ultimi dodici anni. Le proteste hanno interessato diverse città, bloccando i trasporti locali, i servizi ferroviari e gli aeroporti; centinaia di voli sono stati cancellati, le scuole sono rimaste chiuse, i siti di produzione metalmeccanici sono rimasti fermi e gli ospedali hanno assicurato solo il minimo dei servizi da garantire per legge. Lo sciopero intendeva contestare le nuove norme in tema di politiche di lavoro proposte dal governo di Luís Montenegro. Tra le proposte, denunciano i sindacati, norme che faciliterebbero i licenziamenti e renderebbero più precari i contratti di lavoro, e altre che diminuiscono i diritti delle lavoratrici incinte.
Bulgaria: il governo si dimette dopo le proteste
Anche l’Islanda boicotta Eurovision per protestare contro l’ammissione di Israele
L’Islanda si aggiunge ufficialmente all’ondata di defezioni dall’Eurovision 2026. L’emittente pubblica islandese RÚV ha infatti annunciato che non invierà un concorrente né trasmetterà il concorso a Vienna – in programma il prossimo maggio – per protestare contro la decisione dell’EBU di mantenere in gara la televisione di Stato israeliana. La scelta, comunicata formalmente all’organizzazione, segue le rinunce già deliberate da Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia e nasce dalla forte pressione pubblica e dalle critiche sul ruolo politico del contest dopo gli avvenimenti legati al conflitto in Gaza. Al contrario, nel dibattito interno all’EBU, l’Italia ha sostenuto la partecipazione del broadcaster israeliano Kan, affermando che prenderà parte alla gara.
La decisione di RÚV è stata motivata con parole dure verso la gestione del dossier da parte dell’EBU: «Abbiamo deciso di non partecipare all’Eurovision Song Contest di Vienna il prossimo anno», comunica l’emittente islandese, che ricorda come la vicenda abbia provocato divisioni interne e polemiche. In un passaggio ufficiale la televisione sottolinea che, «considerato il dibattito pubblico in corso nel Paese e le reazioni alla decisione presa la scorsa settimana dall’EBU, è chiaro che né gioia né serenità prevarranno riguardo alla partecipazione della RÚV all’Eurovision. La RÚV ha quindi deciso di comunicare oggi all’EBU che non prenderà parte all’Eurovision il prossimo anno».
L’allargarsi del boicottaggio è la reazione alla scelta dell’EBU, presa dopo un pacchetto di riforme al regolamento — tra cui la riduzione del numero massimo di televoti per utente e il ritorno delle giurie nelle semifinali — ma senza mettere formalmente ai voti la partecipazione di Israele. La mossa islandese interrompe una lunga serie di partecipazioni: RÚV lascia la gara dopo 21 edizioni consecutive (22 contando l’annullamento del 2020) e valuta ancora il futuro del proprio selettore nazionale, il Söngvakeppnin. Pur ritirandosi, l’emittente precisa che l’Eurovision «andrà regolarmente in onda», lasciando intendere che la protesta riguarda la partecipazione e non la fruizione del programma.
Dopo mesi di discussioni, in seguito all’annuncio ufficiale che Israele parteciperà all’Eurovision Song Contest del 2026, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna hanno ritirato la loro partecipazione dall’evento proprio a causa della presenza israeliana. La decisione, presa formalmente a inizio dicembre, ha fatto eco alle dichiarazioni rilasciate nel corso degli ultimi mesi. Spagna e Irlanda hanno anche precisato che non trasmetteranno l’evento nelle proprie reti. Da tempo, infatti, si sono fatte promotrici di una campagna di boicottaggio verso l’emittente israeliana Kan, come forma di solidarietà al popolo palestinese e condanna del genocidio. La discussione sull’eventuale esclusione di Israele dalla competizione va avanti da anni, ma è esplosa da aprile 2025, poco prima dell’apertura dell’ultima edizione.
Il nostro Paese, invece, si muove in senso contrario. La radiotelevisione pubblica italiana (RAI) ha infatti annunciato sabato scorso il proprio sostegno alla partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2026, confermando che anche l’Italia parteciperà all’evento. «In qualità di membro dei Big Five l’Italia è da sempre tra i Paesi che hanno creduto e investito nell’Eurovision Song Contest, contribuendo in modo significativo, anche economicamente, al suo sviluppo e al suo successo internazionale – recita il comunicato diffuso dalla tv di Stato italiana –. Negli ultimi anni il nostro impegno è cresciuto costantemente, a testimonianza del valore che attribuiamo a un evento che rappresenta la più longeva manifestazione musicale internazionale, capace di unire culture diverse in una celebrazione comune. L’impegno di Rai all’interno della competizione è conferma della volontà di rafforzare il ruolo dell’Italia nella promozione di musica, cultura e spettacolo a livello internazionale».
Nucleus Genomics, la startup americana che promette bambini su misura
«Pick your baby» («Scegli il tuo bambino»), «Have your best baby» («Ottieni il tuo figlio migliore»). Nucleus Genomics, una startup americana di procreazione artificiale, ha tappezzato New York con enormi cartelloni con i volti patinati di neonati, pubblicizzando i suoi servizi di “ottimizzazione genetica”. La promessa è semplice: analizzare il genoma degli embrioni e permettere ai futuri genitori di scegliere quello con il “profilo genetico migliore”, in base a un’analisi che misura probabilità di salute, aspetto, intelligenza e persino predisposizione a malattie psichiatriche. Una strategia che sta prendendo sempre più piede nella Silicon Valley, volta a superare i confini della genetica riproduttiva e allevare “super-bambini” su misura, riaprendo la porta a nuove forme di eugenetica.
Kian Sadeghi, il venticinquenne fondatore e CEO di Nucleus Genomics, ritiene che ogni genitore abbia il diritto di fare proprio questo, selezionando le qualità che desidera per il proprio figlio, dall’altezza al peso all’intelligenza. Sadeghi ha fondato l’azienda nel 2021, ispirato da un cugino morto a causa di una rara malattia genetica. Sostenuto da investitori e importanti imprenditori tecnologici come Peter Thiel e Alexis Ohanian – gli stessi che, con Sam Altman, supportano anche la startup Preventive – Sadeghi afferma che la sua azienda ha già aiutato migliaia di famiglie. Il servizio offerto da Nucleus Genomics per 30.000 dollari – noto come “IVF+” oppure “Nucleus Embryo” – propone di sequenziare il genoma completo dei genitori e fino a venti embrioni prodotti in vitro. Su ciascun embrione la compagnia calcola “punteggi poligenici”, ossia, stime probabilistiche della predisposizione a oltre 2.000 caratteristiche, che spaziano da malattie ereditarie gravi, patologie croniche come diabete o tumori, fino a tratti complessi come altezza, colore di occhi e capelli, quoziente intellettivo, rischio di depressione, autismo o disturbi comportamentali. Il risultato viene presentato ai genitori come una “classifica” di embrioni: sotto forma di grafici, percentuali e semafori, un’interfaccia che asseconda il desiderio di chiarezza e controllo. Secondo la startup, non si tratta di editing genetico, ma di “diagnosi genetica pre-impianto” avanzata: il DNA non viene modificato, ma semplicemente gli embrioni “esistenti” vengono ordinati in base a probabilità genetiche.
Molti esperti, però, mettono in guardia dalle promesse offerte: le previsioni poligeniche sono per loro natura probabilistiche, non certe. Un punteggio di rischio o predisposizione non equivale a una diagnosi e non garantisce che il bambino nascerà sano o “migliore”. La precisione delle previsioni, dicono i critici, è in larga misura illusoria, tanto più che le condizioni complesse come intelligenza, salute mentale o predisposizione a malattie croniche dipendono da decine o centinaia di variabili: genetiche, ambientali, casuali. La complessità delle informazioni, presentate come facili “scelte da menu”, rischia di essere spinta sul piano del marketing: un pacchetto “chiavi in mano” per fabbricare il figlio su misura, che seduce i committenti per la promessa di ottimizzazione genetica, senza affrontare onestamente l’incertezza e la variabilità biologica.
Il caso Nucleus Genomics va letto per quello che è: un cambio di paradigma antropologico, che sposta la fecondazione assistita dal piano terapeutico a quello selettivo, aprendo la strada a un’idea di umanità progettata e fabbricata in laboratorio. La promessa implicita non è la salute, ma la riduzione dell’imprevisto, dell’errore, della devianza. Un immaginario che richiama inevitabilmente scenari distopici come Gattaca di Andrew Niccol o Il mondo nuovo di Aldous Huxley, dove la programmazione biologica diventa norma e la disuguaglianza si naturalizza, dividendo la società in caste. In questo scenario, la riproduzione smette di essere un evento e diventa un processo industriale, accessibile a chi dispone di risorse economiche. Il nodo non è la tecnologia in sé, ma la logica di mercato che trasforma un figlio in merce, un prodotto su misura, valutabile, confrontabile, scartabile. Una logica infarcita dal credo transumanista, che sogna di abolire malattia, vecchiaia e morte, trasformando la vita in un codice da ottimizzare e potenziare a piacere. La scommessa di Nucleus Genomics e di chi segue questa traiettoria non riguarda il benessere umano, ma un’idea astratta di perfezione che confonde il possibile con il desiderabile e che rischia di cancellare proprio ciò che rende l’uomo tale: l’imperfezione, la complessità, l’imprevedibilità.
Ocse: l’Italia è prima in UE per aspettativa di vita
Nel 2024 l’aspettativa di vita in Italia ha raggiunto il record di 84,1 anni, il valore più alto nell’UE insieme alla Svezia e superiore di sei mesi ai livelli pre-pandemici, secondo il rapporto “EU Country Health Profiles 2025”. Le malattie cardiovascolari e i tumori costituiscono oltre metà dei decessi, mentre le morti prevenibili riguardano soprattutto cancro ai polmoni, Covid-19 e cardiopatia ischemica. Nonostante il rapido invecchiamento demografico, gli anziani italiani mostrano condizioni sanitarie migliori della media europea, pur persistendo criticità come ipertensione non diagnosticata o non trattata e un crescente tasso di fumatori.