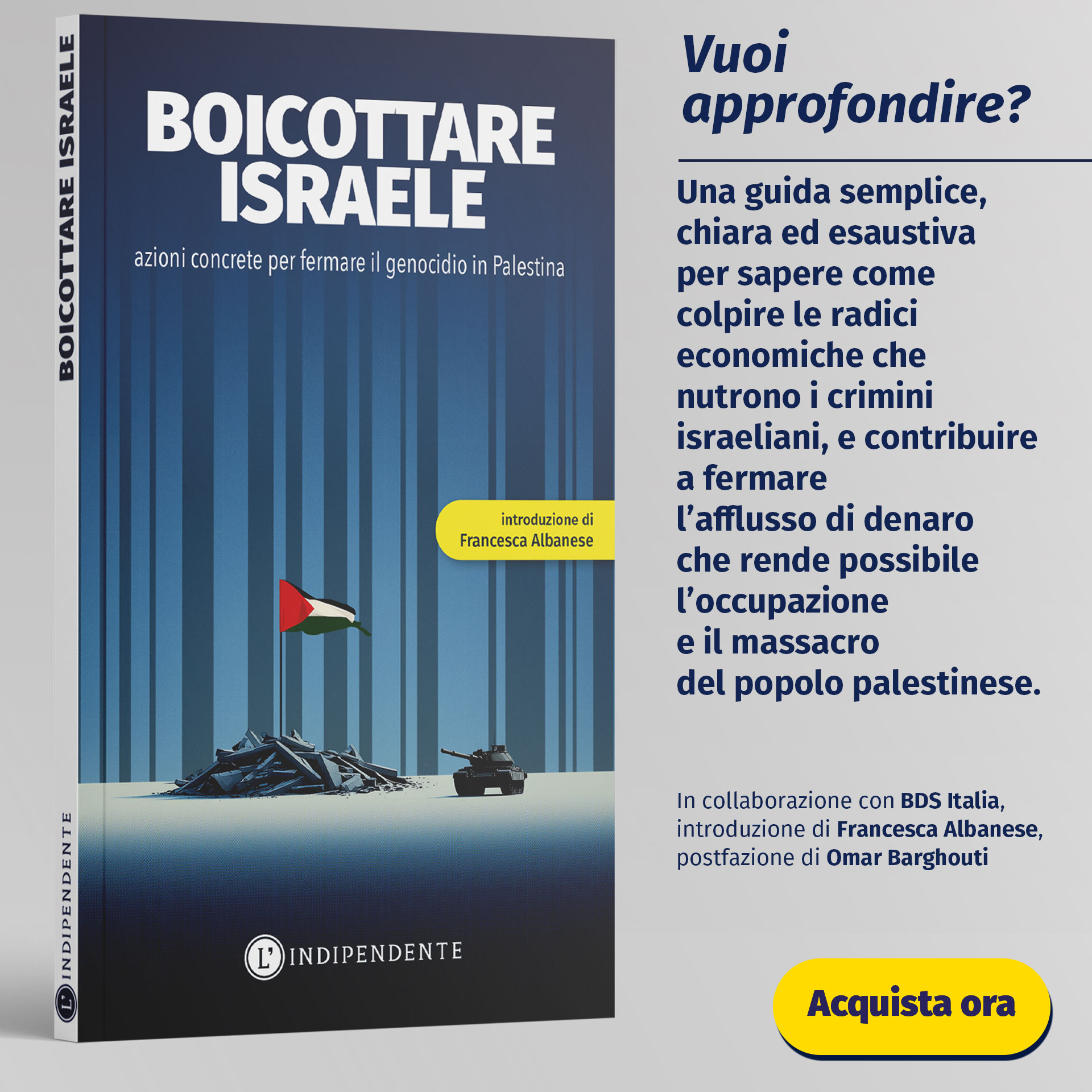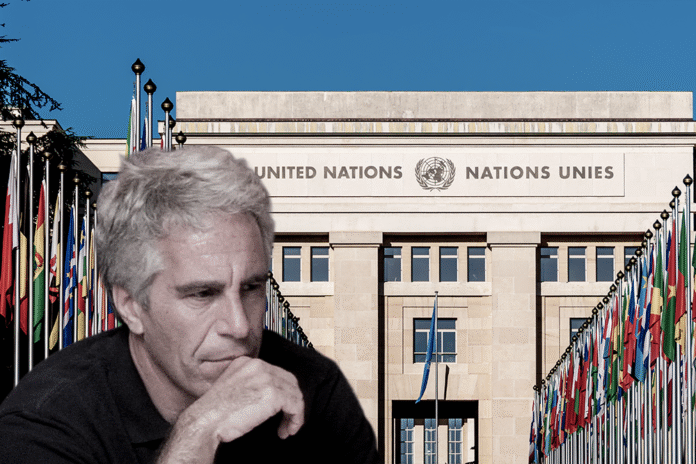Le autovetture moderne non sono più semplici mezzi di trasporto: sono diventate vere e proprie piattaforme informatiche su ruote dotate di decine di sensori e centraline in grado di registrare ogni aspetto dell’esperienza di guida. Dalle avarie ai percorsi effettuati, dalle accelerazioni brusche allo stato del manto stradale, fino alle abitudini dell’automobilista, tutto viene raccolto, archiviato e spesso trasmesso a soggetti terzi. Un vero e proprio tesoretto di dati che, poco sorprendentemente, è ormai sfruttato in modo sistematico da un’industria della sorveglianza la cui presenza si sta insinuando in ogni capillare della vita quotidiana.
L’ultimo esempio, in ordine di tempo, di questo fenomeno arriva da un’inchiesta di Haaretz, testata che è riuscita a ottenere alcune brochure promozionali dell’azienda israeliana Rayzone. Attraverso la sua sussidiaria TA9, la società commercializza un servizio avanzato capace di incrociare i dati raccolti dalle autovetture con le informazioni telefoniche delle SIM installate a bordo, le comunicazioni Bluetooth, le immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza poste lungo il percorso e tutti quegli elementi che potrebbero essere forniti dalle varie agenzie governative. Un pacchetto completo che va ben oltre la semplice raccolta e rivendita di dati, aprendo la strada a ciò che viene ormai definito in modo esplicito CARINT, car intelligence: un sistema integrato pensato per trasformare ogni veicolo in una fonte continua di informazioni operative.
Con l’avanzare dello sviluppo tecnologico, gli automobilisti hanno progressivamente perso porzioni sempre più ampie di controllo sulla propria vettura. L’aggiunta continua di nuove funzioni – raramente presentate come optional e quindi, di fatto, inevitabili – offre indubbi vantaggi: le app sul telefono permettono di aprire le portiere senza chiavi, la connessione costante con le aziende garantisce forme di assistenza immediata in caso di problemi, le telecamere multiple facilitano la guida e le manovre di parcheggio. Tuttavia, ogni nuovo componente introduce anche un ulteriore punto critico, un elemento che obbliga il proprietario del mezzo a riporre fiducia in chi detiene realmente la gestione dell’infrastruttura digitale del veicolo. E in molti casi, questa fiducia risulta malriposta.
Rimanendo sul semplice, esistono già esempi concreti di locomotive che si disattivano automaticamente quando sostano nei pressi di centri di riparazione non convenzionati con il rivenditore, o di trattori dotati di kill switch che consentono ai produttori di rendere il mezzo inutilizzabile in qualsiasi momento. Allo stesso modo, la presenza di telecamere sulle automobili – soprattutto quelle dotate di guida assistita – finisce per trasformare i veicoli in vere e proprie videocamere di sorveglianza su gomma. La CARINT, di contro, rappresenta un’evoluzione più sofisticata e invisibile: attinge ai Big Data per elaborare profilazioni e previsioni sull’identità e sulle intenzioni degli automobilisti, promettendo di riuscire a rintracciare singoli obiettivi anche impiegando elementi apparentemente insignificanti quali la posizione del sedile e le impostazioni dell’airbag.
Non si tratta, peraltro, di una tendenza remota o confinata a scenari da film di spionaggio. Restando in un contesto vicino all’Italia, la Stellantis guidata da John Elkann ha siglato nel 2022 una partnership di rilievo con Palantir, azienda specializzata nell’analisi dei dati e nella sorveglianza, a cui viene spesso attribuita – forse con eccessiva generosità – la localizzazione del rifugio di Osama Bin Laden. La collaborazione, estesa a tutte le controllate del gruppo, è formalmente pensata per ottimizzare la gestione degli stabilimenti, incrociando le informazioni relative ai magazzini, alle tendenze di mercato e ai dati generati dai vari segmenti della filiera produttiva. Tuttavia, le porte ad applicazioni ulteriori sono rimaste aperte.
“[Palantir Foundry] sarà inoltre impiegata in una serie di funzioni pensate per migliorare la qualità, garantire la stabilità della fornitura e del servizio in un contesto sempre più definito dalla distribuzione, oltre a continuare a incrementare i margini di guadagno”, recita il comunicato. “Per esempio, la capacità di analizzare attraverso Foundry miliardi di dati ottenuti dai veicoli connessi fornirà a Stellantis gli strumenti utili a prevedere eventuali problemi di qualità e a sfruttare le informazioni sullo stato dei veicoli per portare avanti i suoi obiettivi di ricerca e sviluppo”. Non resta che fidarsi di Elkann e Palantir che questi dati non vengano impiegati anche a fini terzi.