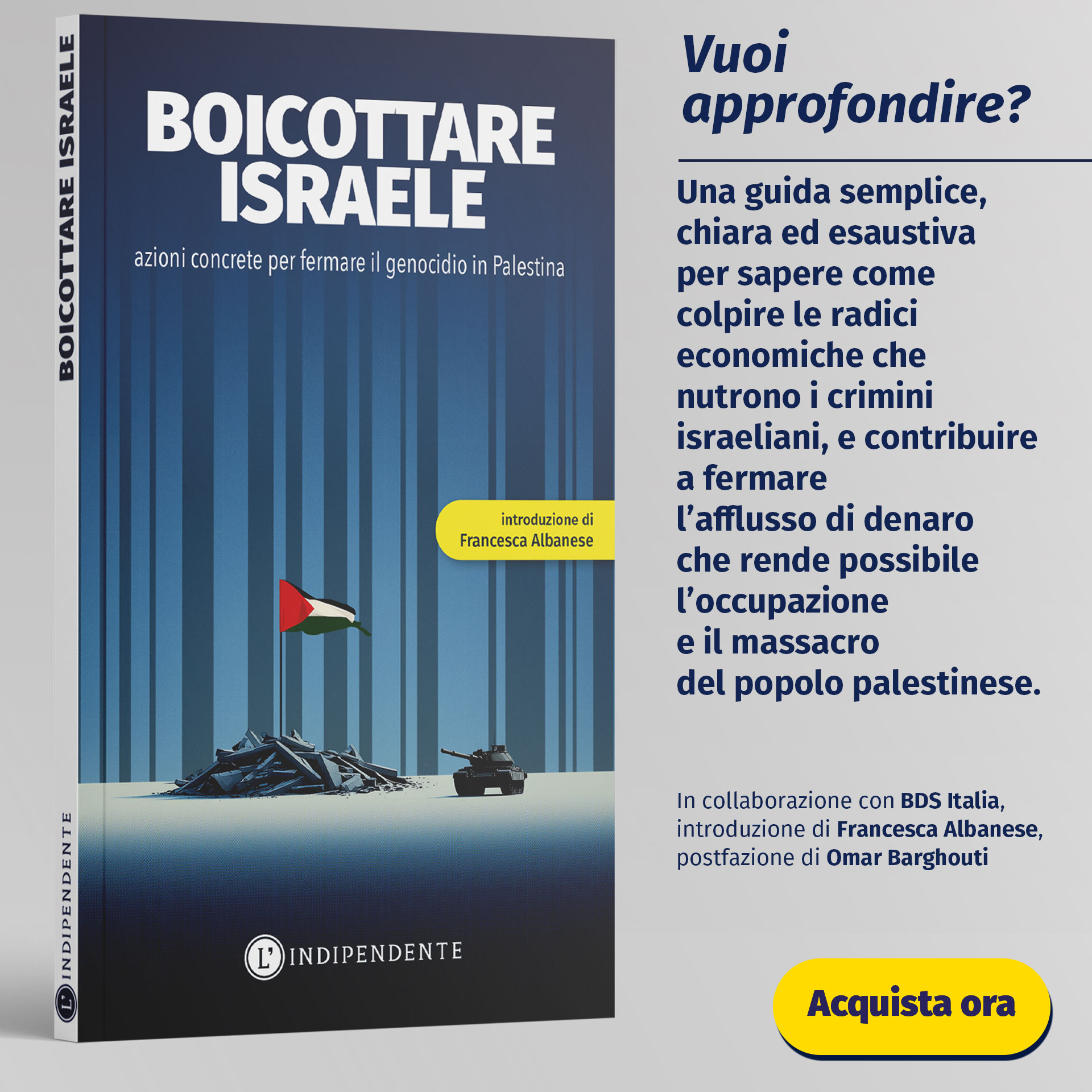Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2025, le forze ucraine hanno lanciato un massiccio attacco con droni e missili verso il territorio russo, reclamando il colpo a un impianto di munizioni nella regione di Nizhny Novgorod (Sverdlov), a un deposito di armi della 18ª Armata e a un terminal petrolifero in Crimea. Secondo lo Stato maggiore ucraino, gli attacchi avrebbero provocato esplosioni multiple, incendi e danni all’infrastruttura logistica dell’industria bellica russa. Le autorità russe – pur riconoscendo di aver subito un “attacco su 14 regioni”, comprese zone attorno al Mar Nero e al Mar d’Azov – sostengono che le loro difese aeree abbiano intercettato 251 droni. Gleb Nikitin, il governatore di Nizhny Novgorod ha precisato che l’impianto di munizioni non avrebbe subito danni rilevanti, rivendicando che le difese abbiano deviato i droni verso aree industriali. Contestualmente, fonti russe indicano che un terminal petrolifero in Crimea è stato colpito, causando un incendio: l’obiettivo strategico, secondo gli ucraini, era ampliare la pressione sulle risorse energetiche russe. L’episodio rientra in una strategia ucraina ormai consolidata: intensificare gli attacchi alla rete di approvvigionamento russa, danneggiare il complesso militare-industriale dell’avversario e dimostrare un’autonomia crescente nella produzione di armi – che si sarebbe addirittura triplicata – in particolare droni. Nelle ultime settimane, attacchi simili si sono ripetuti: tra questi, un attacco a un impianto chimico del Perm Krai e incendi in raffinerie vicino a San Pietroburgo (Kirishi) sono stati segnalati da fonti russe.
Considerate le scarse possibilità che l’Ucraina entri a far parte della NATO, gli alleati occidentali hanno adottato una strategia alternativa per aiutare Kiev a respingere l’aggressione russa: investire miliardi nell’industria bellica ucraina, in modo che possa difendersi meglio. Un recente progresso nell’arsenale interno ucraino è un drone quadrirotore in grado di eludere i dispositivi di disturbo russi, volare per oltre 20 chilometri e sganciare sei chilogrammi di esplosivo guidato su carri armati e altri obiettivi di alto valore. La risposta di Mosca non si è fatta attendere. Le autorità russe hanno condannato gli attacchi come atti di “terrorismo” e di “escalation”, avvertendo che qualsiasi sostegno europeo all’Ucraina – sia diplomatico, sia militare – sarebbe considerato un coinvolgimento diretto nella guerra. Il presidente Vladimir Putin ha ammonito che la Russia reagirà con “forza significativa” se l’Occidente proseguirà nell’armare Kiev. Intervenendo giovedì 2 ottobre al Club Valdai a Sochi, sul Mar Nero, il leader russo aveva già ammonito l’Alleanza Atlantica: «Nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che le contromisure della Russia non tarderanno ad arrivare». In sedi internazionali, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha ribadito che Mosca «non intende attaccare l’Europa», ma che risponderà in modo “decisivo” alle provocazioni. Il clima è già molto teso: oltre alle continue notizie di voli sospetti di droni in vari Paesi europei, intrusioni aeree e manovre belliche, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump si trova a dover decidere se inviare inviare i missili a lunga gittata Tomahawk in Ucraina. Il tycoon ha dichiarato di aver «già preso una decisione, più o meno», ma di voler prima capire come verranno utilizzati. Intanto, Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha affermato che resta un mistero chi si cela dietro le incursioni dei droni che hanno interessato gli aeroporti europei, ma che tali episodi devono servire da “monito” ai cittadini europei sui pericoli della guerra. Mosca sottolinea che, se l’Europa continuerà a fornire sistemi missilistici, intelligence e assistenza militare all’Ucraina, finirà per essere considerata parte del conflitto stesso – una linea che richiama discorsi già emersi nei mesi precedenti.
Se l’attacco ucraino risultasse confermato nei suoi effetti, non si tratterebbe soltanto di un’azione militare isolata, ma di un cambio di paradigma: l’Ucraina che colpisce profondamente nella Federazione russa e sfida i principi e soprattutto i confini della “non interferenza”. Ciò mette l’Europa in una posizione delicata: chiudere gli occhi significherebbe accettare che il conflitto stia già varcando le sue frontiere. Le reazioni politiche non si fanno attendere: i leader di Bruxelles discutono ormai apertamente della necessità di rafforzare le difese dell’Unione e un esempio concreto lo abbiamo avuto nelle scorse settimane con l’operazione Sentinella dell’Est, ma si teme che la linea tra sostegno a Kiev e coinvolgimento diretto diventi sempre più labile. Un nodo cruciale rimane la politica delle armi: finora molti Stati europei hanno evitato di autorizzare l’uso dei propri sistemi su obiettivi russi, ma l’attenzione strategica di Kiev si sposta sempre più su obiettivi logistici e infrastrutturali del nemico. Zelensky e le autorità di Kiev insistono che i recenti raid sono stati condotti con armamenti di produzione nazionale, per dimostrare la propria autonomia, ma anche per rispondere alle critiche occidentali sul rischio di scatenare una escalation. Per l’Europa, la sfida è trovare un equilibrio tra la volontà di non essere trascinata nel conflitto come parte attiva e la necessità di continuare a mostrare un sostegno concreto all’Ucraina. Qualsiasi decisione comporterà conseguenze strategiche e morali, mentre Mosca avverte l’Europa che non sarà “spettatrice” e invita i governi di Bruxelles a scegliere da che parte stare, prima che il conflitto decida da sé.