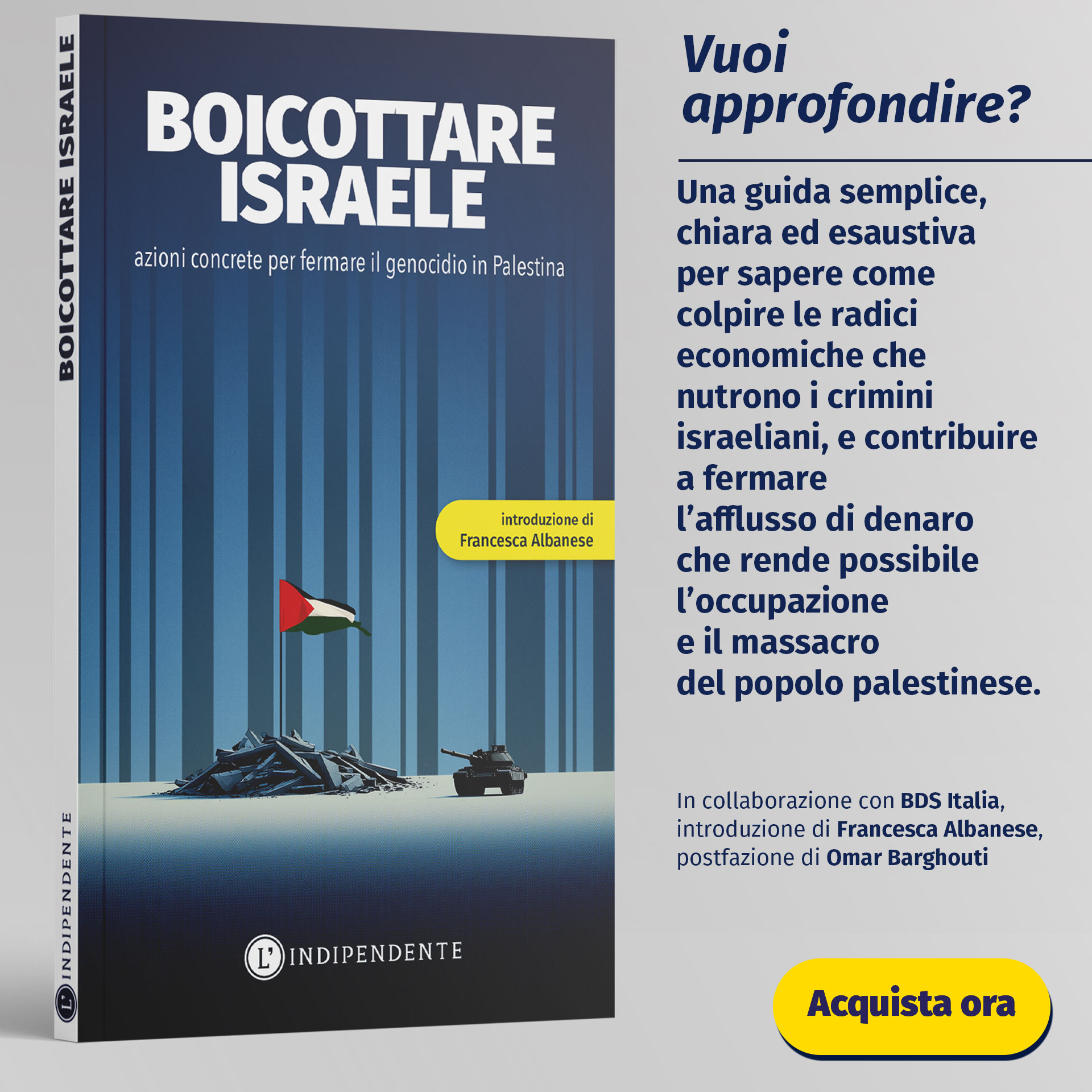Secondo i dati Eurostat relativi al 2024, in Italia più del 10% dei lavoratori è a rischio di povertà, un dato in aumento rispetto all’anno precedente e superiore alla media europea. Il fenomeno interesserebbe in particolare i cosiddetti “working poor”, cioè persone con un impiego ma con reddito insufficiente a condurre una vita dignitosa. L’analisi dell’Osservatorio Antoniano, che tramite la campagna Operazione Pane ha registrato un aumento del 14% delle persone con lavoro che hanno chiesto aiuto nel periodo gennaio-settembre 2025 rispetto al 2024.
Gaza, la tregua farsa: Israele ha attaccato 497 volte uccidendo 342 palestinesi
Da quando è iniziato il cessate il fuoco a Gaza, il 10 ottobre scorso, Israele ha compiuto 497 attacchi, violando la tregua e uccidendo almeno 342 palestinesi. È quanto afferma l’Ufficio Stampa del governo di Gaza, che ricorda come questi atti costituiscano una violazione delle norme del diritto internazionale e umanitario. Il rapporto non tiene conto delle violazioni commesse tra ieri e oggi, 24 novembre, perché pubblicato nella giornata di sabato. Israele insiste nell’attribuire la colpa dei suoi attacchi a presunte violazioni di Hamas, che avrebbe attaccato i soldati israeliani nella Striscia o attraversato la cosiddetta “Linea Gialla”, la linea di demarcazione dietro la quale i soldati israeliani dovrebbero rimanere stazionati. Hamas ha negato che tali violazioni siano mai accadute.
I numeri forniti dall’Ufficio si basano sulle ricostruzioni giornaliere di ospedali, giornalisti, e Protezione Civile gazawi, ma anche sulle testimonianze di civili, organizzazioni umanitarie, uffici di monitoraggio, e programmi di aiuto presenti a Gaza. Con il rapporto di sabato, l’Ufficio documenta le 497 violazioni che Israele avrebbe commesso nell’ultimo mese e mezzo di tregua classificandole per categoria: in 142 casi, scrive l’Ufficio, i soldati israeliani avrebbero sparato «direttamente» contro i civili palestinesi; in 21 casi i veicoli militari israeliani avrebbero oltrepassato la linea gialla; 100 sarebbero attacchi contro abitazioni e strutture civili; infine 228 sarebbero operazioni di bombardamento aereo o terrestre – mediante colpi di artiglieria o carri armati. Delle 497 violazioni, 27 sarebbero avvenute nella sola giornata di sabato, quando 24 palestinesi (inclusi numerosi bambini) sarebbero stati uccisi e altri 87 feriti. Nel suo comunicato, l’Ufficio condanna «fermamente le violazioni che l’occupazione israeliana continua a perpetrare contro i civili e le infrastrutture civili, in palese violazione di tutti gli obblighi legali e morali», e chiede al presidente Trump, ai Paesi mediatori, ai garanti dell’accordo e al Consiglio di Sicurezza dell’ONU di «adottare misure serie ed efficaci per fermare questi attacchi, porre fine all’assedio in corso e far rispettare il cessate il fuoco e il protocollo umanitario».
Gli attacchi sono continuati sia domenica che oggi. Ieri, gli ospedali hanno affermato di avere ricevuto 23 corpi di palestinesi, 2 dei quali recuperati dalle macerie; a questi ultimi se ne sono aggiunti altri 8 nella giornata di oggi, trovati presso il campo di Maghazi, nel Governatorato di Deir al Balah, che hanno portato a 582 le salme di palestinesi rinvenute sotto i detriti. Sempre oggi sono stati segnalati casi di violenza in tutta la Striscia: nel Governatorato di Nord Gaza, Israele avrebbe scagliato attacchi aerei e colpi di artiglieria oltre la linea gialla della città di Beit Lahia, e ferito due civili a Jabaliya, colpendoli con colpi di arma da fuoco; a Gaza City, le Forze di Difesa Israeliane avrebbero ucciso un palestinese nei pressi del quartiere di Tuffah, a est della città, e fatto levare in aria i droni nell’area orientale della capitale; droni anche nel Governatorato di Khan Younis, nella città orientale di Bani Suheila, dove sarebbe stato ucciso un palestinese; sempre a est di Khan Younis sono stati segnalati colpi di artiglieria che avrebbero ucciso un’altra persona, mentre a sud del Governatorato i mortai non avrebbero fatto vittime. Attacchi, infine, anche a nordest di Rafah, il governatorato più a sud della Striscia, dove Israele avrebbe utilizzato elicotteri e carri armati.
Agli attacchi si aggiunge la situazione umanitaria che, nonostante il cessate il fuoco, rimane ancora critica. Nel fine settimana le varie agenzie dell’ONU come il Programma Alimentare Mondiale e l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (nota come UNRWA) hanno lanciato diversi appelli, rimarcando la necessità di fare ripartire il sistema scolastico per far fronte alla ormai incombente crisi educativa; le agenzie hanno poi sottolineato come, nonostante gli oltre 40 giorni di cessate il fuoco, l’accesso sicuro all’acqua potabile rimanga ben lontano dall’essere garantito, e affermato che i cittadini soffrano ancora la mancanza di cibo.
Regionali: Campania e Puglia al campo largo, Veneto alla destra
Nonostante manchi ancora l’ufficialità, tutte le proiezioni danno ormai per certi gli esiti delle elezioni regionali tenutesi tra ieri e oggi, 24 novembre, in Campania, Puglia e Veneto. Le prime due regioni hanno visto trionfare i candidati del campo largo, rispettivamente Roberto Fico del M5S, in questo momento primo con il 62,49% delle preferenze, e Antonio Decaro del PD, con il 65,39% dei voti. In Veneto, invece, si è imposto il candidato della coalizione governativa, Alberto Stefani, in questo momento in vetta con il 63,62%. Netto calo per l’affluenza in tutte e tre le regioni: -11,46% in Campania, -14,61% in Puglia e -16,51% in Veneto.
Brasile: confermato il carcere a Bolsonaro
Un collegio di quattro giudici della Corte Suprema brasiliana ha votato per trattenere l’ex presidente Jair Bolsonaro in custodia cautelare in carcere. I giudici hanno approvato la misura all’unanimità, confermando la disposizione del collega Alexandre de Moraes, che ne aveva ordinato l’arresto a causa di una violazione dei domiciliari. Bolsonaro è stato condannato a una pena di 27 anni e 3 mesi per il tentato golpe militare del 2022; nonostante ciò, si trovava ancora in custodia cautelare ai domiciliari, perché secondo la legge brasiliana per scontare la pena in prigione è necessario concludere tutto l’iter processuale, e all’ex presidente manca ancora la pronuncia della Corte Suprema.
Dalle spiagge agli ippodromi: il nuovo tour di Jovanotti fa infuriare gli animalisti
Dopo le spiagge, gli ippodromi: nel cercare location alternative in cui organizzare concerti, a Jovanotti e al suo team l’idea di questo nuovo tour deve essere sembrata irresistibile. Agli animalisti un po’ meno. E infatti, dopo l’annuncio delle date del “Jova Summer Party 2026”, che prevede due concerti in due differenti ippodromi, sono partite le proteste che sottolineano come i decibel di un concerto mal si concilierebbero con la presenza di animali come i cavalli, che potrebbero patire diverse conseguenze problematiche.
«Siamo basiti nell’apprendere che viene organizzato un concerto che accoglierà migliaia di persone dentro un ippodromo, a pochi metri dai box dove sono alloggiate decine di cavalli, animali che potrebbero andare nel panico e ferirsi per il grande e prolungato rumore a cui non sono abituati e che, nella migliore delle ipotesi, subiranno un forte stress», sottolinea il presidente di Italian Horse Protection Sonny Richichi, associazione indipendente per la tutela di questi animali. «Possiamo anche immaginare che gli organizzatori si siano fidati delle parole di chi gestisce l’ippodromo il quale, da opportunista che passa sopra il benessere dei cavalli per racimolare qualche soldo, avrà rassicurato tutti, raccontando la favola che i cavalli sono abituati al frastuono e che non si spaventano. Ma questo non giustifica una decisione che andava ponderata meglio, non basandosi solamente su chi i cavalli li sfrutta».
Il riferimento è probabilmente al comunicato stampa dell’ippodromo di Palermo La Favorita, che dovrebbe appunto ospitare uno dei due concerti della prossima estate, nel quale gli organizzatori spiegano che «le misure di tutela sono già previste». Inoltre evidenziano che «dai rilievi fonometrici effettuati e stante la notevole distanza del palco rispetto alle scuderie – pari a oltre 500 metri – si rimane ampiamente sotto la soglia di normale tollerabilità per gli animali». Infine, secondo il veterinario della struttura, il dottor Salvatore Speciale: «La musica non nuoce agli animali, che dimostrano di tollerarla e gradirla senza alcuno stress. Il vero pericolo per i cavalli è rappresentato da rumori improvvisi e violenti come i fuochi d’artificio».
Di diverso avviso il presidente di Italian Horse Protection che rincara la dose, spiegando che i cavalli: «Hanno un udito finissimo, molto più sensibile di quello umano, e possono andare nel panico se avvertono segnali di pericolo e se non hanno la possibilità di fuggire in campo aperto. Chiusi all’interno di un box e bombardati dai decibel del concerto e dalle urla del pubblico, non è difficile immaginare cosa passeranno quei poveri animali. Già sono sottoposti a una vita innaturale qual è quella dell’ippodromo, e in più devono subire quella che noi, senza mezzi termini, definiamo una vera e propria violenza». E quindi rivolgono un accorato appello a Jovanotti, chiedendogli di scegliere posti alternativi, «dove la festa non comporti la sofferenza di nessun animale».
Le polemiche precedenti si erano infuocate nella calda estate del 2022, quando erano in corso i concerti del “Jova beach party” tour. L’evento di Fermo, in particolare, aveva suscitato non poche polemiche, con i controlli dell’Ispettorato del lavoro che avevano fatto emergere la presenza di diversi lavoratori in nero e la devastazione ambientale causata dalla distruzione della vegetazione delle dune di sabbia per far posto al palco che aveva portato alla protesta di diversi comitati ambientalisti, compresa la sezione del WWF locale che aveva chiuso i battenti in aperta polemica con il WWF nazionale, che aveva invece supportato l’iniziativa.
Belgio, sciopero di tre giorni: treni fermi
In Belgio è stato lanciato uno sciopero generale per protestare contro le misure di austerità del governo, che includono anche un aumento dell’età pensionabile. A proclamare la protesta sono state tre delle maggiori firme sindacali del Paese che hanno organizzato manifestazioni per tre giorni consecutivi: oggi sciopereranno i lavoratori del settore dei trasporti pubblici, e le ferrovie prevedono di far funzionare un treno su tre. Domani non verranno garantiti i servizi pubblici di scuole, asili nido e ospedali, e dopodomani il personale aeroportuale si unirà alla protesta, tanto che gli aeroporti di Bruxelles-Zaventem e Charleroi, i due principali scali del Paese, hanno già cancellato tutti i voli.
Pedemontana Veneta: rischi PFAS nell’acqua noti da mesi ma tenuti nascosti
Per mesi sarebbe stata nascosta alla popolazione una grave contaminazione da PFBA, sostanze perfluoroalchiliche derivate dai cantieri della Pedemontana Veneta che stanno inquinando le falde acquifere del Vicentino. L’allarme è stato lanciato dal Comitato Tuteliamo la Salute, che ha reso pubblici documenti ufficiali dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (Arpav) in cui si evidenziano concentrazioni di PFBA fino a 2.212 nanogrammi per litro in alcune cave utilizzate come discariche per i materiali di scavo della superstrada. Nonostante la comunicazione dell’agenzia ambientale ai Comuni risalga al 19 maggio 2025, i cittadini non sarebbero stati informati del rischio, in particolare a Montecchio Precalcino, dove il sindaco avrebbe minimizzato l’emergenza.
«Il Comune di Montecchio Precalcino conosceva la situazione Pfas già da maggio»: è questa l’accusa centrale del Comitato, che durante una conferenza stampa ha presentato documentazione inerente la contaminazione. Il 19 maggio scorso l’Arpav aveva infatti inviato una comunicazione a Regione, gestori acquedottistici, ULSS, Provincia di Vicenza e comuni di Montecchio Precalcino e Marano Vicentino, in cui si parlava esplicitamente di un «rinvenimento di sostanze perfluoroalchiliche (PFBA) nell’acquifero sotterraneo del medio-alto vicentino e nei pozzi acquedottistici». Le indagini Arpav hanno focalizzato tre aree — Cava Vianelle (Marano Vicentino), Discarica Terraglioni e Cava Cavedagnona (entrambe a Montecchio Precalcino) — dove sono stati conferiti complessivamente volumi significativi di terre da scavo. Le analisi rilevano «di PFBA nelle acque di dilavamento, con punte anche superiori a 2.000 ng/l, parametro in generale preponderante rispetto ad altri PFAS», con misure isolate che arrivano a 2.212 ng/l nella cava Cavedagnona, 826 ng/l a Vianelle e 643 ng/l alla discarica Terraglioni. Numeri che, se estesi alla falda e alle reti di captazione, avrebbero conseguenze gravi per la potabilità.
Il comitato sottolinea un quadro idrogeologico preoccupante. «A seguito delle elaborazioni idrogeologiche dell’acquifero vicentino e delle relative direttrici di flusso sotterraneo, si evidenzia uno scenario di progressiva contaminazione da PFBA nell’acquifero vicentino proveniente da nord, non meglio identificato», si legge in un documento Arpav del 12 novembre. Ciò significa che, avverte il Comitato, la propagazione potrebbe investire aree contigue, compresi pozzi di captazione utilizzati per l’acquedotto di Padova e numerosi pozzi privati in comuni come Dueville, dove circa 13.000 persone dipendono da prelievi non sempre soggetti a controlli regolari.
La polemica politica è tutta intorno al comportamento delle amministrazioni locali: mentre il sindaco di Marano ha informato enti e cittadini, il Comitato accusa l’amministrazione di Montecchio Precalcino di aver «sottaciuto l’emergenza ambientale e sanitaria che gli è stata comunicata da Arpav», nonostante una delibera comunale del 7 aprile che chiedeva il bando dei PFAS sul territorio. In parallelo, associazioni ecologiste come Covepa denunciano che i siti di conferimento sono molti più di quelli ufficialmente dichiarati — si parla di decine di «hot spot» — e che i monitoraggi rimangono «incompleti», con reti piezometriche spesso assenti.
Il Comitato ha denunciato anche il conferimento di 30.600 m3 di materiale contaminato nella Cava Brugiane, di proprietà di Silva Srl, nonché la presenza di PFBA nelle acque sotterranee dei piezometri di valle della discarica Terraglioni di Montecchio Precalcino. Questo ha spinto il Comitato a scrivere alla Provincia di Vicenza chiedendo di bloccare nuovi insediamenti nell’area e di avviare studi e bonifiche «Il Comitato Tuteliamo la Salute, dopo aver consultato esperti di Diritto ambientale, ritiene che sia ormai necessario e doveroso non aggiungere un nuovo insediamento così impattante come quello proposto da Silva in un’area già martoriata che andrà monitorata per gli anni a venire». Il Comitato conclude chiedendo interventi immediati: «Chiediamo che le istituzioni intervengano per tutelare la popolazione ed il territorio con gli opportuni interventi di studio, bonifica e risanamento delle zone in cui è già stato riscontrato inquinamento da PFAS».
Nel frattempo, il mese scorso la Procura di Vicenza ha chiuso le indagini sulla Superstrada Pedemontana Veneta, accusando 12 persone, tra manager del Consorzio SIS, amministratori della Strada Pedemontana Veneta S.p.A., direttori tecnici e responsabili di cantiere, di inquinamento ambientale e omessa bonifica. Nello specifico, l’inchiesta riguarda i lavori svolti dal 28 giugno 2021 al 23 gennaio 2024 per le gallerie di Malo e di Sant’Urbano (Vicenza). Secondo le ipotesi, gli indagati non avrebbero rispettato le prescrizioni tecniche relative alla composizione del calcestruzzo, impiegando un accelerante contenente PFBA in concentrazioni superiori a quanto consentito, provocando contaminazione delle acque superficiali e sotterranee nei comuni di Castelgomberto, Malo, Montecchio Maggiore, Isola Vicentina e Costabissara.