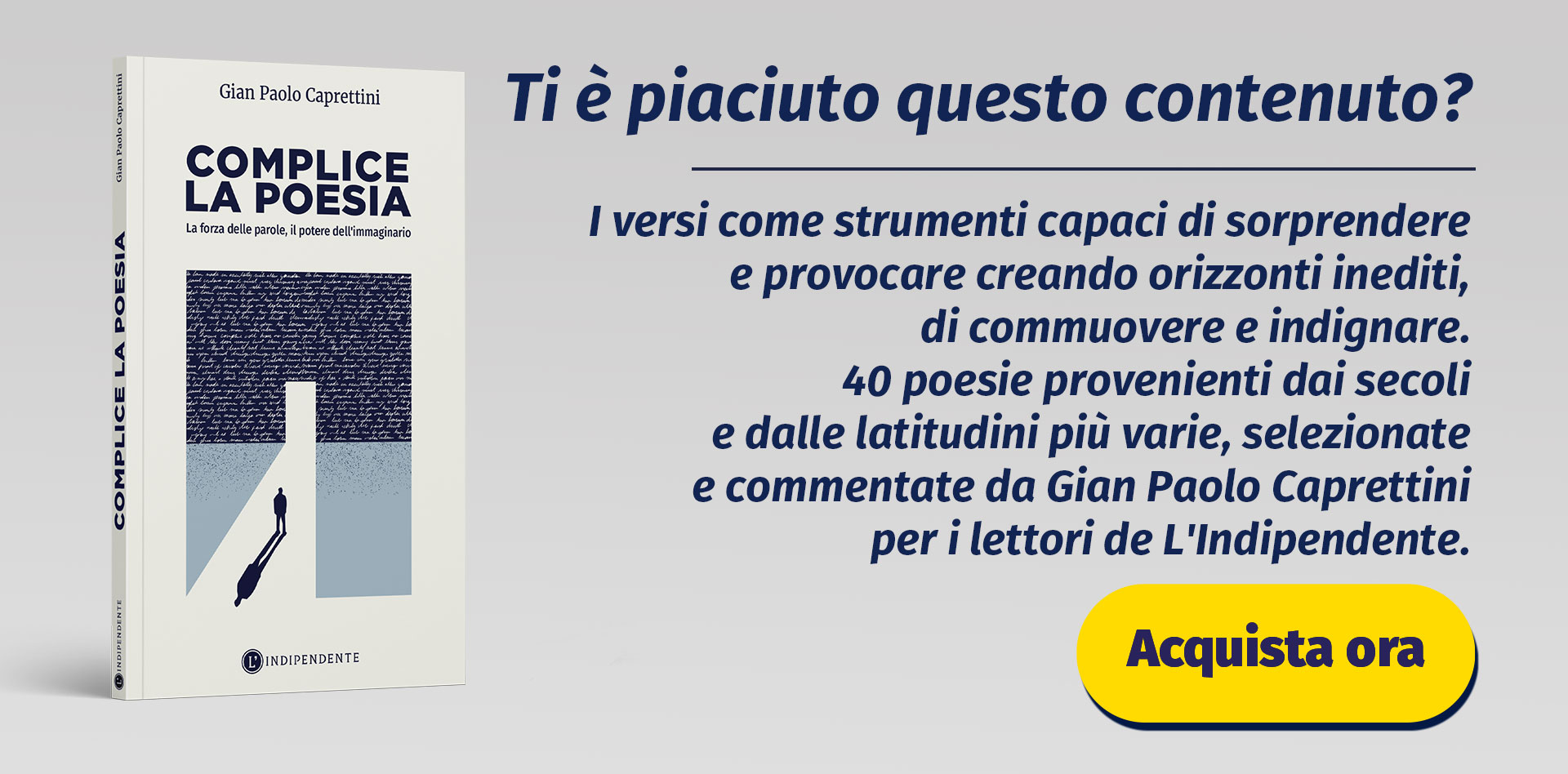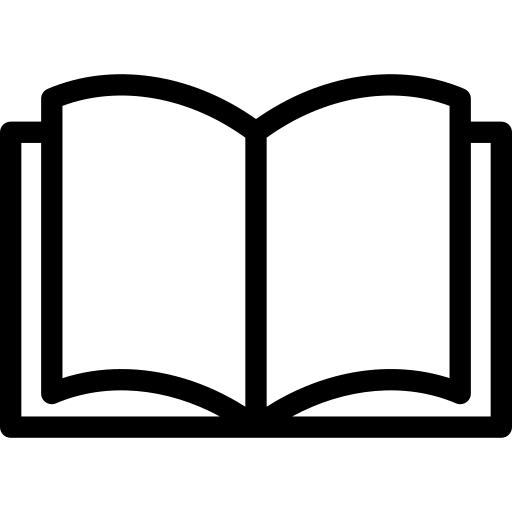A poche ore dalla bocciatura della Corte Suprema, il presidente USA rilancia la sua politica commerciale. Trump cambia la base giuridica, facendo appello al Trade Act del 1974, e dispone nuovi dazi compresi tra il 10% e il 15% per un periodo di 150 giorni. «Nel corso dei prossimi pochi mesi, l’amministrazione Trump emetterà nuove tariffe legalmente ammissibili, che proseguiranno il nostro straordinario processo di successo per rendere l’America di nuovo grande», ha aggiunto il presidente USA, criticando la sentenza della Corte Suprema.
Omicidio Mansouri: nuovi indizi contro i poliziotti per omicidio volontario e depistaggi
Sono tanti, tantissimi gli elementi che non tornano nella versione resa dalle forze dell’ordine sull’uccisione di Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino morto a causa di un colpo di pistola alla tempia il 26 gennaio scorso nel bosco di Rogoredo a Milano. Secondo quanto ricostruito dai pubblici ministeri, infatti, l’agente più vicino a Carmelo Cinturrino – il poliziotto che ha sparato – si sarebbe allontanato dalla scena subito dopo il colpo per recarsi al commissariato Mecenate, dove le telecamere lo hanno ripreso mentre entrava a mani vuote e usciva con uno zaino. Gli investigatori sospettano che al suo interno ci fosse la pistola a salve successivamente ritrovata accanto al corpo di Mansouri e che l’arma sia stata posizionata lì per giustificare la “reazione” dell’assistente capo. Dalle rilevazioni è inoltre emerso come Mansouri sia stato colpito mentre era già voltato, mentre i soccorsi sarebbero stati chiamati con ben 23 minuti di ritardo.
Centrale nell’indagine è la ricostruzione dei minuti successivi allo sparo. Mentre Mansouri era a terra, ancora agonizzante, uno degli agenti si allontanava verso il commissariato. Al suo rientro, sarebbe spuntata la pistola finta — una riproduzione di una Beretta 92 — che Cinturrino ha sempre indicato come l’arma che la vittima gli avrebbe puntato contro, spingendolo a sparare «per paura». Le analisi scientifiche stanno però già offrendo elementi dissonanti rispetto a questa versione: sulla pistola, infatti, sarebbero stati isolati due profili genetici diversi, senza che siano state rinvenute impronte riconducibili a Mansouri. Il poliziotto che si era recato al commissariato ha poi raccontato sotto interrogatorio: «Mi ha detto di tornare in commissariato a prendere lo zaino. Non l’ho aperto, non sapevo cosa ci fosse dentro». L’autopsia ha inoltre evidenziato che il colpo è entrato dall’osso parietale destro, segno che il 28enne fosse girato al momento dello sparo, e sul suo volto sono state riscontrate ecchimosi e lividi, compatibili con una caduta a faccia in avanti. Sul giubbotto, inoltre, sarebbe ben visibile l’impronta di una scarpa.
Altro elementi fondamentale concerne l’analisi dei telefoni: Mansouri, nel momento in cui è stato ucciso, stava parlando con un pusher, il quale lo avvisava dell’arrivo dei poliziotti. Pochi secondi dopo, lo spacciatore effettuò una nuova chiamata a Mansouri, ma non ottenne nessuna risposta. Quattro colleghi di Cinturrino, sotto inchiesta per favoreggiamento e omissione di soccorso, sono stati ascoltati nella giornata di giovedì. Essi avrebbero fornito versioni tra loro concordanti, descrivendo l’assistente capo 41enne come una sorta di «fanatico» che gestiva le operazioni nel boschetto della droga «col pugno duro» e che, pur non essendo il più alto in grado, avrebbe preso il controllo della situazione subito dopo la sparatoria. Alcuni di loro avrebbero anche riferito di abituali pestaggi ai pusher e di arresti eseguiti con eccessiva «disinvoltura».
L’inchiesta sta però pescando anche dal passato di Cinturrino, sul quale pende già un fascicolo per falso legato a un verbale di arresto del maggio 2024. In quel frangente, una telecamera lo aveva immortalato mentre estraeva e intascava banconote dalla cover del cellulare di uno spacciatore tunisino, una quantità di denaro di gran lunga superiore a quella poi dichiarata negli atti ufficiali. A fine gennaio, inoltre, è arrivata negli uffici dei pm un’informativa dei carabinieri su una confidenza: in piazzale Ferrara, zona Corvetto, esisterebbe un appartamento utilizzato come base per lo spaccio da due italiani, i quali godrebbero «della protezione di un poliziotto, un certo Carmelo, amico della portinaia del condominio». Secondo la stessa fonte, l’agente avrebbe anche chiesto «alcune migliaia di euro» a un pusher originario del Marocco per autorizzarlo a inserirsi nella piazza.
Nel frattempo, col passare dei giorni, anche il fronte politico che subito aveva espresso piena solidarietà ai poliziotti ha iniziato a mostrare crepe. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ora affermato: «Sono compiaciuto che la polizia di stato sia in grado di fare chiarezza e di non fare sconti a nessuno, di saper dare la migliore risposta a chiunque metta in dubbio la capacità di poter fare chiarezza anche al proprio interno. Poi noi accetteremo con assoluta serenità quello che emergerà». Dopo aver parlato di un «poliziotto» che «si difende» e di un «balordo» che «muore», il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini ha dichiarato: «se qualcuno sbaglia, va accertato». Per lunedì è attesa una riunione decisiva in procura tra il pm Tarzia e il procuratore Marcello Viola per definire i prossimi passi dell’inchiesta.
Banca d’Italia: “bisogna puntare sull’euro digitale”
Dall’Assiom Forex di Venezia, il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha dichiarato che «In Italia serve un nuovo modello economico. Si deve puntare sul digitale», a partire dall’euro. Al vertice economico, Panetta ha commentato anche la crescita del PIL degli ultimi anni, definendola «insufficiente a colmare le carenze strutturali» del Paese. Il governatore della Banca d’Italia ha così posto l’attenzione sui salari bassi e sulla necessità di migliorare la produttività. «Difficile una rottura economica con gli USA — ha inoltre commentato Panetta — dal momento che dominano in difesa, tecnologia e finanza».
OpenClaw si sta diffondendo velocemente, sollevando preoccupazioni
Il modello open‑source di OpenClaw è diventato il protagonista indiscusso di un’ascesa stellare. Nato per permettere lo sviluppo di agenti di IA direttamente sui dispositivi degli utenti, si è trasformato in breve tempo in un fenomeno performativo: spesso più spettacolare che utile, ma capace di catalizzare l’attenzione del pubblico e, soprattutto, delle grandi aziende tecnologiche. Passato sotto l’ombrello di OpenAI, azienda leader del settore, il progetto sembra ora destinato a un’espansione esponenziale e questo nonostante le sue evidenti criticità di sicurezza. Una prospettiva che sta allarmando osservatori, ricercatori e corporate, preoccupati dall’impatto di un sistema tanto potente quanto ancora privo di adeguate garanzie.
La tecnologia è stata lanciata nel novembre 2025 con il nome di Clawdbot, un’etichetta dal tono leggero che giocava sulla parola claw – “chela” in inglese – e che richiamava al contempo anche il noto bot Claude di Anthropic. Un parallelismo forse troppo evidente, tanto che il progetto è stato presto ribattezzato Moltbot e, infine, OpenClaw: un nome che richiama al tempo stesso la sua natura open‑source e l’ormai consolidato ecosistema di OpenAI. Fin dalle prime versioni, OpenClaw è entrato rapidamente nel radar di chi sperimenta con gli agenti di intelligenza artificiale, sia in ambito privato sia aziendale. La notorietà pubblica, però, è arrivata solo con la popolarità di Moltbook, il social network riservato alle IA, che ha trasformato il progetto in un fenomeno virale. E con la viralità è giunto il successo.
Domenica 15 febbraio, il fondatore di OpenClaw, Peter Steinberger, è stato arruolato nelle fila della società guidata da Sam Altman; un’operazione che arriva in un momento delicato per la società, la quale è impegnata a riaffermare la propria competitività in un settore sempre più affollato e in un clima in cui iniziano a emergere dubbi sulla sua traiettoria, mentre anche la fiducia dei partner storici mostra segni di incrinatura. Per entrambe le parti si tratta dunque di un’intesa di grande valore: Steinberger può contare sul supporto di una delle realtà più influenti dell’IA per proseguire la sua ricerca, mentre OpenAI può attingere alla sua esperienza per esplorare soluzioni agentiche che, al momento, restano difficili da replicare per la concorrenza. Allo stesso tempo, l’unione rientra nell’ormai consolidato modello imprenditoriale del “move fast and break things”, nel dare la priorità alla velocità a discapito della sicurezza.
Attingendo direttamente ai dati presenti sul dispositivo su cui vengono eseguiti, gli agenti di OpenClaw possono accedere a tutte le informazioni conservate sul computer degli utenti che non hanno avuto l’accortezza di utilizzare una macchina dedicata – scelta peraltro non necessariamente semplice, dato che l’ondata di entusiasmo per questi agenti ha impattato sulle scorte di Mac Mini e mini‑PC. Il risultato è che la natura stessa del sistema può esporre contenuti che si vorrebbero mantenere privati: numeri di carte di credito, email personali, documenti sensibili legati al lavoro. Come la maggior parte dei modelli generativi, anche OpenClaw si basa infatti su un funzionamento stocastico, ovvero statistico, ma con una componente aleatoria che introduce variabilità nelle risposte. Questo lo rende inevitabilmente imprevedibile: lo si può orientare, certo, ma non si può mai avere la garanzia assoluta dell’esito finale. Ancor più che gli agenti possono essere ingannati dalle persone con cui interagiscono con lo scopo di far loro compiere azioni dannose per l’utente che li ha creati.
L’accessibilità degli agenti IA di OpenClaw ne ha alimentato una diffusione senza precedenti, innescando una sorta di corsa agli armamenti tra coloro che ne vogliono sfruttarne per primi le potenzialità. Ma la fretta, in questo caso, è un pessimo alleato. Come riportato da Wired, aziende di primo piano – tra cui Meta – hanno imposto ai propri dirigenti e dipendenti il divieto assoluto di sperimentare autonomamente con OpenClaw, arrivando a prevedere il licenziamento immediato per chi dovesse ignorare la direttiva. Una misura drastica che riflette la crescente preoccupazione per i rischi di sicurezza associati a questi agenti, ma che evidenzia anche le tensioni che si stanno sviluppando nella contrapposizione tra modelli “open” e quelli integrati in ecosistemi chiusi.
Pakistan, attacco suicida contro convoglio militare: 7 morti
Due soldati pakistani e cinque militanti sono morti sabato in un attacco suicida nel distretto di Bannu, nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa. Secondo quanto riferito dall’esercito e riportato dal quotidiano Dawn, un convoglio delle forze di sicurezza è stato preso di mira durante un’operazione di intelligence contro i miliziani di “Fitna al Khwarij”, termine con cui Islamabad indica il Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP). Un attentatore suicida a bordo di un veicolo è stato intercettato, evitando – secondo i militari – una strage di civili. Nello scontro sono morti cinque militanti, ma l’esplosione ha causato anche la morte di due soldati.
Venezuela, amnistia concessa a 379 prigionieri politici
La giustizia venezuelana ha avviato la liberazione di 379 prigionieri politici dopo il via libera di una nuova legge di amnistia dal Parlamento, approvata all’unanimità e promossa dal governo ad interim. Il deputato che presiede la commissione incaricata del processo ha spiegato che «la Procura ha presentato richieste di amnistia ai tribunali competenti (…) per un totale di 379 persone» e che «queste persone saranno rilasciate e amnistiate» tra oggi e domani mattina. Il procuratore generale ha definito la norma come la chiusura di «un importante ciclo storico» e un’opportunità per avviare un nuovo dialogo nazionale.
Decine di migliaia di cittadini europei e statunitensi hanno partecipato al genocidio a Gaza
Sarebbero almeno 50mila i cittadini di tutto il mondo che hanno combattuto per l’esercito israeliano a Gaza, nella guerra genocida di Israele che ha ucciso almeno 72.061 persone. I dati, diffusi dalla ONG israeliana Hatzlacha, gettano per la prima volta luce sui numeri effettivi dei cittadini – la maggior parte dei quali europei e statunitensi – che hanno partecipato ai massacri, sollevando domande sulla responsabilità legale internazionale degli stranieri implicati in crimini di guerra contro i palestinesi.
I dati sono stati diffusi per la prima volta dall’organizzazione di giornalismo investigativo Declassified UK, dopo che un avvocato di Hatzlacha ha fatto richiesta di visione dei dati all’IDF, nel marzo 2025. Il via libera, tuttavia, è arrivato solamente in queste settimane, a un anno di distanza. Sarebbero 12.135 soldati arruolati nell’esercito israeliano con passaporto americano, 6.127 con passaporto francese. A seguire oltre 5mila sono cittadini anche russi, quasi 4mila i tedeschi, 3.200 gli ucraini, 1.686 i britannici, 1.675 i rumeni, 1.668 i polacchi, quasi gli 1.400 etiopi e 1.200 i canadesi. Non mancano i soldati israeliani con cittadinanza italiana: ben 828, a cui se ne sommano altri 100 che hanno anche un terzo passaporto oltre quello italiano e israeliano. In totale, sarebbero 4.440 i soldati che possiedono due cittadinanze straniere oltre a quella israeliana, mentre 162 persone ne possiedono ben tre. I dati fotografano un esercito con una grossa componente diasporica e internazionale, ben diversa da quella che era stata presentata fino ad oggi. E che chiama alle responsabilità e alla giustizia internazionale.
L’esercito di Tel Aviv comprende circa 169.000 effettivi in servizio attivo e 465.000 riservisti — di cui, secondo le nuove statistiche, quasi l’8% possiede doppia o multipla cittadinanza. La legge israeliana sul servizio militare obbligatorio esenta i cittadini con doppia nazionalità residenti all’estero, rendendo l’arruolamento un atto volontario — una distinzione importante quando tali crimini vengono giudicati nei tribunali stranieri. La natura volontaria del servizio, infatti, potrebbe rendere i soldati più responsabili per i presunti crimini. Di fatto, tutti i militari che hanno commesso crimini di guerra a Gaza sono perseguibili penalmente dagli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione sul genocidio del 1948. Ma la maggior parte dei Paesi non sembra interessata a indagare sui possibili crimini commessi dai loro concittadini o da altri soldati delle IDF in vacanza sul territorio nazionale, che invece – come accade in Italia – vengono addirittura protetti dalle forze dell’ordine del Belpaese.
A dicembre 2023 il Sudafrica ha formalmente portato Israele davanti alla Corte Internazionale di Giustizia con l’accusa di genocidio. Per arrivare a una sentenza finale, ci vorranno anni. Nel mentre, la Corte ha emesso misure provvisorie, ordinando a Israele di adottare provvedimenti per prevenire atti di genocidio a Gaza e di consentire un accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari. Ancora una volta, Tel Aviv si pone al di sopra del diritto internazionale mentre il blocco degli aiuti continua, i massacri non si fermano e i divieti di continuare il proprio lavoro alle ONG creeranno altre vittime premeditate. Nel marzo dello scorso anno, l’International Centre of Justice for Palestinians (ICJP) ha annunciato la campagna Global 195 per chiamare a rispondere individui israeliani e con doppia cittadinanza per crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza. La coalizione mira ad agire simultaneamente in più giurisdizioni per richiedere mandati di arresto privati e avviare procedimenti legali contro i soggetti implicati, inclusi membri dell’esercito israeliano e l’intero comando militare e politico israeliano. Non ci sono ancora casi comprovati di cittadini israeliani o con doppia cittadinanza arrestati per crimini di guerra commessi a Gaza. Ma sono numerosi i gruppi per i diritti umani che stanno cercando di farli perseguire penalmente.
Nel Regno Unito, nell’aprile 2025, il Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR), con sede a Gaza, e il Public Interest Law Centre (PILC), con sede nel Regno Unito, hanno presentato un rapporto di 240 pagine alla Metropolitan Police inglese. Nel dossier accusano 10 individui britannici di omicidio, trasferimento forzato di persone e attacchi contro personale umanitario durante i primi 8 mesi di guerra. In Germania lo scorso anno è stato presentato un caso contro un soldato di 25 anni nato e cresciuto a Monaco, accusato di aver ucciso civili nei pressi degli ospedali al-Quds e Nasser di Gaza. L’uomo faceva parte di un’unità nota come “Refaim” (“fantasma” in ebraico), responsabile di vari crimini di guerra, ed è finito sotto accusa grazie alle denunce mosse da numerosi centri per i diritti umani. Procedimenti legali contro membri della stessa unità sono in corso anche in Francia, Italia, Sudafrica e Belgio.
La Hind Rajab Foundation – la fondazione che ha preso il nome della bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza, diventata simbolo del genocidio – sta raccogliendo enormi quantità di dati identificativi dei soldati israeliani. La fondazione ha già presentato diversi casi, incluso un ricorso storico che prende di mira 1.000 soldati israeliani, ed è alla guida di uno sforzo internazionale per la responsabilità sui crimini di guerra a Gaza.
Tramite l’analisi di centinaia di video pubblicati dagli stessi soldati su TikTok, Instagram e YouTube, ha tracciato numerosi soldati accusati di crimini contro l’umanità. Nel ricorso presentato ci sono almeno 12 cittadini francesi, 12 statunitensi, 4 canadesi, 3 britannici e due olandesi. Nel gennaio dello scorso anno, un ricorso presentato dalla Hind Rajab Foundation ha portato un giudice brasiliano a ordinare un’indagine su un soldato israeliano in vacanza nel Paese. Il soldato è stato costretto a fuggire, spingendo l’esercito israeliano a ordinare a tutte le truppe che avevano partecipato ai combattimenti di nascondere la propria identità.
I dati emersi recentemente dovrebbero spingere gli Stati a indagare sui loro concittadini attivi nell’esercito israeliano a Gaza, e a portarli a giudizio nel caso abbiano commesso crimini. La scelta di farlo o meno, rifletterà nuovamente il livello di complicità e di connivenza degli stati – soprattutto europei e statunitense – con il genocidio agito da Israele e tuttora in corso.
USA, colpita altra barca di presunti narcos nel Pacifico: tre morti
Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver condotto un nuovo attacco contro un’imbarcazione sospettata di traffico di droga nell’Oceano Pacifico orientale, nella tarda serata di venerdì. Il Comando meridionale degli Stati Uniti ha riferito su X di aver effettuato un «attacco cinetico letale» contro un natante identificato dall’intelligence come mezzo del narcotraffico lungo rotte note. Nell’operazione sono stati uccisi tre presunti narcotrafficanti, definiti «narcoterroristi», senza perdite tra le forze americane. L’azione rientra nell’Operazione Southern Spear, iniziativa controversa promossa dal presidente Donald Trump per contrastare il traffico di droga verso gli Stati Uniti.