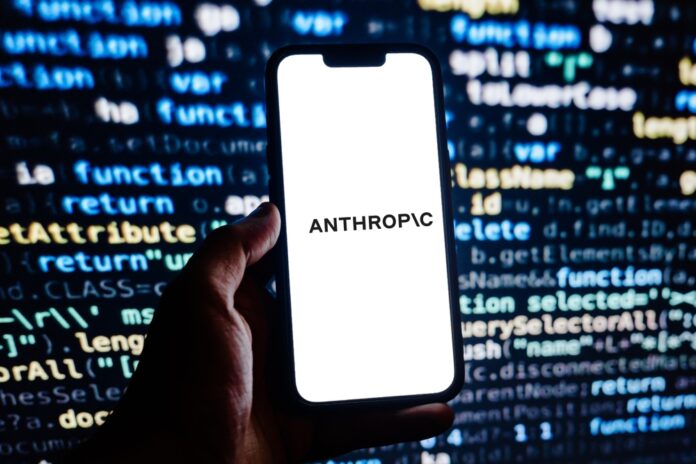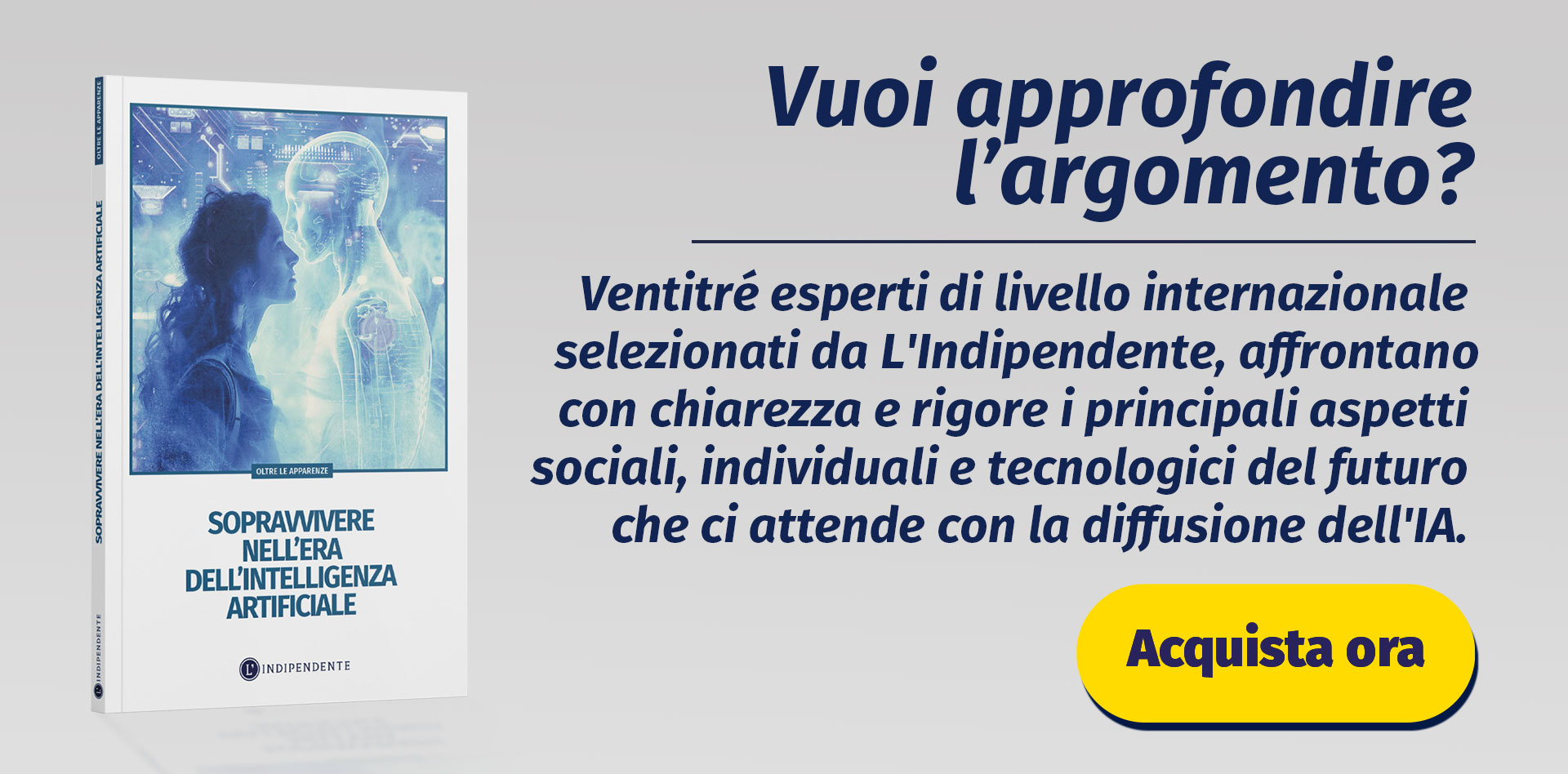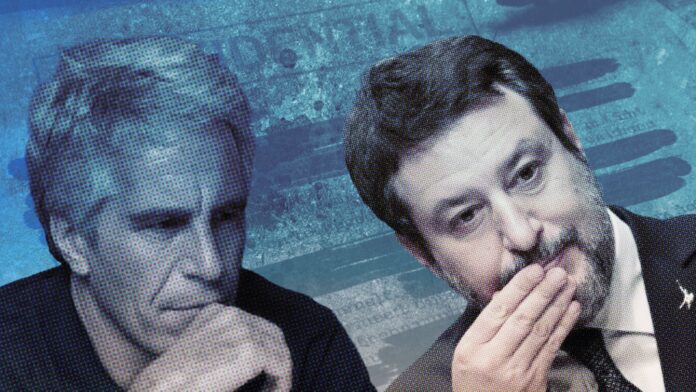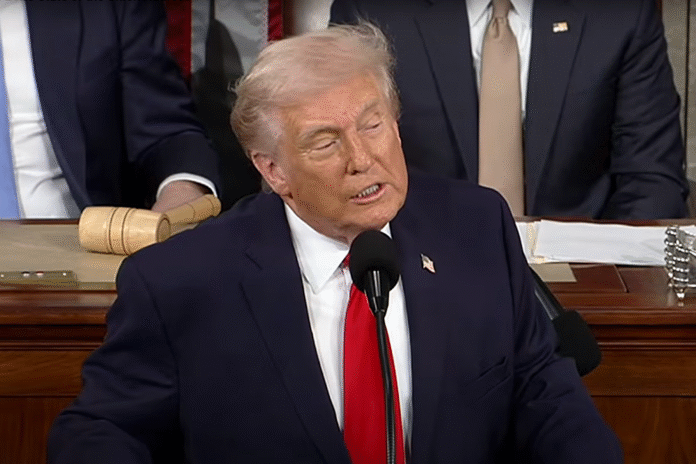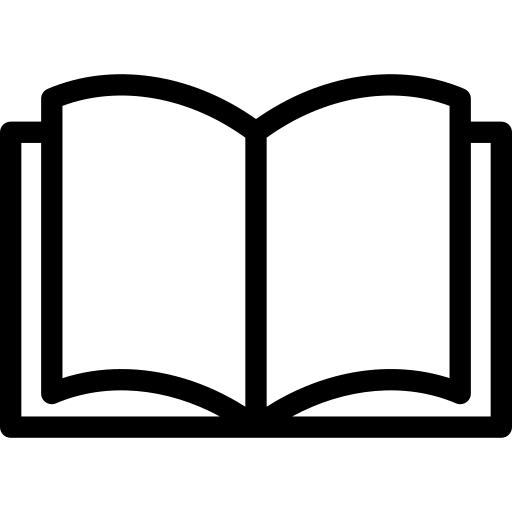Il Centro di Coordinamento delle Operazioni Integrate del Niger ha annunciato di avere condotto tre ampie operazioni antiterrorismo e anticrimine, in seguito a cui sono stati uccisi 17 sospetti militanti e arrestate altre 33 persone. Le operazioni, denominate Niya, Damissa e Garkouwa, hanno portato anche al sequestro di 1.098 candelotti di dinamite, 48 chilogrammi di cannabis, circa 23.250 litri di carburante di contrabbando, centinaia di migliaia di compresse nocive, armi e munizioni. Esse sono state annunciate oggi, 25 febbraio, e condotte tra il 16 e il 22 febbraio dalle Forze di Difesa e Sicurezza in diverse aree del Paese; arrivano in un momento teso per il Paese, da tempo teatro di scontri tra l’esercito e gruppi islamisti.
Il dl Sicurezza è legge: ecco cosa cambia dopo i fatti di Rogoredo
Dopo un iter di quasi venti giorni, il decreto sicurezza varato dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio scorso ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivata ieri. Il testo, che approda in Gazzetta Ufficiale prima dell’esame parlamentare per la conversione, è però uscito ridimensionato rispetto alle bozze iniziali, con interventi significativi su alcuni dei punti più controversi come il fermo preventivo, lo scudo penale e la stretta sui coltelli. Un dietrofront in cui è facile scorgere il nesso con i fatti di Rogoredo, dove i risultati dell’inchiesta sull’uccisione di un pusher di origine marocchina da parte di un poliziotto – inizialmente propagandata come un fatto di legittima difesa – hanno sollevato forti polemiche all’indirizzo del governo.
Uno dei nodi principali del provvedimento – che dovrà essere approvato dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza – riguarda il cosiddetto fermo preventivo, la misura che consente alle forze dell’ordine di accompagnare negli uffici di polizia e trattenere fino a dodici ore persone ritenute potenzialmente pericolose durante manifestazioni pubbliche. Rispetto alla prima bozza, che parlava genericamente di “fondato motivo” desunto da elementi come il possesso di caschi o precedenti penali, il testo definitivo introduce un correttivo significativo: il fermo, infatti, potrà scattare soltanto «in presenza di un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica» . L’aggiunta, frutto del confronto con il Colle, prevede anche l’obbligo per la polizia di dare immediata comunicazione al pubblico ministero, che può ordinare il rilascio se non ritiene sussistenti le condizioni.
Sul fronte del cosiddetto scudo penale per le forze dell’ordine, su cui la maggioranza aveva rinvigorito la spinta dopo i fatti di Rogoredo (l’agente di polizia che sparò a un rapinatore era stato inizialmente iscritto nel registro degli indagati), il decreto introduce l’«annotazione preliminare». Si tratta di un nuovo istituto: quando un reato appare commesso «in presenza di una causa di giustificazione» (come la legittima difesa, l’adempimento di un dovere o lo stato di necessità), il pm potrà effettuare un’iscrizione in un registro speciale che garantisce gli stessi diritti della difesa ma dura al massimo 150 giorni. Solo in caso di incidente probatorio scatterà l’iscrizione nel classico registro degli indagati. La norma, dunque, evita l’automatismo dell’iscrizione, ma non la esclude in presenza di elementi concreti.
Modifiche rilevanti intervengono anche sull’articolo 1 relativo al porto di coltelli. Viene confermato il divieto di vendita ai minori, con sanzioni amministrative per i genitori che vanno da duecento a mille euro, e la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chi porta fuori casa lame superiori a otto centimetri senza giustificato motivo. Tuttavia, nella versione bollinata è saltato l’obbligo per i commercianti di registrare le vendite delle lame sopra determinate dimensioni, adempimento che nelle bozze era stato criticato come eccessivamente burocratico.
L’articolo 11 allarga significativamente il perimetro delle tutele per chi subisce lesioni. La nuova formulazione dell’articolo 583-quater del codice penale equipara ai pubblici ufficiali «il personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive» . Per loro, come già per dirigenti scolastici, docenti e operatori sanitari, le pene per lesioni vanno da due a cinque anni, con aggravanti fino a sedici anni in caso di lesioni gravissime.
Per quanto riguarda la sicurezza urbana, l’articolo 6 rifinanzia il relativo fondo portandolo a 48 milioni di euro per il 2026, con la possibilità per i Comuni di utilizzare le risorse anche per straordinari e assunzioni a tempo determinato della polizia locale in deroga ai limiti di spesa . Viene invece cancellato il fondo da 50 milioni previsto in bozza per il potenziamento tecnologico delle reti ferroviarie. Sul fronte degli organici, sono previsti due concorsi straordinari: milleottocento posti per ispettori della Polizia di Stato nel 2026 e duemilaquattrocento nel 2027.
La norma dovrà essere perfezionata con un decreto del ministro della Giustizia entro sessanta giorni. Certo è che il polverone sollevatosi in seguito ai fatti di Rogoredo — l’uccisione del 28enne Abderrahim Mansouri durante un controllo nel bosco della droga di Milano e l’indagine per omicidio volontario a carico dell’agente che ha sparato, dopo che le prime ricostruzioni sulla legittima difesa sono state messe in discussione dagli accertamenti della Procura — abbia inciso in modo diretto sul clima politico e istituzionale in cui è maturato il decreto Sicurezza. L’episodio ha innescato una doppia pressione: da un lato la richiesta della maggioranza di rafforzare strumenti e tutele per le forze dell’ordine, dall’altro la necessità, emersa con forza dopo l’apertura dell’inchiesta, di evitare norme che potessero apparire come uno scudo preventivo rispetto a eventuali responsabilità individuali. È proprio in questo equilibrio che si collocano le modifiche apportate al testo prima della firma del Quirinale.
Anthropic mette da parte la sicurezza dell’IA in favore dei risultati
Anthropic, nata con l’obiettivo dichiarato di sviluppare intelligenza artificiale in modo sicuro e controllato, ha scelto di mettere da parte uno dei suoi principi fondativi: la promessa di non pubblicare nuovi modelli finché non fossero state implementate mitigazioni dei rischi ritenute adeguate. La verifica della sicurezza richiede d’altronde parecchio tempo, mentre la competizione nella ricerca impone velocità e sacrifici.
Questo cambio di direzione non è stato ovviamente annunciato in pompa magna, ma sarebbe maturato silenziosamente negli ultimi mesi per poi prendere forma questo febbraio, su forte richiesta del CEO Dario Amodei. A riportarlo è il TIME, il quale ha raccolto la testimonianza del capo scientifico di Anthropic, Jared Kaplan. «Abbiamo ritenuto che non sarebbe stato d’aiuto a nessuno smettere di addestrare modelli di IA», ha spiegato nell’intervista. «Con il rapido avanzamento dell’intelligenza artificiale, non ci è sembrato sensato assumere impegni unilaterali… soprattutto se i concorrenti stanno spingendo sull’acceleratore».
Le nuove policy incidono soprattutto sulla Responsible Scaling Policy (RSP), cioè l’impegno a non addestrare o rilasciare modelli oltre la soglia in cui le misure di sicurezza disponibili risultano insufficienti. Nella versione riformulata, l’azienda prevede soltanto la possibilità di “posticipare” lo sviluppo qualora si verifichino all’unisono due condizioni: che i rischi catastrofici appaiano concreti e rilevanti e che i dirigenti ritengano che Anthropic sia effettivamente in testa alla corsa sull’IA. Kaplan ci tiene però a precisare che questa modifica, pur significativa, non sia dettata dal desiderio di attirare nuovi investitori, bensì sia da leggersi come una scelta di natura scientifica, coerente con l’evoluzione del settore, pertanto non conserva al suo interno neppure un’oncia di ipocrisia.
In un passato non troppo lontano, Dario Amodei e la sorella Daniela occupavano posizioni di primo piano nella struttura di OpenAI. Alla fine del 2020 hanno però scelto di allontanarsi, insoddisfatti del fatto che la startup avesse progressivamente smarrito il proprio orientamento originario verso la sicurezza per abbracciare una traiettoria più apertamente commerciale. OpenAI era infatti nata come organizzazione non‑profit con l’obiettivo esplicito di sviluppare intelligenze artificiali a beneficio dell’intera umanità; la decisione di privilegiare le esigenze degli investitori rispetto a quelle della collettività ha finito per svuotare di senso l’impianto ideologico su cui il progetto si fondava.
Usciti dall’azienda guidata da Sam Altman, i fratelli Amodei hanno fondato nel 2021, insieme ad altri cinque ex dipendenti di OpenAI, la nuova realtà: Anthropic. Forte di una credibilità tecnica già consolidata, la startup ha iniziato a presentarsi agli investitori e al pubblico come un’alternativa orientata alla sicurezza, capace di proporre un modello di sviluppo dell’IA meno esposto al caos e alle derive potenzialmente dannose del settore. L’obiettivo dichiarato era quello di introdurre nuovi standard di safety, promuovere forme di autoregolamentazione e costruire un approccio che, nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto rassicurare gli investitori e, allo stesso tempo, diventare un riferimento replicabile anche dalle aziende concorrenti.
Il progetto sembrava procedere in modo soddisfacente. Le Big Tech non erano arrivate ad assumere impegni vincolanti né a rivedere radicalmente le proprie policy, tuttavia avevano comunque cercato di rassicurare il mercato esibendo una maggiore attenzione alla sicurezza degli strumenti. La situazione è però cambiata con il ritorno di Donald Trump alla Presidenza statunitense. Non appena arrivato alla Casa Bianca, il nuovo esecutivo ha adottato politiche che privilegiano uno sviluppo dell’IA rapido e poco regolamentato. In questo nuovo contesto, Anthropic sostiene di essersi dovuta arrendere all’evidenza: i modelli di intelligenza artificiale considerati ad alto rischio sono ormai parte integrante dell’ecosistema tecnologico. Continuare ad autolimitarsi, secondo l’azienda, significherebbe esporsi al rischio di diventare irrilevanti, senza ottenere reali benefici in termini di sicurezza complessiva del settore.
Di fatto, la storia si ripete: nell’aprile del 2025 era stata OpenAI a pubblicare un documento che sosteneva grossomodo la stessa argomentazione, ovvero che l’evoluzione del “panorama dei rischi” giustificasse un allentamento delle proprie soglie di sicurezza. Nel testo si leggeva infatti che, “se un altro sviluppatore di frontiera pubblica un sistema ad alto rischio senza adeguate salvaguardie, potremmo a nostra volta rivedere i nostri requisiti”. Una posizione che, già allora, lasciava intendere come la competizione nel settore potesse prevalere sulle cautele inizialmente proclamate.
L’aggiornamento delle policy di Anthropic é il frutto di circa un anno di dibattiti interni, tuttavia la sua attuazione concreta coincide con un momento diplomaticamente delicato per l’azienda: a differenza di molti altri CEO del settore, Amodei si é dimostrato finora restio a concedere all’esercito statunitense il pieno accesso agli strumenti di intelligenza artificiale dell’azienda. Pur già assecondando le richieste del Pentagono, Anthropic ha infatti tracciato un confine netto per quanto riguarda la sorveglianza di massa degli statunitensi e l’applicazione di IA per alimentare armi autonome, pretese che hanno mandato su tutte le furie Pete Hegseth, il Segretario della Guerra degli USA. Stando a fonti giornalistiche, Hegseth avrebbe dunque imposto un ultimatum ad Amodei, con la scadenza che é prevista per il prossimo venerdi: piegare la testa o subire “pesanti penalità”.
Caporalato e sfruttamento: anche Deliveroo finisce in amministrazione giudiziaria
Il Pubblico Ministero di Milano Paolo Storari continua la propria inchiesta sul caporalato nelle aziende. Il colosso delle consegne a domicilio Deliveroo è stato posto sotto amministrazione giudiziaria con l’accusa di avere sfruttato i propri fattorini, mentre la società e il suo amministratore unico sono finiti sotto indagine. Secondo Storaro, l’azienda avrebbe approfittato dello stato di bisogno dei propri lavoratori per offrire loro paghe sotto la soglia della povertà. Le persone coinvolte sarebbero 20.000 in tutta Italia di cui 3.000 nella sola Milano. Il caso di Deliveroo è il secondo all’interno del mondo dei servizi di consegna, e segue la messa sotto amministrazione giudiziaria di Glovo, altra multinazionale del settore. Al momento è inoltre aperta un’analoga inchiesta nell’industria della moda, che finora ha interessato circa 20 marchi di lusso.
A finire sotto la lente del pm Storari sono l’amministratore unico di Deliveroo Italy srl Andrea Zocchi, con l’ipotesi di caporalato aggravato, e la stessa società, accusata di avere impiegato «manodopera in condizioni di sfruttamento» approfittando dello «stato di bisogno dei lavoratori», portando avanti una «politica di impresa che rinnega esplicitamente le esigenze di rispetto della legalità». Il pm parla di un modello che favorisce «dinamiche di pesante sfruttamento lavorativo», che verrebbero «deliberatamente ricercate ed attuate». L’inchiesta dimostrerebbe che i fattorini lavorerebbero in un rapporto di subordinazione nonostante abbiano tutti partita IVA in regime forfettario: a determinare tale rapporto sarebbe la funzione dell’algoritmo della società di consegne, che monitora tutti gli aspetti del lavoro quotidiano dei fattorini, dagli ordini alla loro stessa remunerazione. Secondo le indagini il 73% dei lavoratori percepirebbe cifre inferiori a 1.245 euro lordi, mentre l’86,5% di essi risulterebbe sottopagato in relazione al CCNL a cui dovrebbe afferire. L’amministratore giudiziario dovrà ora regolarizzare le loro posizioni.
Il caso di Deliveroo arriva un mese dopo l’analoga messa sotto amministrazione giudiziaria di Glovo. Anche il quel caso le indagini mettevano in luce l’esistenza di un modello di sfruttamento dei lavoratori, sottopagati e non regolarizzati. Il provvedimento nei confronti di Glovo è stato confermato dal giudice per le indagini preliminari di Milano. L’inchiesta per caporalato tocca inoltre una ventina di aziende della moda, accusate di non avere fatto abbastanza per prevenire il regime di sfruttamento a cui sarebbero sottoposti gli operai che lavorano in subappalto nella filiera produttiva delle aziende. Tra i marchi coinvolti spicca il caso di Tod’s, accusata non solo di non avere effettuato i controlli dovuti, ma di essere a conoscenza delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori, e di aver deliberatamente ignorato la situazione.
Senato: via libera definitivo al decreto Ucraina
Il decreto Ucraina è legge. L’approvazione definitiva è arrivata oggi, 25 febbraio, dalle aule del Senato, che con 106 voti a favore, 57 contrari e 2 astenuti ha dato il via libera alla fiducia richiesta dal governo sul decreto legge. Tra le varie cose, il provvedimento prevede una proroga dell’autorizzazione della cessione di armi a Kiev fino alla fine dell’anno, il rinnovo dei permessi di soggiorno per i cittadini ucraini fino al 4 marzo 2027 e misure per la tutela dei giornalisti freelance.
Inondazioni in Brasile, almeno 30 morti e decine di dispersi
Il discorso di Trump tra le proteste: rilancia i dazi, attacca l’Iran e si autocelebra
Donald Trump ha tenuto il discorso sullo stato dell’Unione più lungo di sempre. Fedele alle aspettative, il presidente USA ha parlato per quasi due ore al Congresso, mettendo su un vero e proprio spettacolo televisivo tra ospiti, premi e attacchi. Ai migranti, all’Iran, ai democratici, che si sono divisi tra una protesta in aula e una contro-manifestazione fuori dalle mura del Campidoglio. Trump è anche tornato sui dazi, rilanciando la sua politica commerciale pochi giorni dopo la bocciatura ricevuta dalla Corte Suprema (in parte presente al Congresso). Ampio spazio è stato dato all’autocelebrazione: il presidente USA ha parlato di un’economia forte, di un Paese che nell’ultimo anno ha «vissuto una svolta epocale», al punto da entrare in una nuova «età dell’oro».
Un’ora e cinquanta di puro trumpismo hanno segnato il discorso sullo stato dell’Unione, che annualmente tiene il presidente degli Stati Uniti di fronte al Congresso convocato a sezioni unite. L’appuntamento è stato aperto con la celebrazione della squadra di hockey maschile, dopo l’oro vinto alle Olimpiadi di Milano-Cortina, accompagnata da una medaglia speciale consegnata al portiere Connor Hellebuyck. Dopo lo show è arrivata la sfilza di attacchi: a partire dai democratici, destinatari di stoccate e insulti lungo tutto il discorso. Dai banchi dell’opposizione, Ilhan Omar e Rashida Tlaib hanno accusato Trump di «uccidere gli americani», in riferimento alle morti di Renée Good e Alex Pretti per mano dell’ICE.
Durante il suo discorso il presidente USA è poi tornato sull’Iran: «hanno già sviluppato missili che possono minacciare l’Europa e le nostre basi all’estero. E stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti. Hanno ucciso 32.000 manifestanti. Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma non permetterò mai al principale sponsor mondiale del terrorismo di avere un’arma nucleare». A quello che sembra una sorta di auto-endorsement per un attacco militare, Teheran ha prontamente risposto, con il Ministero degli Esteri che ha rispedito le accuse al mittente.
Toni più distesi sono stati riservati alla Corte Suprema, dopo gli attacchi degli ultimi giorni, che hanno fatto seguito alla decisione dei giudici di bollare come illegittima la politica commerciale di Trump. Di tutta risposta, il presidente USA ha cambiato base giuridica, facendo appello Trade Act del 1974 e disponendo nuovi dazi compresi tra il 10% e il 15% per un periodo di 150 giorni. Di fronte al Congresso convocato a sezioni unite, Trump ha rilanciato la sua agenda, affermando che «con il tempo i dazi pagati dai Paesi stranieri sostituiranno sostanzialmente il moderno sistema di imposta sul reddito». Evidentemente da qui passa un importante pezzo della nuova «età dell’oro» dipinta dal presidente USA e lanciata di pari passo a una presunta rinnovata leadership internazionale. Soltanto pochi giorni fa Washington ha ospitato la prima riunione del Board of Peace, l’organismo voluto da Trump per estromettere l’ONU dai negoziati di pace nella Striscia di Gaza.
L’orizzonte del discorso sullo stato dell’Unione è l’appuntamento elettorale di novembre, quando Trump dovrà cercare di limitare i danni della bassa popolarità (ad appena un anno dall’inizio del secondo mandato). Pena la perdita della maggioranza al Congresso.
Napoli, ospedale gestito dalla camorra: 4 arresti
L’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli sarebbe nelle mani del clan camorristico Contini. È quanto emerge dall’indagine condotta da carabinieri e guardia di finanza, conclusasi all’alba con l’arresto di quattro persone. Attraverso uno schema di complicità e minacce, il clan avrebbe gestito i servizi di bar e distributori automatici, nonché gli accessi in ospedale e il trasporto delle salme. Una parte dell’indagine si concentra sulle «numerose truffe ai danni di compagnie assicurative, simulando incidenti stradali con falsi testimoni e perizie mendaci», con l’aiuto di medici compiacenti.