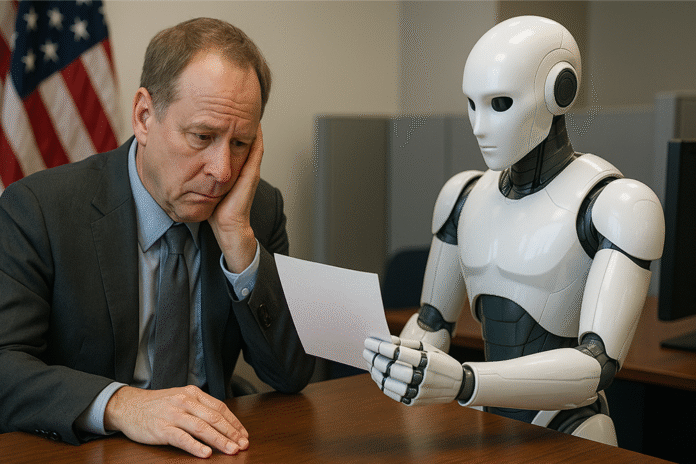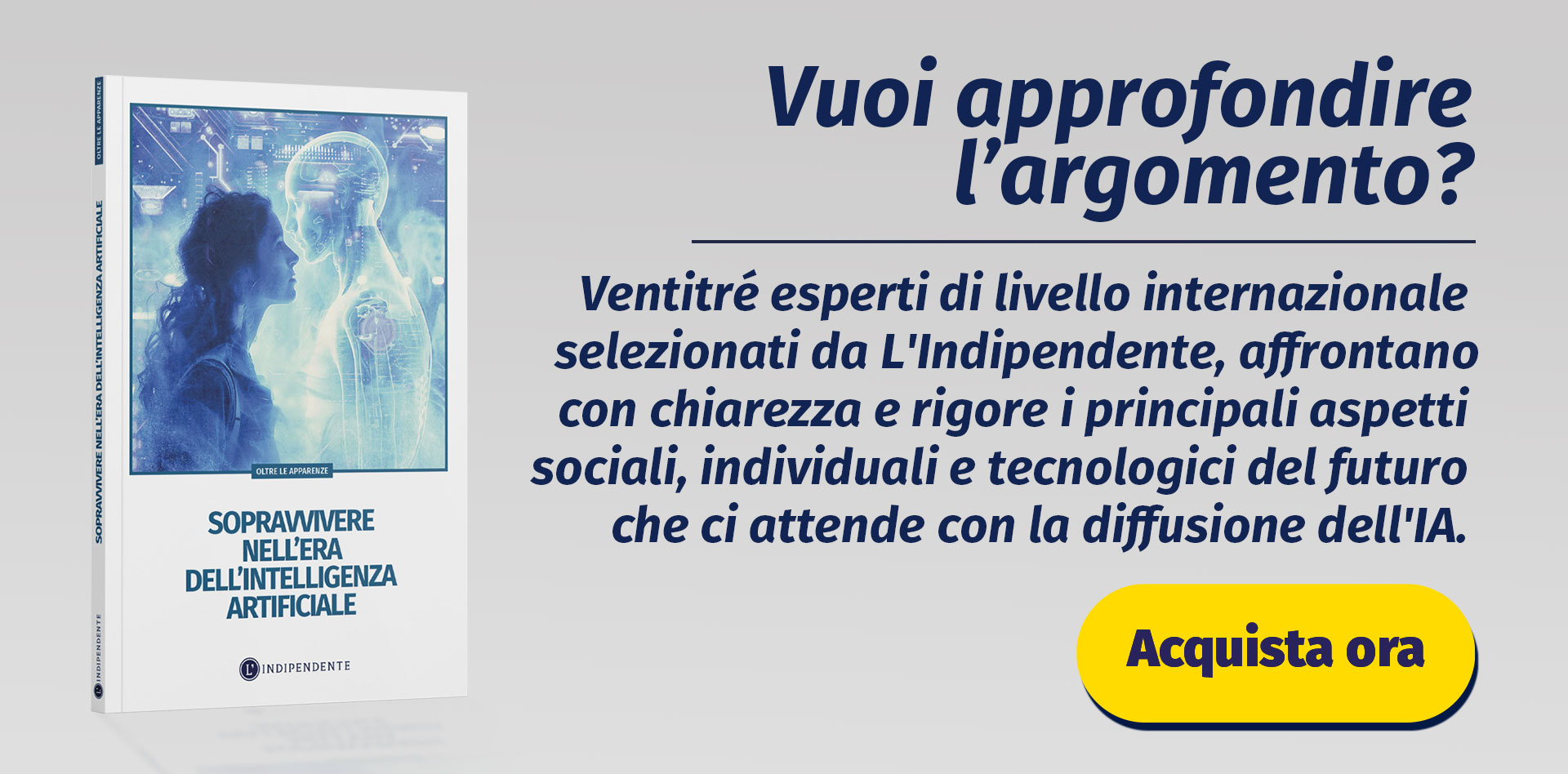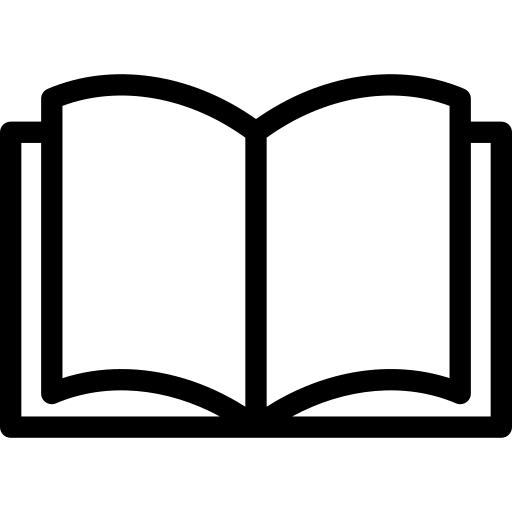Migliaia di persone hanno manifestato a Minneapolis contro la repressione dell’immigrazione dell’amministrazione Trump, sfidando temperature fino a –29 gradi. La protesta, denominata “ICE OUT!”, è stata presentata come uno sciopero generale: secondo gli organizzatori fino a 50mila partecipanti, dato non verificato dalla polizia. Decine di attività in Minnesota hanno chiuso e molti lavoratori si sono uniti ai cortei. Le mobilitazioni seguono settimane di tensioni tra agenti ICE e manifestanti. Alla vigilia il vicepresidente JD Vance aveva difeso l’operato dell’ICE. Durante una protesta all’aeroporto, la polizia ha arrestato decine di religiosi in preghiera.
Trilaterale USA-Russia-Ucraina, concluso primo round colloqui
Seicentomila ucraini, solo nell’ultimo mese, hanno abbandonato Kiev
Solo nel mese di gennaio, 600.000 persone hanno abbandonato la capitale ucraina su una popolazione prebellica totale di circa tre milioni: lo ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko in un’intervista rilasciata recentemente al Times. Il sindaco ha spiegato che gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche e di riscaldamento stanno spingendo la principale città ucraina verso il disastro umanitario. «La situazione dei servizi di base – riscaldamento, acqua ed elettricità – è critica. Attualmente, 5.600 condomini rimangono senza riscaldamento» ha affermato Klitschko, il quale ha anche esortato i residenti rimasti ad andarsene, se possibile, mentre le squadre di emergenza lavorano per ripristinare l’erogazione di energia elettrica e riscaldamento. La protezione civile ha dovuto intervenire drenando l’acqua dagli impianti centralizzati di riscaldamento e di approvvigionamento idrico per evitare che le tubature si congelassero e scoppiassero a causa delle rigide temperature che hanno raggiunto anche i meno diciotto gradi.
Il sindaco di Kiev ha poi denunciato un contrasto con il governo centrale ucraino, criticando duramente il suo operato e spiegando che, invece di unirsi di fronte all’emergenza, l’esecutivo ucraino starebbe alimentando un conflitto politico proprio in un momento di massima criticità. Ha anche rivelato al Times di aver chiesto un incontro per discutere della situazione e trovare delle soluzioni, vedendosi però negare la richiesta, nonostante le questioni legate all’energia e alla difesa aerea siano di competenza diretta del governo.
La denuncia del primo cittadino della capitale ucraina avviene all’indomani di poderosi attacchi russi al sistema energetico di Kiev e altre città ucraine: giovedì il ministro dell’Energia ucraino Denys Shmyhal ha dichiarato che è stato «il giorno più difficile per il sistema elettrico dal blackout del novembre 2022», aggiungendo che «La situazione è estremamente difficile. Gli equipaggi sono stati costretti a ricorrere continuamente a chiusure di emergenza». Ha spiegato che le condizioni più difficili si sono verificate a Kiev e nella regione circostante, nonché nella regione sud-orientale di Dnipropetrovsk. Dopo l’attacco avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì con centinaia di droni e missili che hanno preso di mira le strutture energetiche in tutta l’Ucraina, anche ieri Mosca ha colpito pesantemente i sistemi ucraini, insieme alle infrastrutture energetiche utilizzate dall’esercito ucraino e le aree di schieramento dei soldati: «Aerei operativi/tattici, veicoli aerei d’attacco senza pilota, truppe missilistiche e artiglieria dei gruppi di forze russe hanno colpito infrastrutture energetiche utilizzate per supportare le operazioni dell’esercito ucraino, depositi di munizioni e anche aree di dispiegamento temporaneo di formazioni armate ucraine e mercenari stranieri in 142 località», ha affermato il ministero della Difesa russo in una nota.
Lo svuotamento di fatto delle città ucraine – compresa la capitale – non è l’unico problema che l’Ucraina si trova ad affrontare: insieme all’abbandono crescente dei principali centri abitati, infatti, l’ex Stato sovietico è afflitto dal punto più basso di natalità mai raggiunto e da un numero sempre più consistente di giovani ucraini che fuggono dal Paese per non arruolarsi nell’esercito. Secondo l’istituto demografico dell’Accademia nazionale delle scienze dell’Ucraina, la popolazione, che prima prima della guerra, nel febbraio 2022, era di 42 milioni, si è già ridotta a meno di 36 milioni, compresi diversi milioni di persone residenti nelle aree conquistate dalla Russia. Allo stesso tempo, si stima che entro il 2051 la cifra scenderà a 25 milioni, mentre le proiezioni del 2024 del CIA World Factbook indicano che il Paese ha sia il tasso di mortalità più alto che quello di natalità più basso al mondo: per ogni nascita si verificano circa tre decessi. Per quanto riguarda l’abbandono del Paese da parte dei giovani ucraini, invece, il giornale statunitense Politico aveva riferito come nei mesi di settembre e ottobre 2025 quasi 100.000 ragazzi ucraini di età compresa tra i 18 e i 22 anni avessero lasciato il loro Paese per rifugiarsi negli Stati vicini o confinanti, in particolare Germania e Polonia.
Inoltre, i massicci attacchi russi e la grave situazione umanitaria in cui versa la popolazione ucraina, che deve affrontare temperature molto rigide, si verificano dopo uno scandalo che coinvolge una parte importante della politica ucraina, per il quale circa 100 milioni di dollari destinati a proteggere le centrali elettriche dal sabotaggio russo sarebbero stati in realtà sottratti da alcuni funzionari a partire dal 2022, secondo quanto emerso dalle indagini dell’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU).
Indipendentemente dalla situazione sul campo, dunque, dal quadro delineato emerge una nazione in buona parte distrutta e sempre più svuotata della sua popolazione, sia a causa delle massicce partenze e diserzioni, sia a causa della bassa natalità. Il tutto mentre l’Ucraina deve affrontare divisioni politiche e incertezze imputabili ai mutevoli equilibri dell’assetto internazionale.
Incidenti sul lavoro: morti 3 operai
A poche ore di distanza, tre operai hanno perso la vita in incidenti distinti. Venerdì mattina a Livorno un uomo di 51 anni è morto schiacciato dalla benna di una gru mentre scaricava materiale edile nel quartiere Shangai. Nelle stesse ore, in Abruzzo a Petrella Liri (L’Aquila), un operaio di 59 anni è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente con un mezzo meccanico in un cantiere per una centrale idroelettrica. Nel pomeriggio, a Palermo, ha perso la vita un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, cadendo da un’impalcatura, mentre stava eseguendo alcuni lavori di riparazione. I tre incidenti sul lavoro si sommano a quelli registrati giovedì in Piemonte e in Abruzzo: un operaio di 25 anni morto in un’azienda agricola del Torinese e un 66enne deceduto in un cantiere edile nel Teramano.
Una class action sfida la selezione di lavoro via intelligenza artificiale
L’impiego di strumenti di intelligenza artificiale nei processi di selezione del personale, pur restando oggetto di accesi dibattiti, è ormai diventato una pratica radicata e trasversale che tocca una varietà di settori. Inoltre coinvolge tanto le aziende, quanto i candidati. Per chi invia un curriculum, la frustrazione nasce soprattutto dall’opacità dei criteri con cui le IA valutano i profili, nonché dall’impossibilità di conoscere le ragioni di un eventuale scarto. Una class action avviata in California potrebbe però cambiare radicalmente questo scenario, imponendo ai gestori di tali sistemi una serie di nuovi obblighi che vadano a garantire un minimo di trasparenza.
L’azienda finita sotto i riflettori della magistratura è Eightfold AI, una realtà poco conosciuta dal grande pubblico, ma che è ampiamente utilizzata da numerose corporazioni di primo piano. Dai colossi tecnologici come Microsoft, Ubisoft e PayPal fino a gruppi globali come Vodafone e Bayer, molte imprese si affidano alla sua piattaforma di intelligenza artificiale per valutare e selezionare i candidati. Secondo l’accusa, però, questo processo si fonderebbe su pratiche assimilabili a un vero e proprio dossieraggio.
I promotori dell’azione legale, Erin Kistler e Sruti Bhowmik, sostengono che l’azienda abbia raccolto su di loro — e su milioni di altri lavoratori — una mole di dati personali che va ben oltre quanto indicato nei curriculum: dai contenuti pubblicati sui social media alla geolocalizzazione dei loro device, dai cookie di navigazione alle informazioni acquistate da terze parti. Una pratica resa possibile da un sistema di valutazione che non offre ai candidati una reale possibilità di negare il consenso all’uso dei dati. L’impressione è che ci si debba sottomettere alle richieste di Eightfold AI per non essere automaticamente esclusi dal processo di selezione. “Non facciamo esfiltrazione sui social media e simili”, sostiene il portavoce di Eightup, Kurt Foeller. ”Siamo profondamente impegnati nell’IA responsabile, nella trasparenza e nella conformità con la protezione dei dati e le leggi sul lavoro applicabili”.
La causa, depositata martedì 20 gennaio, si fonda sul Fair Credit Reporting Act e sul California Investigative Consumer Reporting Agencies Act, leggi federali nate originariamente per tutelare i cittadini dall’inserimento volontario o negligente di informazioni inesatte nei rapporti di credito e nelle assunzioni. La norma mira a impedire che la presenza di dati errati produca conseguenze dannose e riconosce alle persone il diritto di reclamare le ragioni alla base delle decisioni che le riguardano. In assenza di regolamentazioni specifiche sull’IA, insomma, gli avvocati dell’accusa puntano ad applicare questo quadro giuridico preesistente a un contesto che, altrimenti, potrebbe essere identificato come perlopiù inedito.
”Questo caso riguarda un mercato distopico che viene guidato dall’IA, dove alcuni robot che operano dietro le quinte finiscono con il prendere decisioni su alcune delle cose più importanti della nostra vita: se troviamo un lavoro, una casa o l’assistenza sanitaria”, contestualizza sui X David Seligman, direttore esecutivo di Towards Justice, gruppo no-profit che rappresenta i querelanti. “Ma ecco il punto chiave: questo NON è il selvaggio West. Non esiste un’eccezione per l’IA alla legge – a prescindere da quanto la tecnologia possa sembrare sofisticata o quanto capitale vi venga riversato dietro”.
Il destino di questo procedimento resta altamente incerto. Guardando ai precedenti storici, è altamente probabile che la battaglia legale finirà con il trascinarsi per anni. Ciononostante, l’iniziativa appare come uno degli interventi più significativi nel tentativo di fare chiarezza su un tema che sobbolle ormai da oltre un decennio: l’impiego dell’IA nei processi di selezione del personale, un’attività che si può far risalire a quando le attuali “intelligenze artificiali” erano ancora etichettate semplicemente “algoritmi”.
Ddl stupri, la maggioranza cambia il testo: sparisce il “consenso”
La senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, ha depositato in Commissione Giustizia del Senato una nuova riformulazione del ddl sulla violenza sessuale, che sarà votata la prossima settimana. Nel testo sparisce il riferimento al “consenso”, centrale nella versione approvata all’unanimità dalla Camera: al suo posto compare il concetto di “volontà contraria all’atto sessuale” o di dissenso, da valutare in base al contesto e alla situazione. La proposta introduce anche una riduzione delle pene: per la violenza sessuale senza aggravanti la reclusione scende da 6-12 a 4-10 anni, mentre resta invariato il range 6-12 anni nei casi commessi con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica. Polemiche da parte delle opposizioni, che giudicano la riformulazione un arretramento rispetto all’intesa bipartisan raggiunta alla Camera.
Per le olimpiadi invernali si restaurano le misure pandemiche: zone rosse e DAD nelle scuole
Smart working, didattica a distanza e zone rosse. A due settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, la Lombardia rispolvera le misure pandemiche. Nel capoluogo lombardo, attorno ai siti olimpici saranno istituite “zone rosse” per tutta la durata dei Giochi, con limitazioni di accesso e di stazionamento decise dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il 6 febbraio, giorno dell’inaugurazione e del passaggio della torcia in centro, le scuole nelle aree interessate resteranno chiuse e gli uffici pubblici sono invitati a favorire lo smart working per alleggerire traffico e trasporti. Nel sondriese, primarie e medie resteranno in presenza, così come le superiori lontane dagli impianti; per gli istituti più vicini ai siti di gara, la scelta tra aula, DAD o formula mista sarà affidata ai dirigenti.
Il piano di sicurezza predisposto per i XXV Giochi Olimpici Invernali prevede una serie di interventi che richiamano, per rigidità e impatto sulla vita quotidiana, alcune delle misure adottate durante l’emergenza Covid-19. Nelle aree dove si svolgeranno gli eventi olimpici – dall’Arena di San Siro ai siti di gara nel capoluogo lombardo – sono state istituite le cosiddette “zone rosse” in prossimità dei siti olimpici, «al fine di assicurare il regolare svolgimento delle iniziative e la pacifica fruizione degli spazi urbani interessati», con limitazioni di stazionamento e presenze non autorizzate, divieti di sorvolo per droni e traffico aereo privato. A Milano città, le zone rosse “olimpiche” saranno tre: l’area Sempione col braciere olimpico, l’area del Villaggio Olimpico e l’area Santa Giulia con l’Ice Hockey Arena. Nell’area metropolitana saranno, invece, due: a Rho e ad Assago. Durante il passaggio della Fiamma Olimpica e il giorno dell’inaugurazione, gli istituti scolastici all’interno della circonvallazione urbana saranno chiusi, mentre gli uffici pubblici sono invitati «a valutare la possibilità di favorire il ricorso al lavoro da remoto».
In provincia di Sondrio, dove le gare coinvolgeranno Livigno e Bormio, alcune scuole superiori rischiano di vedere riattivata la didattica a distanza per gli studenti che non riusciranno a raggiungere gli istituti a causa dei cambiamenti nel sistema dei trasporti e delle corse dedicate soppresse per agevolare il flusso turistico. Questa eventualità ha suscitato polemiche e una raccolta firme: genitori e comitati lamentano che la didattica a distanza venga utilizzata per ragioni logistiche legate a un evento programmato con largo anticipo, non per una situazione imprevista o per una emergenza sanitaria. Le autorità scolastiche regionali hanno cercato di smorzare la tensione, definendo la DAD una “extrema ratio”, da applicare solo nei casi in cui gli studenti non possano arrivare in presenza. Per molti ragazzi la misura rischia, però, di trasformarsi in un ritorno a modalità di apprendimento che l’intero Paese ha subìto durante gli anni della pandemia. L’obiettivo dichiarato di agevolare la circolazione di atleti, spettatori e tifosi si traduce, di fatto, in una sospensione parziale del diritto allo studio in presenza, almeno per alcune fasce di studenti.
Ufficialmente motivate dalla tutela dell’ordine pubblico – contenere assembramenti, governare la viabilità, proteggere delegazioni e apparati – queste misure recuperano un linguaggio e una postura già sperimentati durante la pandemica: sospensione della normalità, perimetri chiusi, accessi contingentati. È una scenografia che, in assenza di un pericolo reale, riattiva l’immaginario del lockdown e della vita regolata per decreto. Il riutilizzo di strumenti nati in un contesto eccezionale – e divenuto di fatto un “precedente” – segnala un modello di gestione del rischio ormai interiorizzato. La sicurezza, declinata di volta in volta in chiave sanitaria, urbana o sociale, diventa la cornice dentro cui si normalizzano interventi profondi sulla quotidianità. Anche le Olimpiadi, evento simbolo di apertura e condivisione, vengono così inglobate in una logica emergenziale che rende ordinaria la compressione delle consuetudini civiche e abitua territori e cittadini a una normalità sempre più perimetrata.
Il prosciutto cotto è realmente cancerogeno?
Negli ultimi giorni sui social è circolata la notizia che il prosciutto cotto sarebbe stato classificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un alimento “cancerogeno di tipo 1”. In realtà, non si tratta di una novità: già nel 2015 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), una agenzia di ricercatori in seno all’OMS, aveva inserito tutte le carni trasformate – dal prosciutto crudo al salame, dalla bresaola agli insaccati come wurstel e salsicce – nella categoria dei “cancerogeni certi” per l’uomo. In pratica sappiamo da oltre 10 anni che le carni trasformate sono considerate a livello scientifico cibi che aumentano la probabilità di insorgenza di alcuni tipi di tumore, come il cancro al colon o alla prostata. Gli studiosi le definiscono “carni processate”, e includono tutti i tipi di carne non fresca, inclusa la carne in scatola e la carne secca. Rilanciare questa notizia oggi sui social e nei mass media come se fosse una rivelazione dell’ultima ora serve solo a generare traffico web e monetizzazioni delle pagine social, più che vera informazione. Vediamo però di capire meglio la questione, al fine di offrire una divulgazione chiara e senza inutili allarmismi a tutti i nostri lettori.
Carni lavorate e cancerogeni certi
Innanzitutto inquadriamo le carni “processate” o “lavorate”. Cosa sono? Si tratta di tutte le carni che vanno incontro a dei processi di trasformazione di tipo industriale, i quali includono tutte le lavorazioni fatte per migliorarne la conservazione, come l’aggiunta di sale e conservanti come nitriti e nitrati, e quei processi per migliorarne il sapore come la stagionatura, l’affumicatura o la cottura. Nelle carni lavorate rientrano quindi prosciutto crudo e cotto, salame, mortadella, speck, pancetta, wurstel, salsicce, carni in scatola e carne secca, affettato di tacchino e altre ancora, in generale tutte le carni non fresche appunto.
Adesso cerchiamo di capire cosa è la classe di sostanze o agenti che l’OMS definisce “cancerogeni di tipo 1”, chiamati anche cancerogeni certi. Gli studiosi dell’OMS definiscono in questo modo le sostanze per le quali esistono dei dati scientifici piuttosto netti e sicuri sul fatto che l’esposizione o assunzione di queste sostanze aumenti la probabilità di sviluppare un tumore. Ad oggi abbiamo circa 130 cancerogeni certi, tra i quali l’alcool, il fumo di tabacco, l’amianto, l’arsenico, le aflatossine o i raggi solari UVB. E appunto anche le carni lavorate o processate. Le carni processate sono ritenute cancerogene per alcuni fattori:
- per il fatto di contenere abbondanti quantità di ferro eme, la forma di ferro più assimilabile dal corpo umano, necessaria per tutte le reazioni chimiche dell’organismo. Nei cibi vegetali è contenuto invece il ferro non-eme, scarsamente assimilato e utilizzato dal nostro organismo. L’eccesso di assunzione di ferro eme, che può favorire stress ossidativo e infiammazione della mucosa intestinale, è sospettato dagli studiosi essere una delle cause alla base del meccanismo di sviluppo dei tumori.
- per il fatto di contenere troppo sale e troppi conservanti come i nitriti e nitrati. In particolare questi conservanti sono molto chiaramente responsabili della formazione di composti cancerogeni nello stomaco, come le nitrosammine.
- per il fatto di associare un elevato consumo di carni lavorate e insaccati ad una dieta che in genere non è corretta e sana. Gli studiosi ritengono infatti, a ragione, che chi mangia molti salumi, wurstel e insaccati, segua anche regimi alimentari molto sbilanciati, che nel complesso aumentano la probabilità di sviluppare tumori e altre patologie legate all’alimentazione scorretta e ad uno stile di vita non salutare.
A questo punto molte persone potrebbero automaticamente, ed erroneamente, fare un ragionamento del tipo “allora se mangio prosciutto mi viene il tumore”. Questo pensiero è del tutto sbagliato, le cose non stanno infatti così. Un’altra associazione mentale errata che di solito le persone fanno è la seguente: dato che oltre alle carni trasformate nella categoria dei cancerogeni di tipo 1 ci sono anche l’alcool e il fumo, “allora il prosciutto è pericoloso tanto quanto il fumo e l’alcol”. Anche questo è completamente sbagliato, perché fumo e alcool sono dei cancerogeni molto più potenti. Fumo e alcool aumentano la probabilità di contrarre il cancro molto di più di quanto lo facciano le carni trasformate. Fumare sigarette e mangiare panini col prosciutto sono due attività molto diverse tra loro dal punto di vista del rischio.
Qual è il pericolo reale?

Vale davvero la pena fare un piccolo approfondimento su questa tematica e capire in maniera sensata come vada inteso e applicato questo principio del prosciutto “cancerogeno”, perché altrimenti si rischia di recepire tutto nella maniera sbagliata e assumere comportamenti estremisti e del tutto fuori luogo, tipo quello di aver paura di mangiare la carne o di escluderla completamente dalla propria alimentazione, che sarebbe davvero insensato, se la decisione è presa per ragioni di salute. Altro discorso, ovviamente, se si decide di rinunciare alla carne per altre motivazioni di tipo etico o ambientale.
Partiamo da un parere autorevole sull’argomento, come ad esempio quello dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC, da non confondere con la IARC menzionata sopra), che dopo la presa di posizione da parte dell’OMS nel 2015, spiega comunque molto bene in questo suo comunicato ufficiale che le carni conservate (salumi e insaccati) possono incrementare il rischio di contrarre alcuni tumori solo quando se ne faccia un uso molto frequente e quindi eccessivo. Inoltre il documento dell’AIRC spiega anche come il rischio tumorale dipenda dal rischio di base che una persona ha di sviluppare un tumore, quest’ultimo basato sullo stile di vita generale della persona e sulla sua predisposizione genetica per alcuni tipi di cancro (familiarità).
Pertanto è bene stare molto attenti a non cadere vittima di falsi allarmismi sul consumo di carne. Quando la carne lavorata (insaccati, prosciutto ecc.) viene classificata nel gruppo 1 delle sostanze cancerogene, non vuol dire che se mangiamo questi alimenti ci verrà sicuramente il cancro. Vuol dire solo che può aumentare, nello specifico del 18%, come dice la stessa IARC, il rischio relativo di ammalarci di determinati tumori. È bene dunque tenere presente che i dati diffusi dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’OMS si riferiscono a un aumento del rischio relativo di sviluppare un tumore, e non a un aumento del rischio assoluto. La differenza tra i due tipi di rischio è cruciale e la illustrerò ora in maniera molto chiara.
Il rischio assoluto è la percentuale che ha ognuno di noi, a seconda della sua genetica, del suo stile di vita e delle sostanze tossiche a cui è cronicamente esposto, di ammalarsi di un determinato tumore. Questo rischio quindi varia da individuo a individuo. Non c’è un rischio assoluto valido per tutti insomma, ma ognuno ha il suo. Il rischio relativo invece è la probabilità che si verifichi un determinato evento in un determinato gruppo di persone rispetto a un altro gruppo con comportamenti, condizioni fisiche e ambienti diversi. Ecco come spiega questa differenza la nostra Agenzia Italiana per la Ricerca sul Cancro: «persone che non hanno familiarità per il cancro del colon e per il cancro in generale, che hanno abitudini di vita salutari (non fumano, fanno esercizio fisico) ma sono consumatori frequenti di salumi, accresceranno il proprio rischio di ammalarsi del 18% circa rispetto a persone con le stesse caratteristiche e abitudini che però non mangiano i salumi. Il rischio di entrambi i gruppi, tuttavia, resterà comunque molto basso perché complessivamente rischio assoluto e rischio relativo sono entrambi bassi. Ciò significa che in termini sia assoluti sia relativi quelle persone non avranno modificato di molto il proprio rischio di ammalarsi di cancro al colon. Viceversa persone che hanno una malattia infiammatoria dell’intestino o un’elevata familiarità per cancro del colon-retto (due condizioni che accrescono di molto il rischio), mangiando insaccati in grande quantità accresceranno il proprio rischio assoluto, relativamente elevato, del 18% di rischio relativo, rispetto a persone che nelle stesse condizioni evitano gli insaccati».
Detto in altre parole, se una persona ha di base un rischio assoluto basso, poniamo dello 0,6% di contrarre un tumore, mangiando poi ogni giorno 50 grammi di salumi (questa è la quantità di cui parla l’Agenzia Internazionale sul cancro riferendosi a un consumo elevato di carni lavorate) aumenterà del 18% quel rischio assoluto di base, e ciò significa che dallo 0,6% si passa allo 0,7% di rischio di sviluppare il tumore. Infatti il 18% va calcolato come 18% dello 0,6%, e questo è il risultato finale a cui si giunge. Come si vede, se il rischio di base e di partenza (rischio assoluto) è basso grazie a uno stile di vita virtuoso e sano, seppure si consumino i salumi ogni giorno (e va da sé che in una dieta sana non si dovrebbero nemmeno consumare salumi ogni giorno) rimarrà comunque un rischio basso. Viceversa, se il rischio di base di una persona è alto a causa del suo stile di vita non salutare (fumo di sigaretta, sedentarietà, dieta non sana, vita in aree e città molto inquinate etc.), poniamo pari al 20%, consumare 50g di salumi aumenterà questo rischio del 18% e si passa a un rischio reale e complessivo del 24%. Come si vede, l’aumento del rischio è significativamente maggiore tra le persone che hanno un rischio di base (rischio assoluto) già importante.
In conclusione dovrebbe essere ora chiaro che anche se una sostanza o cibo sono riconosciuti come cancerogeni, nella valutazione del rischio di contrarre un tumore non si può mai prescindere dal valutare i reali rischi di base (genetica e stile di vita) e la dose che si assume di quella sostanza o alimento. Diciamo che il prosciutto cotto più un bicchiere di vino o anche due, che sarà mai…poi vuoi non fare l’aperitivo con “due “ patatine? E la brioche a colazione ogni giorno, ricca di grassi idrogenati, conservanti e zucchero? E così via. Alla fine la somma di tutto fa una percentuale significativa che può far scaturire una patologia tumorale. Ma la colpa non è più del prosciutto. L’importante è sapere queste cose e i meccanismi con cui funziona l’alimentazione e la salute, poi ognuno decide consapevolmente.
Trump fa causa a JPMorgan per “debanking politico”
Cinque miliardi di dollari: è l’ammontare del risarcimento chiesto da Donald Trump nella causa intentata contro JPMorgan Chase e il suo amministratore delegato Jamie Dimon, accusati di averlo colpito con un presunto “debanking” a sfondo politico. Secondo la denuncia, depositata in una corte della contea di Miami-Dade (Florida), la banca avrebbe chiuso i conti di Trump e delle sue società nel 2021 per motivi ideologici, dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, e non per rischi legali o normativi, danneggiando reputazione e attività del tycoon e creando una presunta “blacklist” per scoraggiare altri istituti dal servirli. JPMorgan respinge le accuse, affermando di non chiudere conti per opinioni politiche o religiose e di operare secondo regole e rischi regolamentari.