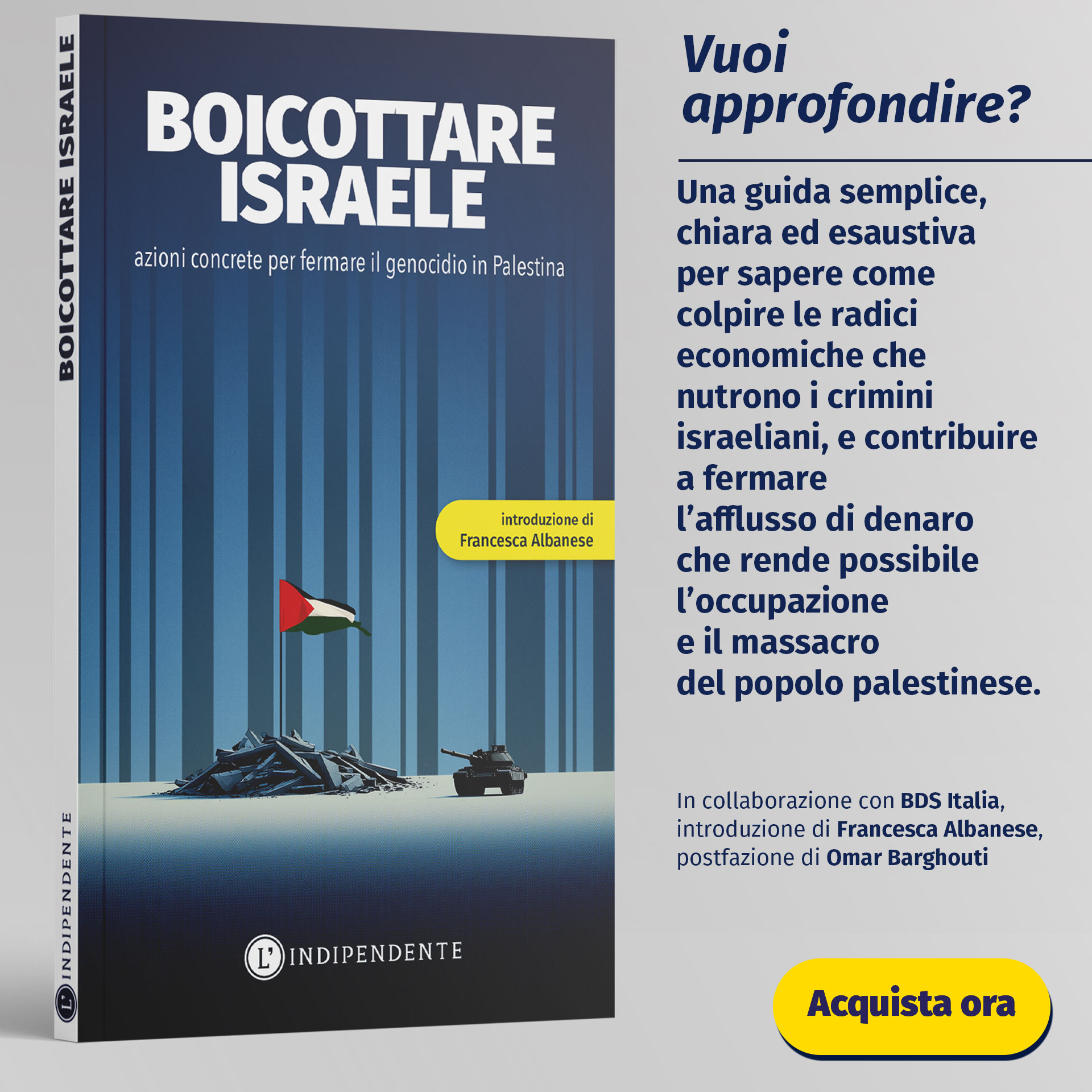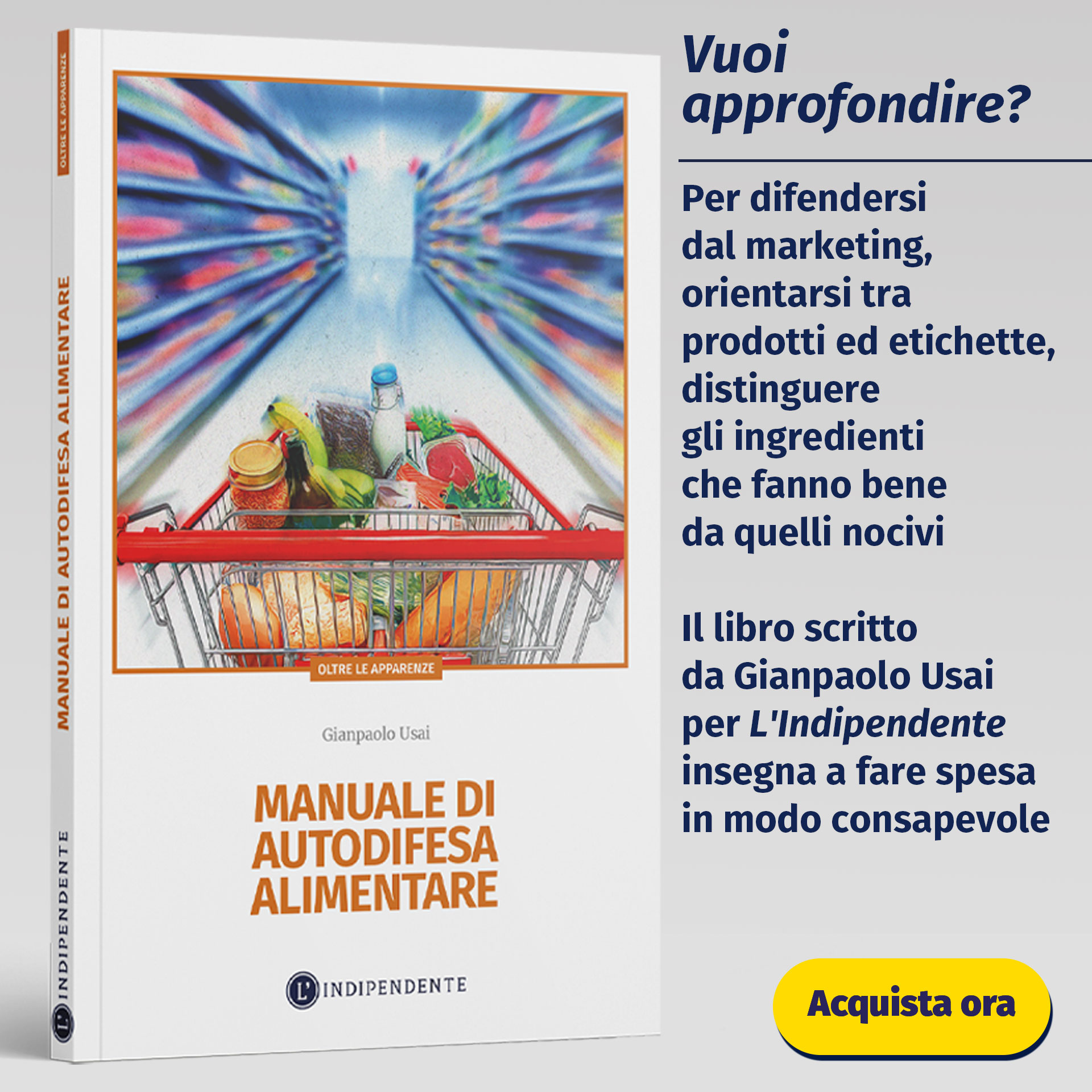Alcuni membri di Palestine Action, il gruppo che in Gran Bretagna promuove azioni dirette non violente contro le aziende complici di Israele e dichiarato dal governo organizzazione terroristica, stanno portando avanti il più grosso sciopero della fame nelle carceri del Paese da quarant’anni a questa parte. Sono otto gli attivisti coinvolti, rinchiusi in cinque prigioni sul territorio britannico in attesa di processo. Nonostante l’aggravarsi delle loro condizioni di salute, hanno dichiarato che proseguiranno fino a che il governo non prenderà alcune iniziative, tra le quali la revoca della messa al bando dell’organizzazione e la fine delle operazioni nel Regno Unito di Elbit System, azienda israeliana produttrice di armi.
Due attivisti sono entrati oggi nel loro 45° giorno di protesta – iniziata il 2 novembre, nel 108° anniversario della Dichiarazione Balfour. La settimana successiva si sono aggiunte altre cinque persone, mentre l’ultimo rifiuta il cibo da 12 giorni. Cinque scioperanti sono già stati ricoverati in ospedale. Gli avvocati e i familiari avvertono che gli attivisti potrebbero morire in carcere, accusando le autorità britanniche di mancanza di assistenza e comunicazione e il ministro della Giustizia di ignorare le loro richieste di incontro. Tutti hanno perso molti chili e le loro condizioni di salute si stanno aggravando velocemente. Anche Amnesty International UK ha denunciato il momento critico e ha chiesto ai pubblici ministeri di ritirare le loro accuse di terrorismo e porre fine alle lunghe detenzioni preventive, sottolineando come «l’uso delle leggi antiterrorismo per aggirare il giusto processo e imporre pene più severe ai manifestanti che intraprendono azioni dirette costituisce una minaccia ai diritti di espressione e di riunione di tutti».
Questo gruppo di detenuti è in attesa di processo per il presunto coinvolgimento in due azioni organizzate da Palestine Action, entrambe avvenute prima della messa al bando dell’organizzazione, quest’estate. Nella prima azione, gli attivisti sono accusati di aver danneggiato attrezzature e proprietà della fabbrica di armi Elbit Systems (il più grande produttore di armi israeliano) di Filston, nell’agosto 2024. Nella seconda azione, nel giugno 2025, gli imputati detenuti sarebbero entrati nella base aerea RAF Brize Norton e avrebbero spruzzato vernice rossa sui motori degli aerei cisterna utilizzati negli attacchi aerei britannici in Medio Oriente. Nessuno degli imputati ha accettato le accuse a loro carico. Sono 29 in totale gli attivisti di Palestine Action rinchiusi nelle prigioni britanniche, tutti accusati a vario titolo di azioni volte a sabotare Elbit System o i partner con i quali questa collabora. Non è escluso che altri si uniranno allo sciopero in corso.
Gli attivisti hanno dichiarato che continueranno a rifiutare il cibo fino a quando il governo britannico non soddisferà le loro cinque richieste. Alcune sono richieste legate alla propria carcerazione, quali lafine della censura delle loro comunicazioni, il rilascio immediato su cauzione e la divulgazione dei documenti relativi all’influenza dello Stato israeliano e delle aziende nei loro casi, al fine di garantire un processo equo. Altre riguardano il più ampio movimento di solidarietà con la Palestina: gli scioperanti chiedono la revoca della messa al bando di Palestine Action: da quando il gruppo è stato classificato come organizzazione terroristica, nel mese di luglio, oltre 2.350 persone sono state arrestate ai sensi della legge sul terrorismo, per aver esposto cartelli che indicavano il loro sostegno al gruppo. L’ultima richiesta va oltre i confini della Gran Bretagna: gli scioperanti chiedono la fine delle operazioni nel Regno Unito di Elbit Systems, la quale produce l’85% della flotta di droni utilizzati per perpetrare il genocidio in Palestina.
Quello in corso rappresenta il più grande sciopero della fame coordinato nelle carceri britanniche dalla protesta del 1981 dei prigionieri repubblicani irlandesi dell’H-Block, che contestavano il rifiuto dello Stato britannico a riconoscerli come prigionieri politici. Durante i sette mesi di quella protesta, il governo Thatcher assistette alla morte di dieci giovani uomini prima di accogliere silenziosamente quasi tutte le loro richieste. Oggi come ieri, uno sciopero della fame collettivo dei detenuti viene accolto con un silenzio di tomba da parte dello Stato britannico. Ha fatto il giro dei social la risposta di David Lammy, ministro della Giustizia, quando è stato avvicinato dalla sorella di Kamran Ahmed, Shahmina Alam, al venticinquesimo giorno dello sciopero: «è davvero un peccato», ha commentato, «non ne sapevo niente».
Palestine Action, prima della sua prescrizione, aveva accusato il governo britannico di complicità nei crimini di guerra israeliani a Gaza e aveva dichiarato di essere «impegnata a porre fine alla partecipazione globale al regime genocida e di apartheid di Israele». Tuttora, le manifestazioni di disobbedienza civile a sostegno del gruppo stanno venendo fortemente represse dal governo britannico, che continua a non rilasciare dichiarazioni sullo sciopero della fame in corso nonostante le richieste formali anche da parte degli avvocati degli imputati. La solidarietà invece è arrivata da prigionieri di tutto il mondo: per un breve periodo, anche Jakhi McCray, Luca Dolce (detto Stecco) e Dimitris Chatzivasileiadis, detenuti negli Stati Uniti, in Italia e in Grecia, si sono uniti allo sciopero degli attivisti britannici.