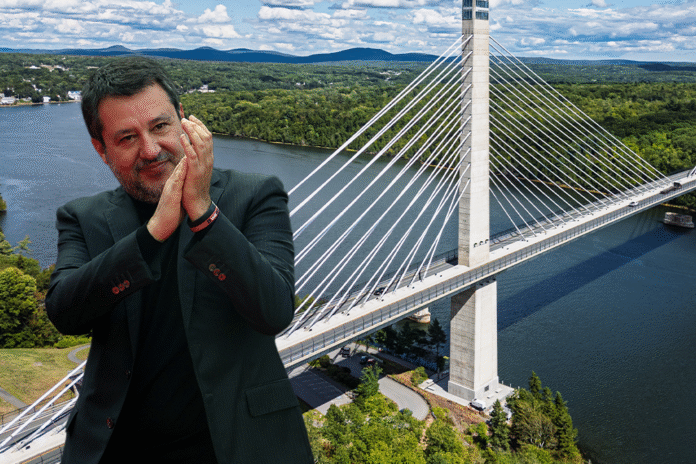Tra pochi minuti la cerimonia d’apertura suggellerà l’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina, segnate da militarizzazione, prezzi alle stelle e biglietti invenduti. Fino a due giorni fa risultavano ad esempio scoperti migliaia di seggiolini dello Stadio San Siro, dove si svolgerà parte della cerimonia. Gli organizzatori sono dunque corsi ai ripari, tra ribassi e offerte del 2×1 tipiche dei saldi invernali, cui si aggiungono i biglietti regalati a sponsor e politici. L’invenduto si palesa come una costante, che dall’evento inaugurale intreccia il cartellone dei prossimi giorni, per un totale di 1,2 milioni di biglietti staccati su 1,5 milioni stimati. L’Associazione italiana gestori affitti brevi riporta intanto che il dato delle case occupate è il peggiore degli ultimi 11 anni, lanciando l’allarme del flop turistico. Cortina e Milano risultano comunque altamente militarizzate, con uno schieramento di 6mila agenti italiani, cui vanno aggiunti quelli stranieri a seguito delle varie delegazioni.
4 categorie di posti a sedere, coi prezzi via via decrescenti all’allontanarsi dal prato di San Siro: questa la decisione della Fondazione Milano-Cortina (MICO), che per un biglietto di categoria A è arrivata a chiedere 2.026 euro. A seguire, 1.400 euro per la categoria B e la metà per quella C. Chiudono i 260 euro della “popolare” categoria D, corrispondente al terzo anello dello stadio. I circa 10mila biglietti invenduti a due giorni dalla cerimonia d’apertura avrebbero fatto allarmare gli organizzatori, che hanno così deciso di lanciare l’offerta del “compri 2 e paghi 1” ai minori di 26 anni intenzionati ad aggiudicarsi un posto nel terzo anello milanese. Una scelta dell’ultimo minuto che ha provocato non pochi malumori tra coloro che avevano comprato il biglietto a prezzo pieno.
Sempre nell’ottica del riempimento dello stadio, gli organizzatori avevano precedentemente messo in campo due strategie: vendere ai volontari fino a un massimo di quattro biglietti a testa, al prezzo singolo di 26 euro, e distribuire pacchetti di posti a sedere a sponsor e politici, come i consiglieri comunali di Milano. Ammonterebbero a circa 300mila i tagliandi destinati agli sponsor per l’interezza dei Giochi olimpici, che si aggiungono ai 900mila venduti sulla piattaforma ufficiale. Ciò restituisce un totale di 1,2 milioni di biglietti, il 20% in meno rispetto all’obiettivo iniziale fissato a 1,5 milioni.
Il tema dell’invenduto si rispecchia nella denuncia dell’Associazione italiana gestori affitti brevi, che al posto del boom turistico sperato si è ritrovata il tasso di occupazione delle case peggiore degli ultimi 11 anni. I proprietari puntano il dito contro il costo elevato dei biglietti per le gare delle Olimpiadi, denunciando una scarsa domanda di alloggi a fronte di un’offerta elevata. Nel frattempo c’è chi tenta il colpo grosso, arrivando a chiedere fino a 180mila euro per due settimane a Milano.
Il flop turistico delle Olimpiadi Milano-Cortina — quelle dagli ecosistemi stravolti, costi infiniti e opere rimaste incomplete — non ne ha intaccato la militarizzazione, per un dispiegamento di 6mila agenti italiani cui si aggiungono quelli stranieri arrivati a seguito delle varie delegazioni. Fa ancora discutere il caso ICE, al centro di un rimpallo che si protrae da giorni all’interno della politica italiana nonché tra quest’ultima e quella americana. Nelle scorse ore, infatti, la responsabile della Sicurezza e dei Servizi della delegazione statunitense, Nicole Deal, ha smentito la presenza dell’ICE in Italia, sconfessando la versione di Matteo Piantedosi. Due giorni fa il Ministro dell’Interno aveva confermato l’arrivo degli agenti USA, privati però delle «attività operative di polizia».
Ieri, mentre la Fiamma olimpica girava per Milano, centinaia di manifestanti hanno inscenato una protesta contro l’ICE e la partecipazione di Israele alle Olimpiadi. Il fine settimana vedrà l’organizzazione delle Utopiadi al Palasharp occupato, per una tre giorni di sport popolare che intende sfidare i riflettori delle Olimpiadi Milano-Cortina. «Contestiamo la militarizzazione delle città per eventi che hanno come solo scopo la privatizzazione di essa», scrivono i promotori, concentrando l’attenzione sulle conseguenze a corto raggio della militarizzazione, tra traffico e quartieri paralizzati, scuole chiuse, espulsione degli indigenti. «In una città che dà priorità al lusso e al profitto, che spinge ai margini chi la abita creando posto solo per i loro standard di ricchezza, ci schieriamo dalla parte degli espulsi e degli indesiderati, perché è lì che stiamo». Soltanto nelle ultime 48 ore due senza tetto sono stati stroncati dal freddo a Milano, portando a 6 il bilancio di morti da inizio anno, mentre la città era impegnata a spolverare le sue vetrine migliori in attesa del grande evento internazionale.