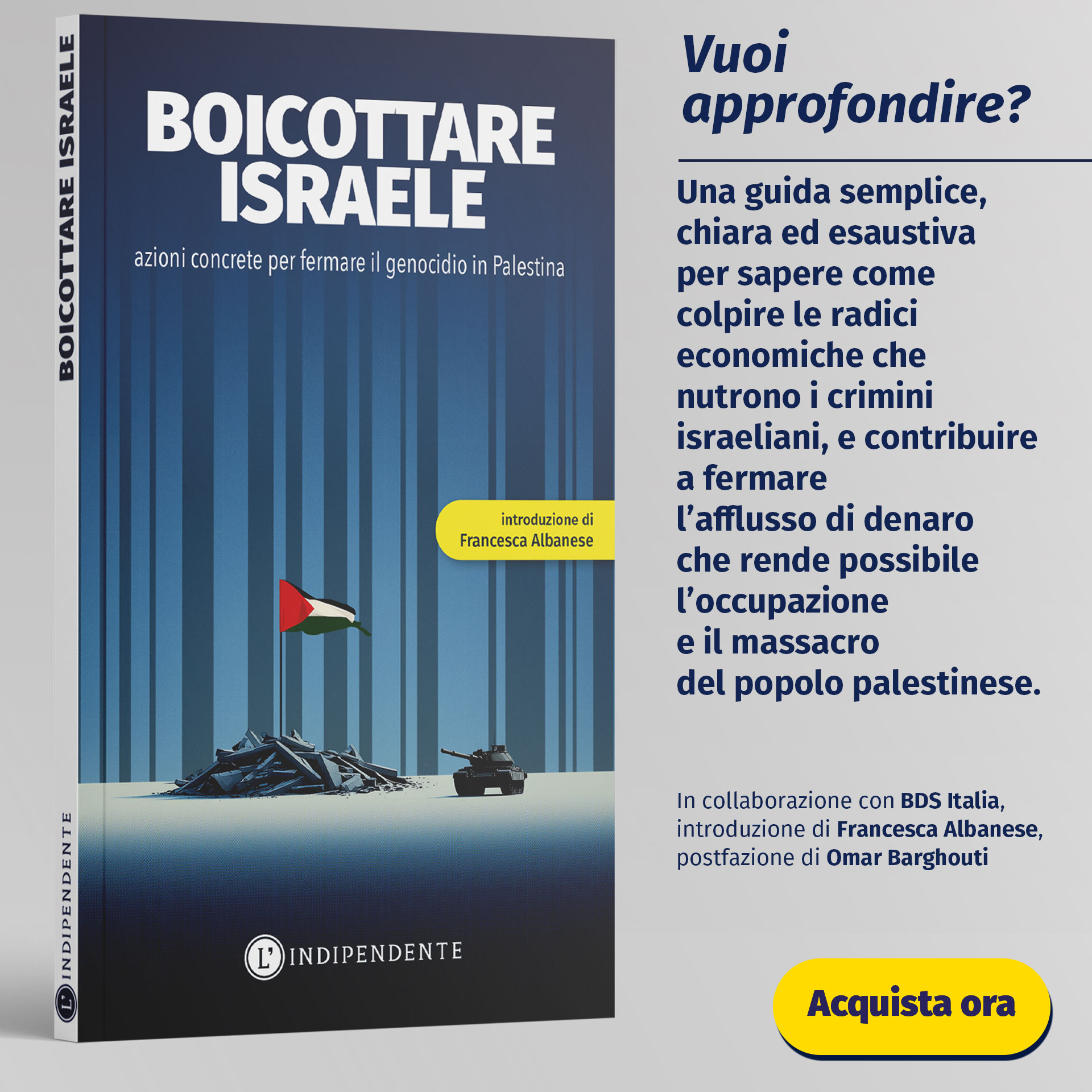Prosegue l’allerta meteo a Torino e in provincia dopo una notte di piogge intense: il Po è in crescita, con l’area dei Murazzi chiusa, e si prevedono ulteriori aumenti a valle per il contributo degli affluenti. Frane e piene hanno bloccato diverse strade nel Canavese e Pinerolese. Arpa Piemonte segnala «rischio rosso» in valli Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone e bassa Valsusa, e «arancione» in altre zone. Il presidente Cirio annuncia 4 centri provinciali, con oltre 1.000 volontari mobilitati per fronteggiare emergenze, invitando alla prudenza. Chiusa anche la A5 tra Quincinetto e Ivrea, poi riaperta parzialmente.
L’industria alimentare reintroduce l’olio di palma, cercando di non farsi notare
Negli ultimi anni la scritta «senza olio di palma» è diventata una delle più diffuse sugli scaffali dei supermercati e nelle pubblicità. Come forse ricorderete nel 2014 ci fu una intensa campagna mediatica contro questo grasso, da parte di associazioni ambientaliste e dei consumatori, che coinvolse diversi Stati europei e che portò ad un risultato spettacolare: la stragrande maggioranza delle aziende alimentari abbandonò l’olio di palma e lo sostituì con altri oli vegetali. L’unica assenza di rilievo fu la Ferrero, che ancora oggi utilizza questo grasso per la Nutella e decine di altri prodotti.
La produzione di olio di palma è responsabile infatti di una deforestazione significativa in Malesia e Indonesia (e di recente anche in Africa) e contribuisce alla scomparsa di alcune specie animali come gli oranghi (la loro popolazione è diminuita di oltre il 90% in un secolo sull’isola di Sumatra dove si è diffusa la piantagione dell’olio di palma). L’olio di palma ha inoltre sollevato molte preoccupazioni per la salute collettiva anche da parte di enti che si occupano della salute pubblica, come l’OMS, la FAO e l’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare). Queste hanno infatti sottolineato a più riprese la necessità di limitare, da parte dell’industria, l’utilizzo di questo grasso nei prodotti alimentari (quali merendine, biscotti, cornetti e brioches, salse pronte, gelati, piatti pronti, torte confezionate ecc.) e nelle fritture della ristorazione collettiva (mense, ristoranti). Il motivo è soprattutto quello che la raffinazione dell’olio di palma messo in atto dall’industria porta allo sviluppo di contaminanti tossici e cancerogeni, come gli esteri degli acidi grassi (GE) e il glicidolo (sostanze che si ritrovano anche nella panatura dei bastoncini di pesce di cui abbiamo parlato qualche giorno fa).
In conseguenza di tutto ciò, l’olio di palma fu quasi del tutto abbandonato nel 2018 dall’industria alimentare e sostituito in prevalenza con olio di girasole e di colza. Tuttavia, nel 2022 c’è stata una ripresa dell’impiego di questo grasso da parte delle aziende. Il motivo: lo scoppio della guerra in Ucraina. In sostanza, dal 2022 ad oggi l’olio di palma è tornato piano piano nelle nostre tavole per colpa dei rincari folli dell’olio di girasole. Il rincaro è dovuto al fatto che l’Ucraina detiene il 60% della produzione e il 75% dell’export mondiale, essendo il principale coltivatore di girasoli al mondo, come dichiarato da Assitol, l’associazione italiana dell’industria olearia. Le difficoltà create dalla guerra per le esportazioni dell’olio dall’Ucraina, hanno determinato la crisi di questa materia prima e il conseguente rialzo dei prezzi del 66%.
La deroga del Governo italiano

A quel punto le industrie alimentari hanno smesso di utilizzare l’olio di girasole e si sono subito fiondate sull’olio di palma e su altri oli vegetali, chiedendo anche al Governo, in Italia, una deroga temporanea affinché esse potessero riportare sulle etichette dei prodotti una dicitura generica di «oli vegetali» per poter utilizzare vari tipi di olio al posto di quello di girasole, in particolare quello di palma. E ottenendo infatti già a Marzo 2022 una deroga dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha dato il via libera all’operazione. Ma nel frattempo i prezzi dell’olio di girasole sono tornati al loro valore di partenza e l’emergenza è quindi rientrata. Anche perché in realtà l’Ucraina, nonostante la guerra, è riuscita a garantire l’esportazione puntando oltre al trasporto via mare, anche su quello ferroviario e su gomma e i prezzi si sono progressivamente sgonfiati dall’estate dell’anno scorso allineandosi ai livelli precedenti la guerra. Pertanto adesso sarebbe opportuno che l’industria sospendesse l’uso dell’olio di palma e tornasse ad usare quello di girasole, per logica. Non bisogna dimenticare infatti, oltre al devastante impatto ambientale dell’olio di palma, anche i timori che esso fa sorgere da tempo per la salute delle persone. Si sappia che per quanto riguarda la problematica ambientale l’Italia ha addirittura vietato l’impiego di olio di palma e olio di soia per la produzione di biocarburanti e di elettricità a partire dal 1 gennaio 2023, grazie ad una petizione parlamentare per iniziativa di Legambiente.
I timori inerenti la salute
Al di là di aspetti economici, commerciali e ambientali, comunque importanti, bisogna parlare di questa ripresa e reimpiego dell’olio di palma in numerosi prodotti alimentari soprattutto per il fatto che quest’olio comporta degli aspetti di pericolosità per la salute dei consumatori. Infatti esso ha un contenuto di sostanze nocive, che si formano durante i processi di raffinazione, dieci volte superiore rispetto a quello degli altri oli vegetali raffinati, e in particolare dell’olio di girasole. La pericolosità e nocività di queste sostanze è attestata dal parere ufficiale congiunto degli esperti dell’OMS e della FAO, oltre che dal parere tecnico-scientifico di EFSA, l’autorità europea per la sicurezza alimentare, secondo la quale, alla data di emissione del parere, non erano solo i lattanti a rischiare un’esposizione eccessiva ai contaminanti tossici dell’olio di palma GE e 3-MCPD, ma anche bambini e adolescenti consumatori di grandi quantità di dolci confezionati, snack e biscotti. Vorrei ricordare infatti che l’olio di palma si aggiungeva da anni anche nelle formulazioni di latte artificiale in polvere per neonati, prima di essere sostituito da olio di girasole, di colza e di cocco.
Prodotti che contengono ancora olio di palma
Alla data odierna ci sono ancora diversi prodotti alimentari in commercio che impiegano questo olio. Possiamo citare alcuni risotti pronti, gelati in biscotto, snack da aperitivo, creme spalmabili alla nocciola, salse da condimento e sughi pronti. Ora non resta altro da fare che aspettare e vedere se le aziende alimentari torneranno ad un comportamento più responsabile nei confronti dei consumatori e dell’ambiente (almeno nelle intenzioni e all’apparenza) come fu nel 2018 quando abbandonarono spontaneamente l’uso di questo grasso. Il tempo ci mostrerà le vere intenzioni dell’industria e le sue scelte, se saranno a favore della collettività o del loro mero interesse economico. Segnalo infatti che l’olio di palma è un grasso che consente all’industria maggiori profitti rispetto a quello di girasole o al burro, infatti costa 3-4 volte meno di questi altri grassi.
Israele getta la maschera: l’occupazione di Gaza sarà permanente
La politica di Israele a Gaza è «chiara e inequivocabile»: è il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, a gettare la maschera su quello che era ormai evidente e sotto gli occhi di tutti. E questa consiste di alcuni punti fondamentali: occupare in maniera permanente la Striscia e bloccare tutti gli aiuti umanitari alla popolazione, proseguendo nel mentre con bombardamenti ininterrotti. Con il pretesto di creare una «zona cuscinetto» tra i palestinesi e gli insediamenti israeliani illegali, l’IDF (Israel Defence Forces, l’esercito israeliano) «non abbandonerà le zone bonificate e conquistate». Allo stesso tempo, al fine di esercitare pressioni su Hamas, verranno bloccati tutti gli aiuti umanitari, mentre saranno condotti «attacchi continui contro i terroristi di Hamas e le infrastrutture terroristiche».
Come per Libano e Siria, dunque, l’esercito israeliano non abbandonerà le zone della Striscia di Gaza attualmente occupate. La dichiarazione è una prima ammissione pubblica esplicita delle politiche israeliane, ma è qualcosa di largamente atteso da tempo, che rientra negli obiettivi di Israele sin dall’inizio dell’aggressione contro Gaza. Come svelato pochi giorni fa dal quotidiano Haaretz, che aveva pubblicato i progetti fino ad ora rimasti segreti del governo di Netanyahu, il 16% dell’enclave sarà infatti destinato a diventare una «zona cuscinetto», nella quale le case dei palestinesi (o quel che ne rimane) saranno completamente rase al suolo e sarà vietato del tutto il ritorno dei legittimi proprietari. Contemporaneamente, sarà creato un corridoio, situato nel mezzo della Striscia, che permetterà a Israele di «controllare il traffico sulle strade strategiche, che sono al centro dei negoziati con Hamas».
L’occupazione permanente della Striscia rientrava poi nel piano presentato da Netanyahu a pochi mesi dall’inizio dell’aggressione militare contro Gaza ed è stato sostanzialmente riconfermato nella proposta di “pace” avanzata da Israele alla fine dello scorso anno. Ancora prima che Trump avanzasse i propri progetti di ricostruzione della Striscia per renderla la «Riviera del Medio Oriente», poi, l’ufficio del primo ministro israeliano aveva reso pubblico un progetto avvenieristico, nel quale si ipotizzava di rendere la Striscia un futuristico hub commerciale. Il piano di occupazione gode inoltre del pieno appoggio dell’alleato numero uno di Israele, ovvero gli Stati Uniti: era stato proprio il presidente statunitense Trump a dichiarare, qualche settimana fa, che «I palestinesi non avranno il diritto al ritorno nelle proprie case».
A questa ammissione il ministro della Difesa Katz ne aggiunge un’altra, resa nella maniera più esplicita possibile proprio per spazzare via ulteriori dubbi sulle intenzioni israeliane. «Impedire l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza è uno dei principali strumenti di pressione, che impedisce ad Hamas di usare questa misura contro la popolazione, oltre alle altre misure che Israele sta adottando» ha dichiarato senza mezzi termini, aggiungendo, a scanso di equivoci, che «nella realtà attuale, nessuno è disposto a portare aiuti umanitari a Gaza e nessuno si prepara a far entrare alcun tipo di aiuto».
Da quando Israele ha deliberatamente violato e fatto decadere il cessate il fuoco, nella Striscia la popolazione è tornata a soffrire la fame e la sete a livelli allarmanti. Secondo gli ultimi aggiornamenti delle Nazioni Unite, il 91% della popolazione di Gaza, ovvero 1,95 milioni di persone, si trova in una situazione di carenza di cibo e acqua. Questo in un contesto dove oltre l’80% dei terreni coltivabili è stato distrutto, insieme al 55% dei sistemi di irrigazione, insieme al 75% delle navi da pesca, mentre il 95% del bestiame è morto. A questo si aggiunge il fatto che l’accesso all’acqua potabile non è garantito nel 91% delle case, che viene associato anche a un grave rischio di contrarre malattie gravi. Due terzi della della popolazione di Gaza riceve meno di 6 litri di acqua al giorno per bere e cucinare.
Il deliberato utilizzo dell’affamamento della popolazione come strumento di guerra e di pressione costituisce un crimine di guerra, ai sensi del diritto internazionale al quale Israele dovrebbe, in teoria, sottostare. Come già spiegato in passato da varie ONG per la tutela dei diritti umani, oltre che da esperti ed organizzazioni internazionali, privare la popolazione delle risorse necessarie per la sopravvivenza e violare gli obblighi imposti dalla Corte dell’Aja in merito all’invio di aiuto ai civili sono decisioni che dovrebbero – almeno in teoria – costare pesanti sanzioni a Israele. Il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che, in quanto «potenza occupante», Israele ha «obblighi inequivocabili» derivanti dal diritto internazionale, in particolare in materia di diritti umani e umanitari – dei quali il blocco degli aiuti umanitari costituisce una grave violazione. Nel frattempo, «ai punti di attraversamento, si accumulano cibo, medicine e rifornimenti per ripari, e attrezzature vitali restano bloccate».
Nelle frattempo, almeno 35 persone sono state uccise ieri negli attacchi israeliani sulla Striscia, portando così il numero dei civili assassinati nel corso dell’aggressione (che dura ormai ininterrottamente da 18 mesi) a oltre 51 mila secondo il ministero della Sanità di Gaza, mentre superano i 116 mila i feriti. L’ufficio stampa del governo di Gaza, citato da Al Jazeera, sostiene invece che il conteggio reale delle vittime ammonti ad almeno 61.700, tenuto conto del fatto che è improbabile che le migliaia di persone ancora schiacciate sotto le macerie vengano ritrovate vive.
California, causa contro i dazi di Trump
La California ha intentato una causa per bloccare i dazi doganali imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A portare avanti la causa è stato il governatore democratico Gavin Newsom, che accusa Trump di aver fatto un uso illegittimo dell’International Emergency Economic Powers Act nell’imporre le tariffe a vari Paesi del mondo. Nel frattempo, Trump ha aumentato i propri dazi sui prodotti cinesi al 245%, mentre la Cina ha detto che non ha intenzione di rispondere al «gioco dei numeri» degli Stati Uniti.
Congo, incendio su una barca: 50 morti
Un’imbarcazione si è capovolta dopo aver preso fuoco nel nord-ovest della Repubblica Democratica del Congo, causando almeno 50 morti e centinaia dispersi. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di martedì, ed è stata riportata oggi. L’imbarcazione trasportava circa 400 passeggeri e, al momento dell’incendio, si trovava sul fiume Congo, all’altezza della città di Mbandaka, nella Provincia dell’Equatore. La ricerca dei dispersi è iniziata ieri, ed è ancora in corso. L’incendio sarebbe avvenuto mentre una persona stava cucinando.
ENI si accorda con l’argentina per sfruttare il gas estratto devastando la Patagonia
Il CEO del colosso fossile italiano ENI, Claudio Descalzi, e il presidente e amministratore delegato della compagnia petrolifera partecipata argentina YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), Horacio Marín, hanno ufficialmente siglato un memorandum d’intesa per la cooperazione nello sviluppo del progetto Argentina GNL. A renderlo noto è stata la stessa YPF al termine di una riunione tra i vertici delle due aziende. L’obiettivo è il trasporto, la liquefazione e la successiva esportazione del gas prodotto dal grande giacimento di gas di Vaca Muerta, in Patagonia. Nel giacimento in questione il gas è estratto con la tecnica del fracking (fratturazione idraulica), che richiede l’impiego di elevatissime quantità di acqua ed è causa di frequenti e documentati episodi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere, per via degli sversamenti di sostanze tossiche e fanghi petroliferi. Le operazioni hanno inoltre luogo in un territorio parte delle terre ancestrali del popolo indigeno Mapuche, che da tempo si batte contro queste operazioni.
Argentina GNL è il progetto con cui il Paese intende divenire un esportatore energetico affidabile a livello mondiale, con un mercato da 30 miliardi di dollari l’anno entro il 2030, come annunciato dallo stesso Marín. Il tutto può avvenire grazie alle risorse custodite da Vaca Muerta, una formazione geologica situata sul bacino di Neuquén, in Patagonia, e che comprende parte delle province di Neuquén, Río Negro, Mendoza e La Pampa. Si tratta di una formazione geologica “non convenzionale”, il che significa che l’estrazione deve essere effettuata con il metodo del fracking, estremamente dannoso per l’ambiente e per le popolazioni indigene che vi abitano, oltre che possibile causa di eventi sismici. Detta anche fratturazione idraulica, la tecnica consiste nell’estrarre petrolio o gas di scisto da rocce argillose nel sottosuolo. Si effettu una prima perforazione finalizzata a raggiungere i giacimenti nei quali, successivamente, si inietta ad alta pressione una miscela di acqua, sabbia e prodotti chimici di sintesi allo scopo di facilitare la fuoriuscita della risorsa fossile. In primo luogo, alla luce delle grandi quantità di acqua richieste, va citato l’enorme spreco idrico: basti pensare che ogni pozzo avrebbe bisogno tra i 100 mila e i 27 milioni di litri d’acqua. In secondo luogo, c’è l’elevatissimo rischio di contaminazione delle falde acquifere e del suolo, poiché gran parte del liquido iniettato, contenente in media 14 differenti additivi chimici, non riemerge e rimane nel sottosuolo. Inoltre, è stato appurato che questa tecnica può causare eventi sismici.
Ricca di fossili di dinosauri e giacimenti di idrocarburi, Vaca Muerta si estende per circa 30.000 chilometri quadrati. Sono 31 i progetti di estrazione totali per questa vasta zona, di cui solo 5 in fase di produzione. Tra i protagonisti dell’estrazione vi sono YPF e Tecpetrol, oltre tutta la solita schiera di grandi multinazionali del settore. Uno studio pubblicato dalla ONG argentina Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) ha rilevato che Vaca Muerta potrebbe rappresentare dal 57% al 67% delle emissioni nazionali di gas serra del Paese entro il 2030. All’industria estrattiva, così come allo sfruttamenti ambientale in generale, si sono sempre opposti i Mapuche, popolo originario che vive in una estesa porzione di territorio che comprende Cile e Argentina. Le motivazioni della loro lotta socio-ecologica sono due: tutela del territorio e conservazione dell’ambiente naturale (da cui traggono la loro economia di sussistenza). I mega-progetti di estrazione fossile occupano terreno, portando all’espropriazione e all’espulsione da vaste aree. Le attività di estrazione creano poi un impatto ambientale enorme su aria, acqua e suolo, distruggendo l’habitat naturale da cui i Mapuche trovano nutrimento, fisico e spirituale.
Sono state numerose, negli anni, le proteste del popolo mapuche contro lo sfruttamento delle risorse della zona, così come i tentativi di dialogo con la YPF. Tuttavia, con l’insediarsi del governo Milei la situazione non sembra che peggiorare per i legittimi proprietari di queste terre: lo scorso anno, il governo ha infatti inviato 300 militari a presidiare il giacimento, al fine di impedire ai mapuche di interferire con le operazioni estrattive.
Il Messico non rinnoverà le relazioni diplomatiche con l’Ecuador
La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato che il Messico non rinnoverà le relazioni diplomatiche con l’Ecuador finché il presidente ecuadoriano Daniel Noboa rimarrà in carica. La rottura arriva dopo la vittoria di Daniel Noboa alle elezioni presidenziali, contestata dall’opposizione. I rapporti tra Messico ed Ecuador sono tesi dall’aprile dello scorso anno, quando la polizia ecuadoriana ha fatto irruzione nell’ambasciata messicana a Quito per arrestare Jorge Glas, ex vicepresidente ecuadoriano accusato di corruzione, che si trovava nell’edificio dopo una richiesta di asilo. Dopo l’irruzione, il Messico aveva interrotto le proprie relazioni diplomatiche con il Paese.
I relatori ONU (di nuovo) contro il dl Sicurezza: “lede i diritti umani, va abrogato”
Dopo la lettera risalente a qualche mese fa, nella quale si esprimeva il timore che le norme contenute nel nuovo dl Sicurezza potessero ledere i diritti umani e civili dei cittadini italiani, cinque relatori speciali delle Nazioni Unite sono tornati a scrivere al governo italiano, per chiedere la definitiva abrogazione della norma recentemente approvata. I relatori si sono detti «allarmati» dalla modalità con la quale il governo ha velocizzato l’approvazione della norma (trasformata in un decreto legge per renderne più rapida l’approvazione, aggirando la discussione in Parlamento), impedendo così «il controllo pubblico» sulla decisione. La norma, riferiscono gli esperti, prevede «definizioni vaghe e ampie disposizioni relative al terrorismo che potrebbero portare a un’applicazione arbitraria» oltre a «mettere a rischio la libertà di espressione», colpendo «in modo sproporzionato gruppi specifici», soprattutto tra le minoranze.
Il decreto Sicurezza è stato approvato lo scorso venerdì 4 aprile, anche se con qualche ridimensionamento a causa delle osservazioni avanzate dal Colle circa l’incostituzionalità di alcuni passaggi. Molte delle misure-bandiera della maggioranza sono tuttavia rimaste intatte: tra queste, il carcere fino a due anni per i blocchi stradali, il divieto di vendita e consumo di cannabis “light”, il nuovo reato contro le occupazioni abusive, l’aumento del tetto al rimborso delle spese legali per i membri delle forze dell’ordine che affrontano il processo e la possibile autorizzazione agli appartenenti ai servizi segreti a partecipare e dirigere associazioni terroristiche o mafiose.
Nella loro seconda lettera indirizzata al governo italiano, i relatori speciali dell’ONU hanno ricordato come avessero già in precedenza segnalato che l’approvazione delle norme contenute nel decreto avrebbe comportato la violazione, da parte dell’Italia, dei suoi «obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani, tra cui quello di proteggere i diritti alla libertà di movimento, alla privacy, a un processo equo e alla libertà, e di proteggere dalla detenzione arbitraria». Come già sottolineato in precedenza, il decreto include «definizioni vaghe e ampie disposizioni relative al terrorismo che potrebbero portare a un’applicazione arbitraria». I relatori avevano segnalato che, in caso di approvazione, il decreto Sicurezza avrebbe potuto contenere violazioni di numerose normative internazionali, tra le quali: «l’art. 9 (diritto alla libertà e alla sicurezza e la proibizione della detenzione arbitraria), 12 (diritto alla libertà di movimento), 14 (diritto a un giusto processo), 17 (diritto alla privacy), 19 (diritto alla libertà di espressione e opinione), 21 (libertà di riunione pacifica) e 22 (libertà di associazione) del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR)». Il testo potrebbe anche contenere violazioni degli obblighi dell’Italia specificati all’interno della Convenzione Aarhus (sui diritti dei cittadini alla partecipazione nei processi decisionali e all’accesso alla giustizia sui temi ambientali) della Commissione Economica per l’Europa (UNECE), ratificata dall’Italia nel 2001.
Nel frattempo, il decreto appena entrato in vigore potrebbe già fare acqua da tutte le parti. Nel difendere un ragazzo al quale è stato contestato il reato di resistenza aggravata per non essersi fermato a un posto di blocco e per aver discusso successivamente con le forze dell’ordine, l’avvocato difensore Eugenio Losco ha presentato, in sede di udienza, la questione di costituzionalità del decreto, in quanto mancherebbero le ragioni di «necessaria e straordinaria urgenza» per l’approvazione del “pacchetto Sicurezza” in fretta e furia.
Il Ghana caccia le aziende straniere dalle miniere d’oro e avvia la nazionalizzazione
Il Ghana ha cacciato le aziende straniere dal suo mercato dell’oro, ordinando di cessare la compravendita e l’esportazione del metallo prezioso entro la fine di aprile e revocando le licenze di esportazione in vigore fino ad ora, sia alle compagnie straniere che a quelle locali. Contemporaneamente, la nazione maggiore produttrice di oro del continente africano ha istituito un nuovo unico ente statale autorizzato ad acquistare, vendere, certificare e esportare oro artigianale, chiamato GoldBot. Secondo quanto dichiarato dalla nuova autorità statale, gli stranieri e le società estere potranno presentare domanda solo «per acquistare o ritirare oro direttamente dal GoldBod». L’obiettivo è quello di trarre maggiori benefici dalle vendite di oro, mantenere la stabilità della valuta nazionale e contrastare il contrabbando. Come ha spiegato il ministro delle Finanze del Ghana, Cassiel Ato Forson, il precedente «sistema frammentato, non coordinato e non regolamentato ha portato a un diffuso contrabbando di oro e ha privato lo Stato di valuta estera di cui aveva tanto bisogno». Il nuovo ente statale permetterà di abbandonare un sistema in cui sia le compagnie locali che quelle straniere potevano acquistare l’oro senza rispettare le norme approvate.
Nel 2024, le esportazioni di oro della nazione africana sono cresciute del 53,2%, raggiungendo gli 11,64 miliardi di dollari, di cui quasi 5 miliardi provenienti da attività minerarie legali su piccola scala. Inoltre, il valore dell’oro sta rapidamente salendo a causa della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina che ha spinto gli investitori a comprare il metallo prezioso per mettersi al riparo dall’incertezza economica e geopolitica: venerdì scorso, il prezzo del metallo giallo ha superato per la prima volta i 3.200 dollari l’oncia. Una circostanza che permetterà al Ghana di ottenere ulteriori profitti dalla gestione esclusiva del suo mercato dell’oro. Inoltre, il nuovo programma sull’oro del Ghana mira a conseguire la rigida certificazione della London Bullion Market Association, che vieta alle raffinerie di maneggiare oro proveniente da fonti che contribuiscono ad abusi dei diritti umani, conflitti, criminalità o degrado ambientale.
Rispetto alla questione ambientale, già nell’ottobre del 2024 il governo ghanese aveva revocato una legge che consentiva l’estrazione mineraria nelle riserve forestali, dopo le proteste dei cittadini. La norma, risalente al novembre 2022, consentiva l’estrazione nelle riserve forestali e, secondo la popolazione, stava ampliando la pratica del galamsey, consistente nell’estrazione mineraria illegale su piccola scala. I manifestanti, guidati dal gruppo che rappresenta tutti i sindacati del Ghana, avevano quindi minacciato un blocco nazionale e richiesto il ritiro della dibattuta norma, ottenendo rapidamente l’ascolto del governo, guidato fino allo scorso anno da Nana Akufo-Addo, che aveva accolto parte delle richieste. Oggi, nonostante il cambio di governo dopo le elezioni di dicembre, vinte da John Dramani Mahama, la nuova amministrazione continua a mantenere un occhio di riguardo per la questione ambientale.
Sul piano economico e della nazionalizzazione delle risorse, invece, diverse nazioni africane hanno cominciato negli ultimi anni a estromettere dalle loro miniere d’oro le multinazionali straniere per dirottare i profitti a beneficio dello sviluppo nazionale e non di società estere. Nell’agosto del 2024 era stato il Burkina Faso a concludere un accordo del valore di 80 milioni di dollari per nazionalizzare le miniere d’oro di Boungou e Wahgnion, precedentemente appartenenti a una società privata. Lo scorso gennaio, invece, il governo del Mali aveva sequestrato all’azienda di estrazione mineraria Barrick Gold, la seconda più importante al mondo, le scorte del metallo prezioso estratte dal complesso minerario di Loulo-Gounkoto. La società era stata accusata di non aver rispettato i termini di un accordo siglato con il governo, finalizzato a raggiungere una più equa redistribuzione delle ricchezze derivanti dallo sfruttamento delle risorse minerarie del Paese. I Paesi africani si stanno così muovendo sempre di più nella direzione della tutela delle loro ricchezze naturali: nazionalizzare le miniere d’oro significa, infatti, riportare le risorse minerarie e i relativi rendimenti nelle mani dello Stato, garantendo che i profitti derivanti dall’estrazione rimangano nel Paese. Anche il Ghana sembra avere intrapreso questo percorso, in nome della difesa degli interessi nazionali e del benessere della popolazione locale e contro lo sfruttamento selvaggio delle multinazionali straniere. La difesa delle risorse nazionali tramite le nazionalizzazioni rientra in un più ampio contesto di lotta per l’indipendenza e la sovranità che accomuna diversi Paesi africani, soprattutto nell’area del Sahel, per decenni soggiogati dalle politiche imperialiste di diversi Stati occidentali.