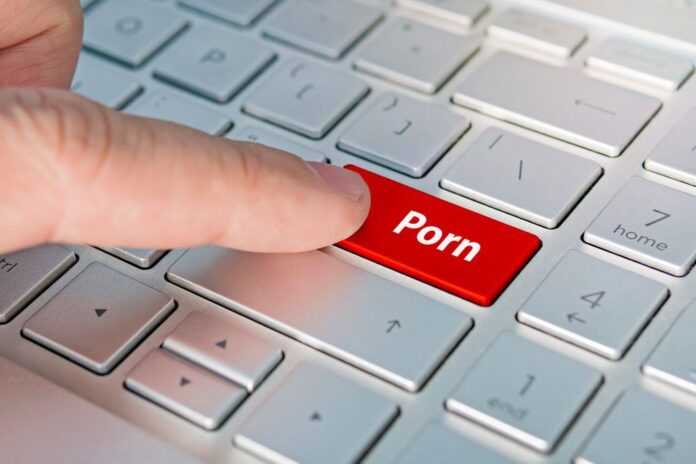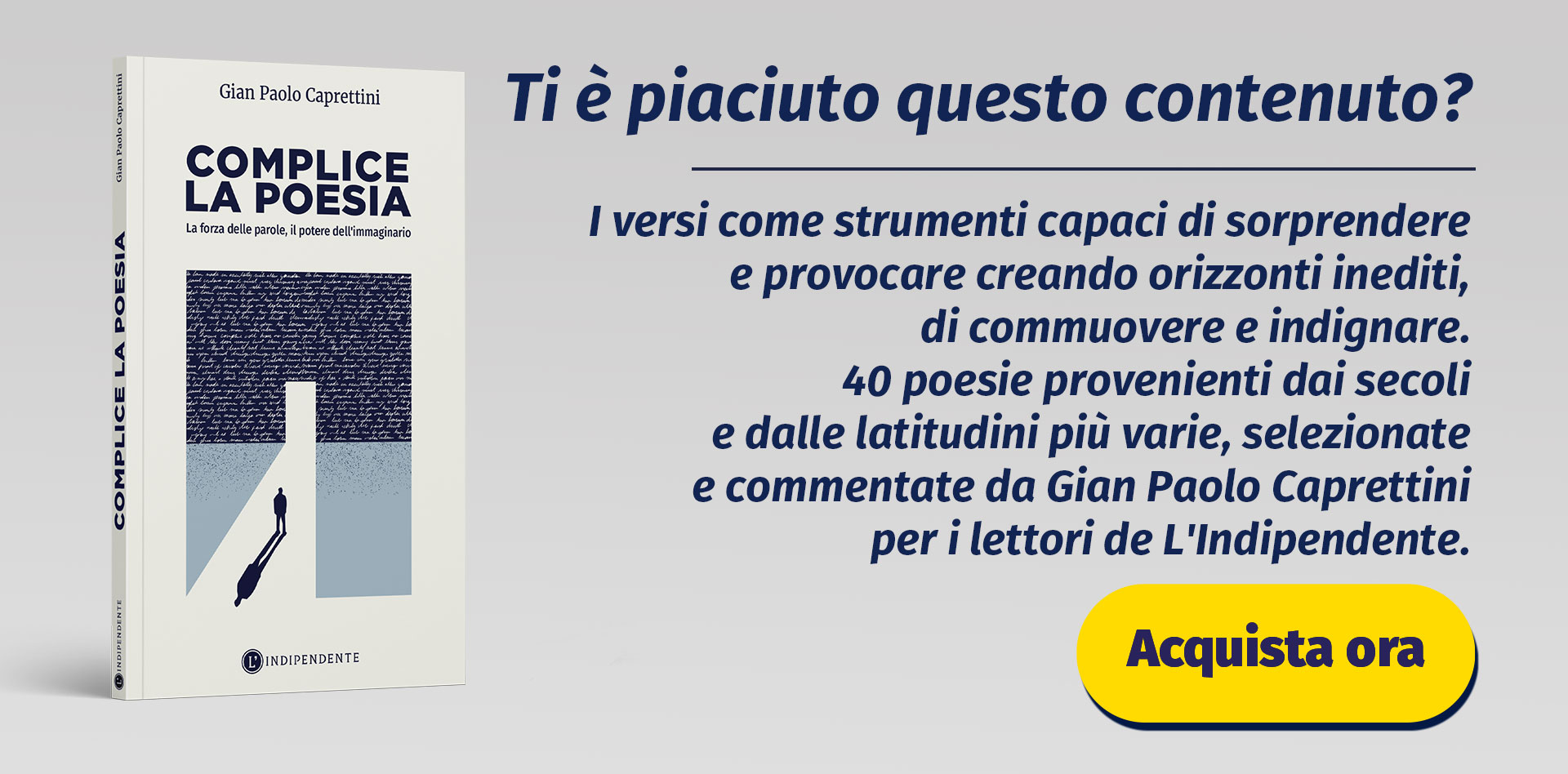Allora un eremita, che visitava la città una volta l’anno, si fece avanti e disse: Parlaci del Piacere.
Ed egli rispose, dicendo:
Il piacere è un canto di libertà,
Ma non è la libertà.
È la fioritura dei vostri desideri,
Ma non è il loro frutto.
È un richiamo profondo verso una vetta,
Ma non è il fondo né il culmine.
È l’uccello in gabbia che prende il volo,
Ma non è lo spazio imprigionato.
Sì, in verità il piacere è un canto di libertà,
E io vorrei che lo cantaste a cuore aperto; ma temo che a cantarlo perdereste il cuore.
(da G. Kahlil, Gibran. Il profeta, 1923)
Il piacere ha una forma indeterminata: ha la consistenza di un canto che tuttavia non può celebrarsi come libertà. Esce dai confini che esso stesso ha determinato, si presenta come un fiore perché sboccia ma non si può raccogliere come un frutto dei desideri. Il piacere sfugge, vola, eppure c’è. Il piacere è contraddizione a cielo aperto, non può essere circoscritto dai sentimenti, esalta ma non appaga. E il cuore non può sostenerlo.
Questa profezia di Gibran, cioè questa dimostrazione che le parole non possono dire i sentimenti, ci incoraggia a trattare la libertà come una sfida indicibile, che nessuno può dire davvero in che cosa consista. Saziare i bisogni, come Gibran mostra altrove a proposito dell’amicizia, qui nel desiderio e nella libertà è fuori luogo, al massimo illude.
Stavo leggendo Pasolini per ricordarlo nel suo anniversario e mi sono imbattuto in questa espressione, da un suo articolo dell’ottobre 1973: «il canone del conformismo è una fonte di violenza». C’è un ordine, un ordine qualsiasi che emana da norme non scritte, eppure potenti: «Norme per eccellenza. Le norme della normalità», annota Pasolini. E ancora: «Quasi sempre i conformisti sono teppisti: cioè oppongono al vero scandalo della ricerca libera e critica, il falso scandalo dell’accettazione di una cultura stabilita».
Conformismo e piacere stanno dunque in una contraddizione originaria e permanente. Il conformismo non può generare vero piacere e quindi va a provocare violenza verso chi si allontana dalle norme della normalità.
Dobbiamo dunque diventare profeti, non distruggere le gabbie ma insegnare a volare, puntare alla vetta trascurando quale sia il fondo, quello che abbiamo lasciato, e la vetta, quella che forse non raggiungeremo mai.
Il profeta non è uno che azzecca le previsioni ma è un oracolo che trasmette verità enigmatiche, forse anche scomode, che si rivelano lentamente o improvvisamente, comuque lontane da qualsiasi calcolo. La libertà, per finire, è imponderabile, è irraggiungibile perché sposta sempre più in là o più in qua la propria meta. Coincide con la vita stessa.
«Sono infatti scrittore – afferma Pasolini in un altro suo pezzo giornalistico, anche questo raccolto poi in Descrizioni di descrizioni (Einaudi 1979, p. 170): e questo rapporto di nostalgia per la intensità, la completezza, la purezza della vita – che si manifesta solo nelle vite altrui, sia in quelle tragiche che in quelle ridicole, sia in quelle povere che in quelle ricche – è il rapporto che mi permette di esprimerla…al di là del male e del bene…, di cui faceva parte la lotta degli sfruttati contro gli sfruttatori, di una cultura potenziale contro la cultura reale».
Una profezia permanente dunque che mezzo secolo dopo Pasolini o cent’anni dopo Gibran si misura come infinita e misteriosa apertura dell’intelligenza del cuore.