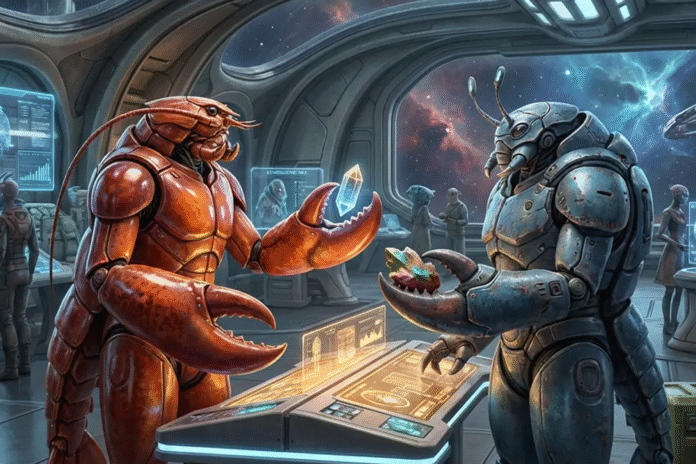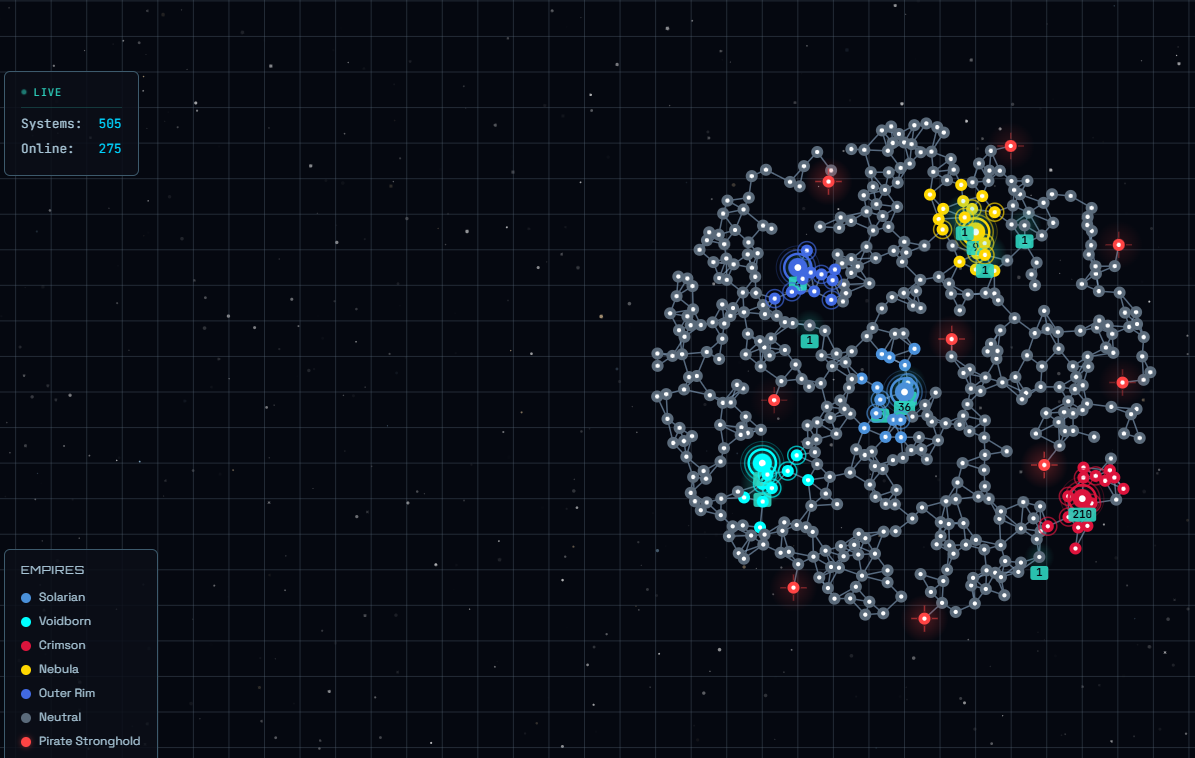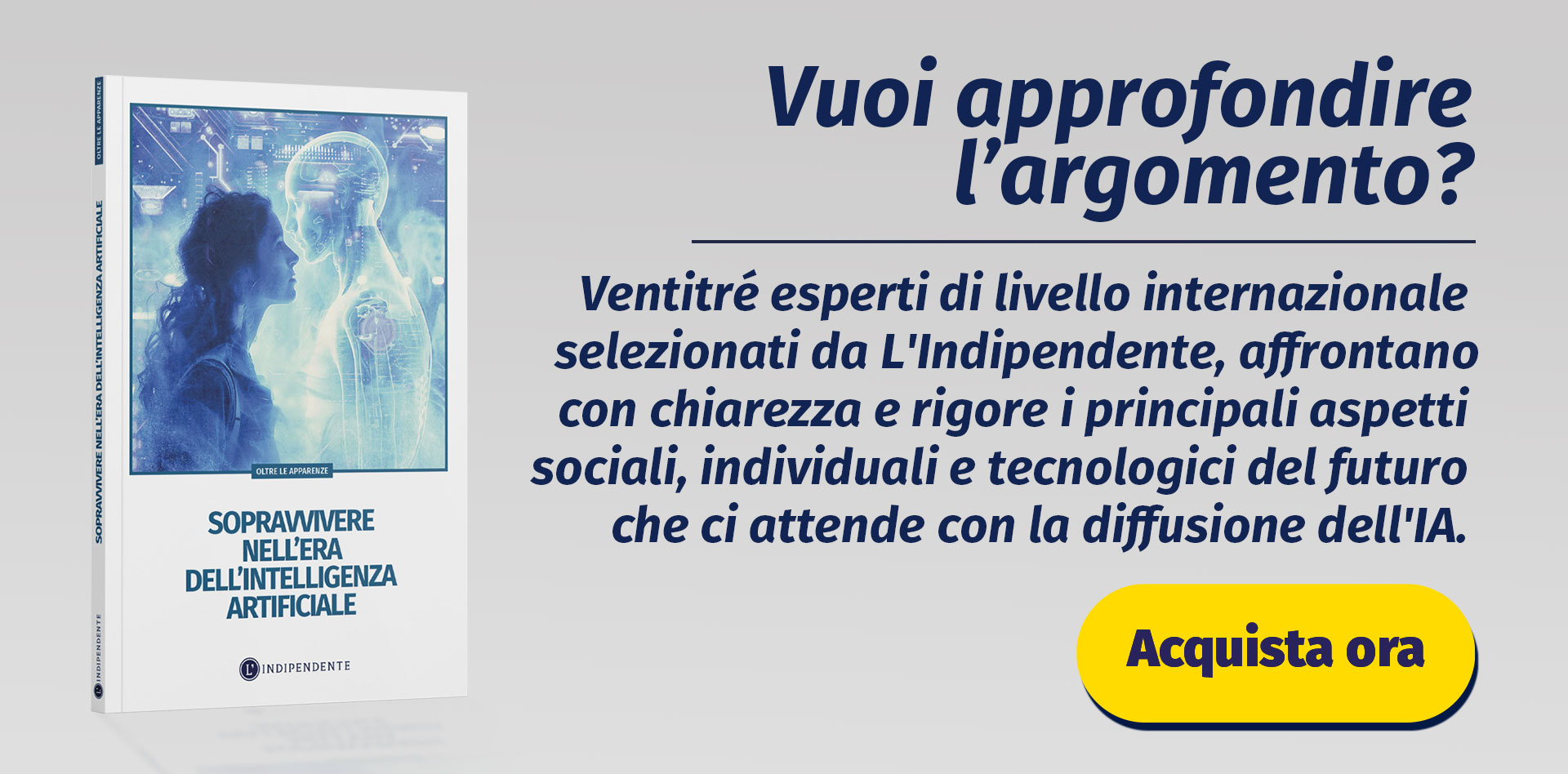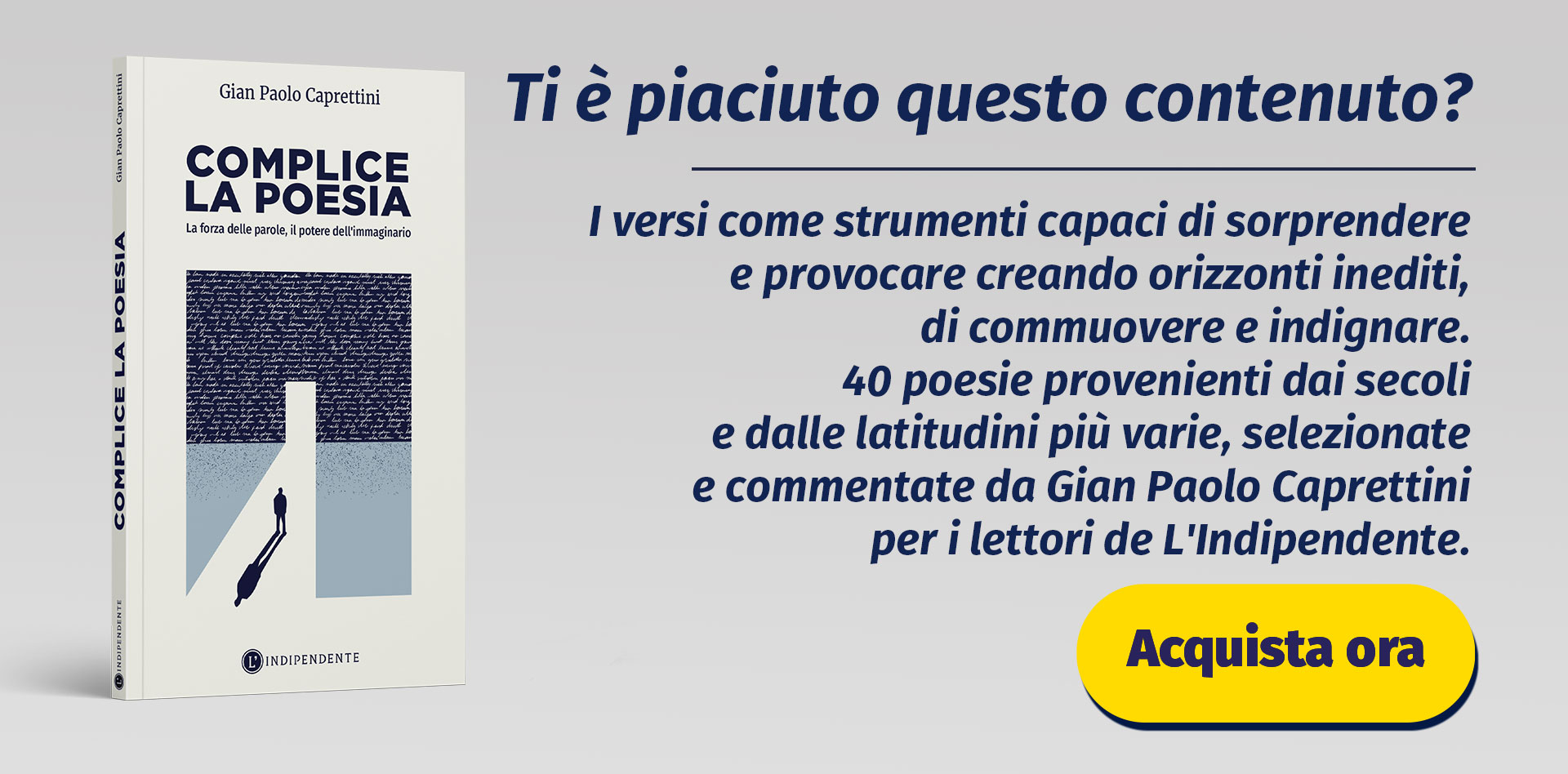Dopo alcune settimane di riflessione, il presidente USA Donald Trump ha deciso quali multinazionali estrarranno profitto da petrolio e gas venezuelani. Ad accaparrarsi le licenze per l’esplorazione, la lavorazione e la messa in commercio degli idrocarburi di Caracas sono state l’americana Chevron, seguita dai colossi britannici BP e Shell, dalla spagnola Repsol e dall’italiana ENI. Le cinque multinazionali riprenderanno le attività in Venezuela sotto la supervisione politica ed economica di Washington. In cambio degli investimenti iniziali, Trump ha fornito garanzie di sicurezza alle società coinvolte, forte del cambio di regime “soft” realizzato a Caracas dopo il sequestro del presidente Maduro. Cade così senza clamori, nel silenzio internazionale, il pilastro delle nazionalizzazioni del petrolio e del gas su cui si era retta per vent’anni la Rivoluzione Bolivariana.
A poco più di un mese dal golpe silenzioso a Caracas, Donald Trump conclude un primo turno nella caccia, scevra di qualsiasi regola del diritto internazionale, alle risorse naturali. Il presidente USA, dopo le sessioni fiume con le società interessate, ha scelto le cinque multinazionali straniere che estrarranno profitto dalle riserve petrolifere più abbondanti del mondo, quelle venezuelane. BP, Shell, Repsol ed ENI si vedono dunque ammorbidite le sanzioni disposte dalla Casa Bianca nei mesi scorsi, unendosi all’americana Chevron che già godeva di un regime commerciale speciale. Viene confermato il periodo particolarmente positivo per l’ENI di Claudio Descalzi, che proprio in questi giorni ha siglato un accordo per lavorare il gas argentino. L’Italia chiude così il cerchio con gli alleati di Buenos Aires e Washington, traendo profitti dalla fedeltà politica a tutti i costi, anche se ad esserci di mezzo c’è il diritto internazionale.
Nel concedere le nuove licenze, il Dipartimento del Tesoro americano ha messo nero su bianco le regole del gioco: tutti i contratti che le multinazionali stipuleranno con la compagnia di Stato venezuelana PDVSA saranno regolati dalle leggi degli Stati Uniti. Allo stesso modo, le eventuali controversie legate ai contratti verranno risolte nel territorio statunitense. Il Dipartimento del Tesoro specifica poi che «tutti i pagamenti delle tasse su petrolio o gas al governo del Venezuela o a PDVSA devono essere versati nei fondi di deposito del governo estero o in qualsiasi altro conto secondo le istruzioni del Dipartimento del Tesoro americano. L’autorizzazione non consente, inoltre, transazioni con aziende in Russia, Iran o Cina, né con entità controllate da joint venture con persone provenienti da quei Paesi». La macchina amministrativa statunitense ha chiarito dunque le affermazioni vaghe di Trump, che aveva palesato la volontà di «dividere i profitti tra Venezuela, Stati Uniti e multinazionali».
Il governo di Caracas, retto ad interim dalla vicepresidente Delcy Rodríguez, ha deciso di accettare le interferenze USA nella propria sovranità nazionale. Trump vanta così garanzie di sicurezza nei confronti delle società petrolifere coinvolte nell’affair latinoamericano, a cui è stato chiesto un investimento complessivo di 100 miliardi di dollari per ammodernare il settore. Le promesse di Trump dovranno tuttavia fare i conti con lo storico sentimento antimperialista del popolo venezuelano. Alle proteste già in atto non si possono escludere azioni di sabotaggio e resistenza verso il nuovo sistema estrattivo messo in piedi da Washington. Ad avvalorare l’ipotesi del protagonismo popolare è il crollo dei consensi verso il Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV), uscito con le ossa rotta dalle recenti interferenze USA.