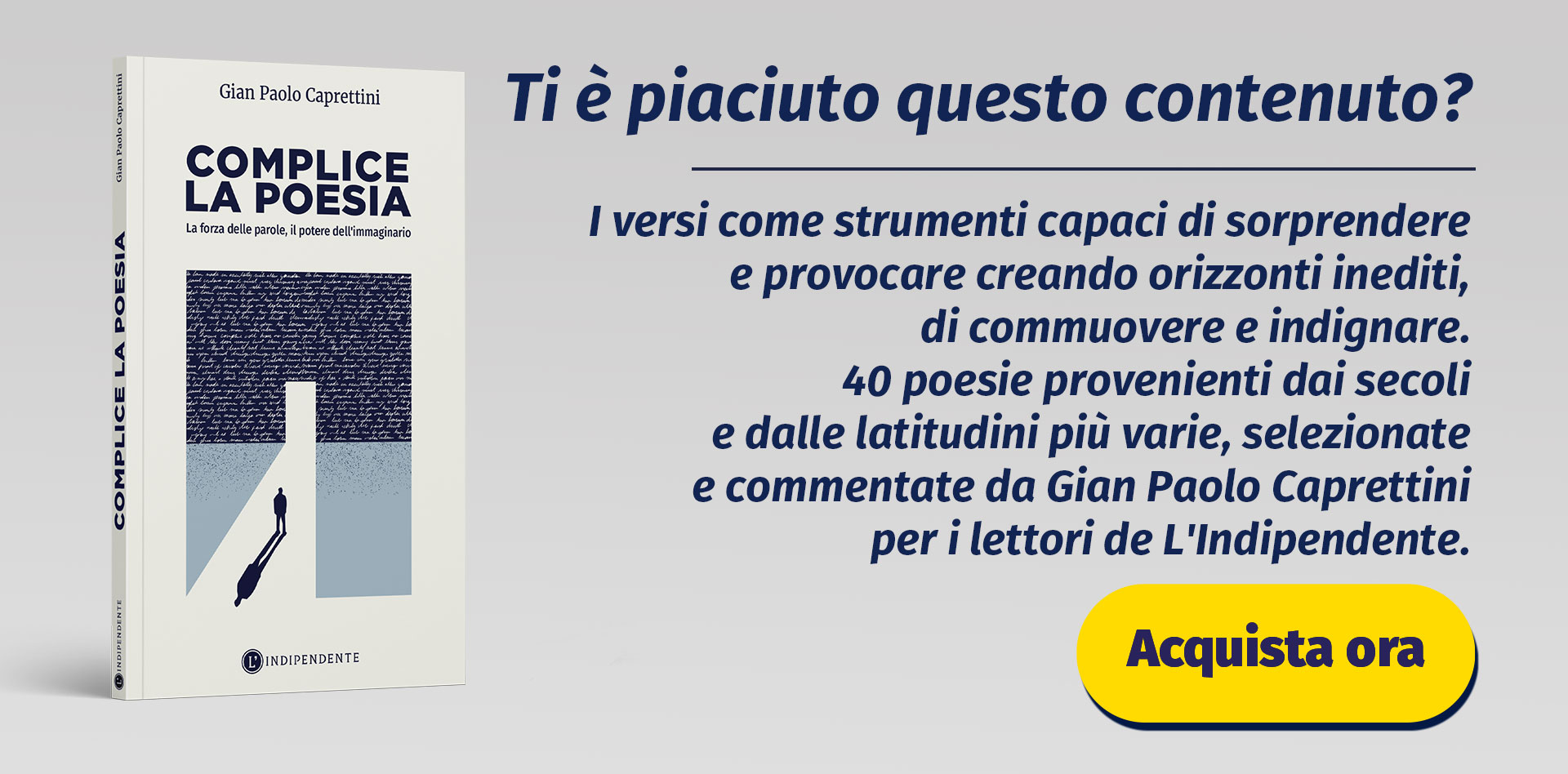Davanti al mare le nostre identità si sospendono, proviamo la sensazione di trovarci in una condizione assoluta, dove conferma e stupore si fondono. È inevitabile fissare l’orizzonte laggiù, verso le ultime acque, ma in questo modo avviene quasi che lo spazio, il contenitore del tempo, come lo chiamava Platone, si allarghi e perda i suoi confini. La percezione contraddittoria e congiunta di un tutto concluso e di un oltre ignoto genera sensazioni di infinito, un infinito tuttavia che appare parzialmente percorribile, che fa nascere ipotesi da verificare, terre remote da immaginare, isole come oasi di una ipotetica traversata. Il mare, come dato naturale, si estenua allora, diventa rarefatto, trasforma la sua materia in colore, scivola nella metafora, si fa disponibile a contenere pensieri e a distenderli senza alcun ordine in nuovi quadri mentali.
Il mare d’estate ci regala questo, l’utopia di una realtà senza tempo. Dove “senza tempo” significa che le condizioni determinanti la vita ordinaria non agiscono e che reale e possibile escono da ogni logica probabilistica. Un’altra condizione metaforica del mare è quella del percorso, del contenitore di varie rotte e destini.
La navigatio vitæ del mondo antico, la vita stessa nel suo complesso si raffigura come solco marino orientato dalle stelle e dal cielo, con le sue gioie e le sue disavventure, che caratterizzano tutto ciò che è umano e dipende da una tecnica. Ognuno salpa e prende il largo sulle onde di vari itinerari possibili, mettendo in gioco il senso dell’avventura. Da Omero a sant’Agostino la nave esprime la comunanza dei destini umani, il bisogno di una meta condivisa, la rappresentazione anche di un pilota che guida e che si può alternare con altri che lo sappiano fare. Sulla nave le mansioni vengono applicate nello sforzo comune di andare avanti, di non perdere la rotta, di affrontare le burrasche, di gestire tempi ed eventi a seconda di come si presentano le necessità. La nave, il mare richiedono competenze ma anche coraggio, costanza e creatività, un’idea di sicurezza da garantire a tutti perché il domani è comune.
L’Ulisse di Omero nulla avrebbe raggiunto e superato senza l’aiuto divino, perché il suo mito aveva bisogno di un logos, di una ragione e insieme di una sfida, quella sfida tutta umana che avrebbe poi condannato l’Ulisse dantesco a causa di un eccesso di volontà di conoscenza.
Il mare, però, esprime non soltanto il bisogno di oltre, di ignoto ma anche la difficile sopravvivenza, l’ottenimento di risorse.
La pesca e il pescatore aprono un nuovo fronte metaforico a questo proposito, un fronte oggettuale dove il pesce trasfigura in destino attraverso la fatica e i rischi di quel lavoro.
Hemingway: «Vorrei poter dar da mangiare al pesce, pensò. È mio fratello. Ma devo ucciderlo e mantenermi forte per farlo» (Il vecchio e il mare). Per chi ha anche scritto Addio alle armi e Verdi colline d’Africa, la morte provocata è un tema immenso, la morte che viene dal mare poi parla di una perdita, parla di naufragi e di prede sfuggite.
Seferis: «Dormo, ma il cuore veglia: /guarda in cielo le stelle, e la barra, / l’infiorata dell’acqua al timone».
Nel sogno non ci sono volti. Per Seferis, la poesia è il “giornale di bordo” dell’immaginario. Anche la poesia, infatti, è una pesca, di parole e di prede simboliche, ancorate insieme all’essere e al divenire, al permanere e al trasformarsi. Come nel ritmo parallelo, incessante delle onde, ognuna per definizione diversa dall’altra.
A Skagen, estremo nord dello Jutland, Danimarca, il mare del Nord e il Baltico sono divisi da una striscia di terra, una specie di Scilla e Cariddi nordica. La gente, in pellegrinaggio, raggiunge sulla lunga spiaggia quell’estremo quasi puntiforme e si bagna i piedi. Arrivare lì è una esperienza densa di gioia, religiosa e festosa. Lì si vedono le onde trasversali, frutto dello scontro dei due mari. E ti chiedi perché c’è qualche governante che pensa alla guerra, qui dove l’assoluto della natura canta la sua gloria e donne, uomini, bambini, cani, gabbiani, corvi e foche si abbracciano quasi senza dirsi una parola.