Il legame tra mafia e amministrazioni locali è una delle grandi piaghe che affligge il nostro Paese, le cui origini risalgono al periodo dell’Italia postunitaria. Il fenomeno si è sviluppato soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, quando lo Stato e le ingerenze di forze straniere si servirono del fenomeno mafioso anche per orientare e dirigere la politica della penisola. È nota, infatti, la profonda compenetrazione tra Stato e mafia, soprattutto a livello locale, che ha permesso il prosperare dei diversi clan, i quali hanno progressivamente assunto sempre maggiore potere sul territorio. ...
Questo è un articolo di approfondimento riservato ai nostri abbonati.
Scegli l'abbonamento che preferisci (al costo di un caffè la settimana) e prosegui con la lettura dell'articolo.
Se sei già abbonato effettua l'accesso qui sotto o utilizza il pulsante "accedi" in alto a destra.
L'Indipendente non ha alcuna pubblicità né riceve alcun contributo pubblico. E nemmeno alcun contatto con partiti politici. Esiste solo grazie ai suoi abbonati. Solo così possiamo garantire ai nostri lettori un'informazione veramente libera, imparziale ma soprattutto senza padroni.
Grazie se vorrai aiutarci in questo progetto ambizioso.




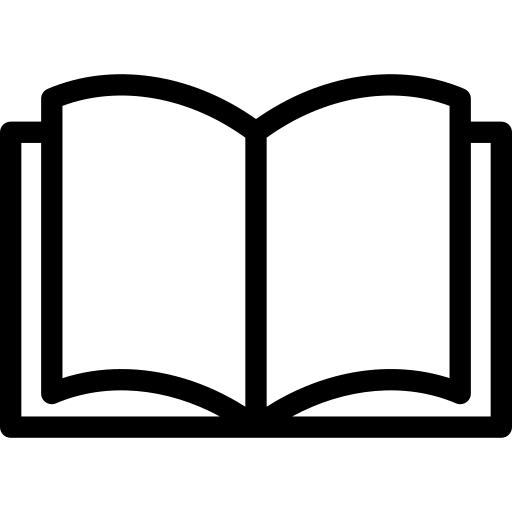

Ormai i “contratti” con la criminalità organizzata si fanno alla luce del sole. E sempre e solamente per sete di potere e denaro…
Se le commistioni politica-mafia datano da due secoli, non dovremmo sottovalutare la legalizzazione della mafia in Italia, da parte della CIA che, nello sbarco di Sicilia del 1943 delle truppe americane, fu inviato anche il grande mafioso americano, Lucky Luciano, che nonostante la sua condanna a oltre 30 anni di carcere in USA, fu liberato – appunto – dalla CIA affinché l’armata americana consegnasse a tutte le istituzioni politiche delle principali città, dal Sud al Nord dell’Italia, un biglietto con il nome indicato da Luciano, di chi doveva essere eletto a sindaco della città.
Luciano fu onorato con la medaglia al valore civile per aver “reso servizio nobile agli USA” e fu rimandato a Napoli dove visse fino alla sua morte, indisturbato nel il suo ingente traffico di droga, proveniente dagli Stati Uniti. A buon intenditore.