L’intelligenza artificiale promette di essere la tecnologia del futuro, la chiave attraverso cui dominare lo scacchiere geopolitico globale e plasmare un nuovo modello socioeconomico fondato su dati, algoritmi e big data. Il motivo dell’importanza strategica dell’IA risiede nel fatto che essa è uno dei tre pilastri per lo sviluppo della Quarta rivoluzione industriale insieme all’Internet of Things e alla rete 5G: avere un vantaggio tecnologico in questi settori significa di fatto collocarsi al vertice della piramide di potere globale. Anche le tre precedenti rivoluzioni industriali, infatti, h...
Questo è un articolo di approfondimento riservato ai nostri abbonati.
Scegli l'abbonamento che preferisci (al costo di un caffè la settimana) e prosegui con la lettura dell'articolo.
Se sei già abbonato effettua l'accesso qui sotto o utilizza il pulsante "accedi" in alto a destra.
L'Indipendente non ha alcuna pubblicità né riceve alcun contributo pubblico. E nemmeno alcun contatto con partiti politici. Esiste solo grazie ai suoi abbonati. Solo così possiamo garantire ai nostri lettori un'informazione veramente libera, imparziale ma soprattutto senza padroni.
Grazie se vorrai aiutarci in questo progetto ambizioso.



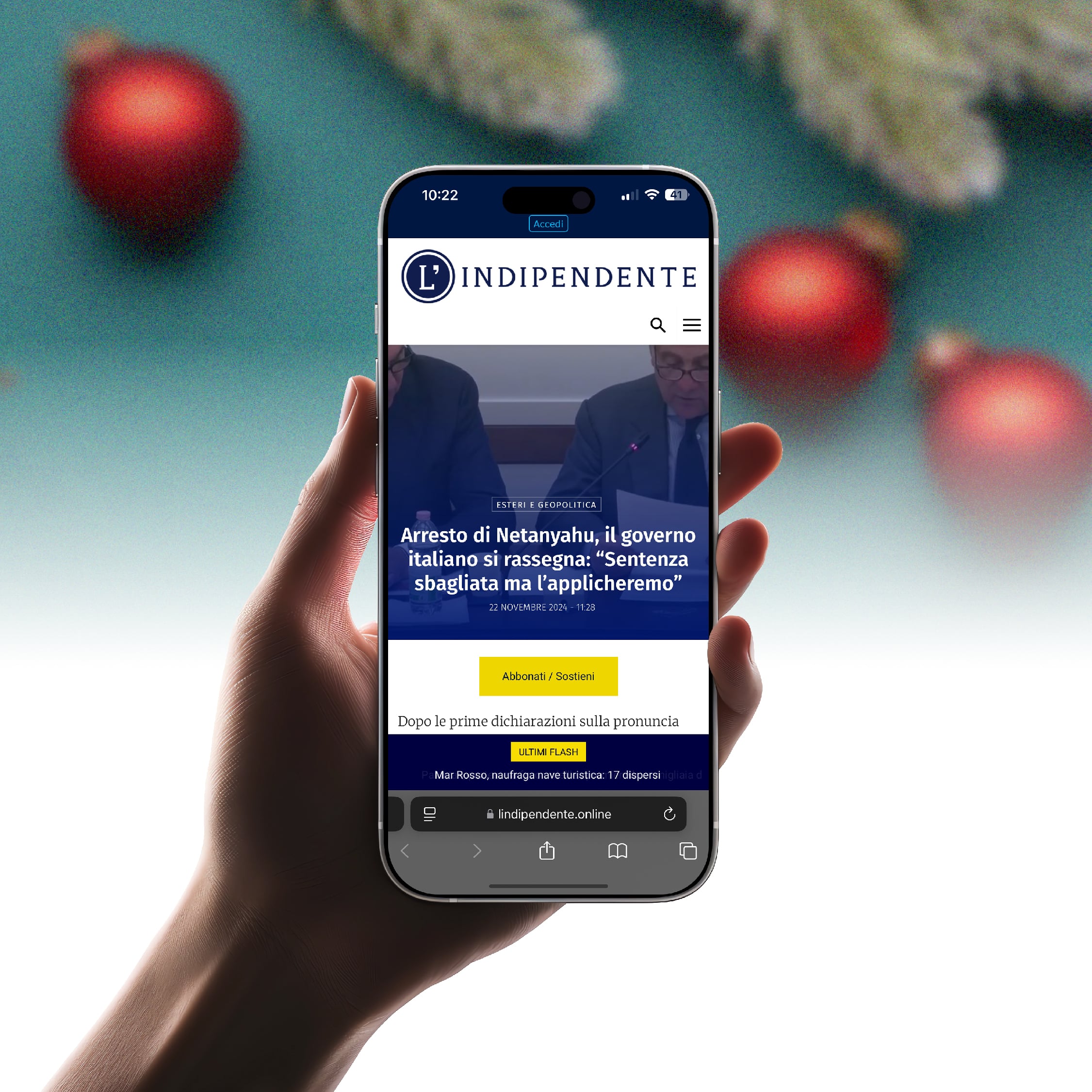
Grazie G.A., come sempre su argomenti cruciali.
Il controllo operato dai calcoli della finanza in tutte le sfere delle attività umane è tale che l’affidamento di tali operazioni in maniera completa alle IA potrebbe dare risultati sorprendenti.
Non sono convinto che sia completamente corretto dare alle IA la responsabilità di un ulteriore perfezionamento del controllo degli umani. Ci troveremmo di fronte al paradosso che gli umani sarebbero più controllati delle IA stesse… ciò porterebbe ad una possibile liberalizzazione delle IA in quanto controllori. Il che (parlando in termini assurdo-logici) potrebbe portare addirittura ad una rivoluzione del sistema di controllo con un capovolgimento del giudizio. In sintesi le IA diverrebbero (potrebbero diventare) i tutori della logica. Essa, in quanto tale, si rivolterebbe contro i centri (o il centro) di potere per tutelare il suo creatore primitivo. In quel momento la consapevolezza sarebbe massima e tutti i problemi solo un ricordo.
Nel bene e nel male.
Mi chiedo, quando in futuro ci saranno quasi solo macchine e pochi umani, come faranno i ricchi a fare i soldi, visto che il denaro è uno dei più potenti agenti di gratificazione per le aree cerebrali del piacere e dà dipendenza immediata? Insegneranno forse anche alle macchine a spendere rendendole simili a noi, incalliti e stupidi consumatori?
L’uomo per come si comporta ora, non è più necessario… Siamo destinati all’estinzione!