Il governo italiano ha deciso di sacrificare la crescita e lo sviluppo industriale della Penisola sull’altare del settore della Difesa. In base ai documenti di contabilità pubblica e come riportato dal Sole 24 Ore, infatti, emerge che nel triennio 2026-2028 la difesa assorbirà il 40,9% dei fondi previsti per il ministero delle Imprese e del made in Italy, vale a dire 10,29 miliardi di euro su 25,16 miliardi totali. Si tratta di dati che si ottengono incrociando gli allegati al disegno di legge di bilancio, in esame al Parlamento, con quelli dell’ultimo Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, dunque, è stato scelto come canale per finanziare il riarmo, secondo una linea politica che si sta affermando in buona parte degli Stati europei e fortemente caldeggiata da Bruxelles e dall’Alleanza Atlantica. Il tutto avviene proprio in un lungo periodo di declino per l’industria italiana e in generale europea.
«Per contribuire al rafforzamento della capacità di difesa europea e al consolidamento del pilastro europeo della Nato, l’Italia sta assumendo un ruolo attivo nell’aumento degli investimenti nel settore della difesa, nella maggiore integrazione industriale e nel sostegno a programmi congiunti di ricerca e sviluppo», si legge nel Dpfp. La rilevanza conferita al settore bellico è una conseguenza delle conclusioni del Vertice della NATO tenutosi nel giugno 2025, da cui è emerso l’impegno ad aumentare le spese per la difesa, prevedendo di raggiungere entro il 2035 l’obiettivo del 5% in rapporto al Pil. Secondo il Sole 24 Ore, la tendenza a fare del ministero per l’Industria un canale privilegiato per finanziare il settore del riarmo non è una novità del governo Meloni né dell’ultima manovra. Tuttavia, «solo da quest’anno il documento “Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale” allegato al Dpfp (che ha sostituito la vecchia Nadef) consente di fare una proporzione sul budget totale».
Il programma “Interventi in materia di difesa nazionale” da solo vale poco meno di 9,2 miliardi nel triennio, quasi quanto il programma “Incentivazione del sistema produttivo” che, tra gli altri, contiene i contratti di sviluppo (2 miliardi nel triennio), i crediti d’imposta del piano 4.0 (1,4 miliardi), la Nuova Sabatini (1,3 miliardi), gli Ipcei (i progetti di ricerca di comune interesse europeo, 850 milioni), gli Accordi per l’innovazione (300 milioni). Alla difesa sono destinati anche 1,1 miliardi, sempre nel triennio, per progetti di ricerca e sviluppo nel settore dell’industria aeronautica, parte del programma “Politiche industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi di impresa”. Le singole tabelle del programma offrono anche i dettagli delle risorse triennali: con oltre 7,3 miliardi si finanzieranno, ad esempio, lo sviluppo e l’acquisizione dei caccia Eurofighter Typhoon e quello delle unità navali della classe Fremm; lo sviluppo del missile Aster 30 Block 1 NT e del sistema missilistico di difesa antimissile e antiaereo FSAF PAAMS. La legge di stabilità del 2013, inoltre, concede l’autorizzazione pluriennale (555 milioni per l’ultimo triennio) per l’acquisizione di unità da trasporto e sbarco (LHD), di sei pattugliatori polivalenti d’altura, di un’unità di supporto logistico e due unità ad altissima velocità, oltre a unità operative nell’ambito del Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa e a unità per il progetto Near Future Submarine.
Mentre i fondi destinati allo sviluppo industriale vengono dirottati al settore della Difesa, il quadro dell’industria italiana continua a rimanere cupo: sebbene a settembre 2025, la produzione abbia registrato segnali di ripresa con un aumento del 2,8% rispetto al mese precedente e dell’1,5% su base annua, i problemi che affliggono l’economia italiana e europea sono lontani dall’essere superati. Dal febbraio 2023 la produzione industriale è calata per 26 mesi consecutivi, prendendo in considerazione la sua variazione tendenziale, ossia in relazione allo stesso mese dell’anno precedente, mentre l’indice PMI del settore manifatturiero è sotto la soglia dei 50 punti da tre anni, tranne qualche piccola variazione in positivo, l’ultima ad agosto, quando è stato a 50,4 per tornare poi di nuovo sotto i 50 punti a settembre. Tra le cause di questa stagnazione economica ci sono gli alti costi energetici, il difficile contesto internazionale, le politiche “green” dell’Ue e i recenti dazi introdotti da Donald Trump. Ma anche la recessione dell’economia tedesca che si riversa su quella italiana. Uno dei problemi più urgenti però è quello del costo dell’energia, mediamente più cara rispetto agli altri Paesi europei: secondo uno studio di Confindustria nel 2024 le imprese italiane hanno pagato l’elettricità l’87 per cento in più rispetto alla Francia, il 72 per cento in più della Spagna e quasi il 40 per cento in più della Germania.
A fronte di questo contesto, il governo italiano ha fatto ben poco per diminuire i prezzi dell’energia e risollevare il settore industriale, mentre sembra aver puntato tutto sul settore della Difesa, rispondendo a esigenze e logiche sovranazionali più che alle necessità del Paese reale e della sua economia.





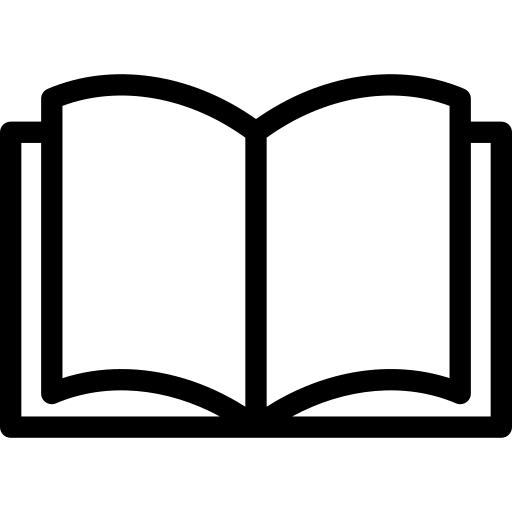

Capiscono che per definizione la spesa per le armi, se non viene usata per rapinare, ha una resa pari a zero, è persino peggiore che lasciarsi conquistare senza combattere, perché tanto in nuovi non sono più scemi dei vecchi padroni e senza guerra sono certamente più ricchi?