A chi difende i diritti degli animali viene detto: come puoi preoccuparti degli animali quando nel resto del mondo vi sono guerre, carestie e problemi ben più importanti di cui occuparsi? Come è possibile mettere sullo stesso piano la vita degli animali con quella degli uomini? Ed è giusto, parlando degli animali domestici, dedicare tempo, attenzioni ed energie nel coltivare un rapporto con un essere vivente che non appartiene alla nostra razza? Queste domande in realtà nascondono ben altro dietro. Quali valori cioè ci governano? Quali sono gli impulsi che ci guidano? Cosa determina e cosa orienta il nostro agire, il nostro comportamento, la nostra capacità di amare?
Tra gli argomenti più in voga usati contro gli animalisti vi è l’accusa di aver umanizzato gli animali domestici e di trattare come figli. Sia ben chiaro, sui social alle volte assistiamo a scene di animali domestici con indosso vestitini e accessori che giustamente sollevano obiezioni critiche, ma il punto in questione è un altro. L’attaccamento affettivo per un animale domestico diviene spesso oggetto di critiche da parte di coloro che accusano chi ha un cane o un gatto di volergli bene in modo eccessivo. E di preferire l’animale domestico alla procreazione. Si tratta di una falsa dicotomia, perché non esiste nessuna correlazione tra l’affetto per gli animali e la mancanza dei figli.
Il basso tasso di natalità in Italia ha ragioni storiche, culturali ed economiche che non hanno nulla a che vedere con il possesso o meno di un animale da compagnia. Ma è interessante notare come nella dimensione affettiva ed emotiva vengano applicate delle gerarchie che soggiacciono ad argomenti puramente razionali.
Lo studio condotto dal biologo giapponese Miho Nagasawa ha rivelato le basi ormonali del legame che ci unisce ai nostri animali domestici. Questo legame passa dallo sguardo: il contatto visivo genera nel cervello di entrambi un’impennata dell’ossitocina, l’ormone alla base dei legami affettivi. Nel legame che si sviluppa tra un cucciolo (di cane, di gatto o di qualsivoglia specie) e un essere umano si attivano quegli ormoni, come l’ossitocina e le endorfine, che sono alla base del legame madre-figlio. O più precisamente madre-neonato.
La natura indifesa di un cucciolo, di un essere inerme che dipende dalle nostre cure, attiva in noi un istinto innato che ci spinge a prendercene cura. Se dal punto di vista razionale siamo spinti a stabilire delle gerarchie nella sfera degli affetti e dei sentimenti, il nostro sistema neuro-endocrino non va tanto per il sottile. E non fa differenza. Chiunque abbia vissuto con un animale lo intuisce, ma la Scienza ci ha fornito per la prima volta una spiegazione biologica di quella verità che potremmo riassumere poeticamente con «l’amore trascende ogni barriera e ogni distinzione». Non solo di razza, cultura, lingua ma è in grado di superare anche i confini che dividono le specie. Non soltanto da parte nostra, ma anche da parte degli animali.
La biologa Simona Kossak visse per trent’anni nella foresta di Bialowieza per osservare e studiare il comportamento della fauna selvatica. La sua capanna era talmente in sintonia con la foresta che una cerva la scelse come luogo per partorire i suoi cuccioli, che furono allattati dalla stessa biologa. Tra la Kossak e questi cuccioli si sviluppò un legame a dir poco unico, come racconta lei stessa:
«Un giorno i cervi, che avevo allevato con il biberon e che per molti anni mi seguirono nei boschi, manifestarono segni di paura e non vollero entrare nella foresta a pascolare. Come mi ci diressi io si fermarono, le orecchie rizzate e il pelo diritto sul fondoschiena. In apparenza doveva esserci qualcosa di assai minaccioso nella foresta. Attraversai metà dello spazio aperto e mi fermai, perché i cervi stavano producendo un terribile coro di latrati alle mie spalle. Mi voltai e ce n’erano cinque, rigidi sulle zampe, che mi guardavano e chiamavano: Non andare, non andare, c’è la morte laggiù! Devo ammetterlo, restai di stucco ma alla fine andai. E trovai che c’erano tracce di una lince, una lince aveva attraversato la foresta. Trovai le sue feci più avanti. Cos’era successo? Un carnivoro era entrato nella fattoria, i cervi lo avevano notato ed erano spaventati. Poi hanno visto la loro “madre” andare verso la morte, completamente inconsapevole, e dovevano avvisarla – per me, lo dico onestamente, quel giorno fu una conquista. Avevo attraversato il confine che ci divide dagli animali, un muro che non sembrava possibile abbattere. Se mi avevano avvisata voleva dire una sola cosa: sei un membro del branco, non vogliamo che tu sia ferita».
Questa testimonianza è fondamentale non soltanto per ridisegnare i confini della nostra etica nei confronti degli animali, ma ci spinge anche domandarci: quali sono le basi etiche su cui abbiamo costruito la nostra società?
Nella società odierna l’assunto «la vita animale non vale una vita umana» è un principio universalmente condiviso dalla maggior parte della popolazione. Come potremmo infatti giustificare la macellazione, le sperimentazioni sugli animali, gli allevamenti intensivi che trasformano la complessità di un essere vivente in prodotti alimentari, se la vita animale non venisse percepita come «inferiore» a quella dell’uomo? Di epoca in epoca alcuni individui, da Pitagora a Seneca a Kant, passando per Tolstoj e Rousseau si sono domandati perché venga inflitta, in modo deliberato o inconsapevole, una grande sofferenza a creature dotate di sensibilità e di sentimenti anche complessi. Ma tali individui hanno sempre rappresentato una minoranza.
Se in passato le carestie, la fame, la scarsa diffusione della tecnologia avevano reso l’uomo dipendente dallo sfruttamento della vita animale per garantire la propria sopravvivenza, oggi tale necessità non sussiste. Almeno non nel mondo occidentale. Eppure gli animali continuano a essere considerati una fonte appropriata e lecita di cibo. Alla base di quest’atteggiamento vi è la convinzione che vi siano vite meno meritevoli di altre di essere vissute. Vi è cioè una scala gerarchica che assegna un determinato valore alla vita in base a dei presupposti non biologici ma culturali.

Ma facciamo un passo indietro. Per capire il pregiudizio ideologico che si nasconde dietro ciò, è necessario capire da dove nasce e perché. Questa questione, infatti, non riguarda soltanto il rapporto uomo-animale, ma investe aspetti fondamentali della nostra società e della nostra cultura. Aspetti che a loro volta sono stati la causa delle peggiori atrocità della storia.
Porsi la domanda quale vita sia più degna di essere vissuta, ha avuto sempre conseguenze nefaste per il genere umano. Nella Germania nazista alcune categorie di persone, ebrei, rom, polacchi, omosessuali e via dicendo venivano considerate immeritevoli di vivere. Oggi le vittime del 7 ottobre vengono strumentalizzate per giustificare il genocidio in corso a Gaza; alla base di ciò vi è il presupposto inconscio che la vita di un palestinese valga meno di quello di un israeliano. O viceversa. Nel corso della storia quegli individui affetti da handicap e disabilità cognitive sono stati trattati come individui di serie b, come se il diritto alla vita fosse legato allo sviluppo e all’estensione delle facoltà razionali.
La nostra società, infatti, è figlia del razionalismo di matrice illuminista, del cartesiano «penso, dunque sono». Il penso dunque sono è il valore fondante della nostra cultura. Il rapporto uomo-animale, e la dialettica che plasma e orienta questo rapporto deve continuamente fare i conti con argomenti e obiezioni circoscritte all’ambito della sola razionalità.
Eppure nel mondo antico, questo rapporto non era così sistematico e assoluto. Se il filosofo greco Pitagora fu uno dei primi a esprimersi contro la violenza sugli animali per ragioni razionali, Arthur Schopenhauer, ritenendo gli animali capaci di emozioni profonde, si domandava: «Chi è crudele nei confronti degli animali come può essere una buona persona?»
Fu tuttavia il filosofo Jeremy Bentham a porre nella percezione della gioia e della sofferenza la qualità che accumuna i membri di ogni specie: «Il problema non è “Possono ragionare?”, né “Possono parlare?”, ma “Possono soffrire?”». Ecco quindi uno slittamento dal «penso, dunque sono» al «sento, dunque sono».
Chiunque abbia vissuto con un animale, sa quanto questi esseri siano capaci di provare emozioni profonde come gioia, affetto, paura, attaccamento. Se fino ad ora i computer e le IA sono riusciti ad emulare in una forma approssimativa i rudimenti del pensiero logico, ed è probabile che in futuro la tecnologia possa arrivare a mimare il pensiero logico-razionale, non è mai esistita né è mai stata ipotizzata l’esistenza di una macchina in grado di riprodurre e provare la vasta gamma di emozioni e sentimenti umani. Emozioni e sentimenti che condividiamo con gli animali. Nel film Equilibrium diretto da Kurt Wimmer ci viene mostrata una società distopica dove le persone non hanno perduto la facoltà di ragionare ma di sentire. Gli esseri umani sono obbligati ad assumere una droga che li priva della capacità di provare emozioni, al fine di eliminare qualsiasi forma di conflitto. Le persone conducono una vita meccanica, priva di emozioni, di sentimenti, di sensazioni e pur avendo mantenuta intatta la capacità di ragionare sono simili a dei robot; camminano, mangiano, respirano, pensano ma non hanno più nulla di ciò che rende un uomo vivo. E allora sorge spontanea la domanda: quali sono quelle qualità che ci rendono umani? La capacità di pensare? Di elaborare pensieri complessi e calcoli astratti? O la capacità di sentire? E se gli animali provano emozioni e hanno sentimenti proprio come noi, perché non hanno diritto alla vita?
Ed ecco anche perché sostengo, e lo sostengo con fermezza, che il modo in cui trattiamo gli animali determina e influenza i rapporti con i nostri simili. Seneca era convinto che ci fosse un legame tra l’uccidere gli animali e il massacrare i propri simili in guerra. Circa 1800 anni dopo lo scrittore russo Lev Tolstoj fu dello stesso avviso: «Fino a quando ci saranno i macelli, ci saranno anche i campi di battaglia. La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali.»
Le interazioni con gli animali ci spingono a ridimensionare l’importanza che assegniamo alla razionalità, in favore di un modo d’intendere la vita più improntato al sentimento. Con gli animali non parli, non costruisci discorsi logici, non elabori discorsi ma senti. Accrescono in noi quei sentimenti di tenerezza e sensibilità di cui non possiamo e non dovremmo fare a meno.





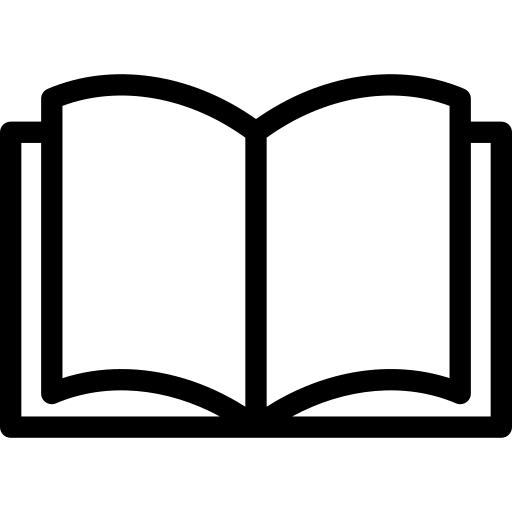

Grazie per le bellissime parole che comunque lasceranno la maggior parte delle persone indifferenti o meglio impaurite dal baratro che si aprirebbe se avvenisse il collegamento cognitivo -emotivo.
Eppure tutti [quasi] possono sperimentare l’evidenza della fallacia dell’assioma ‘umano superiore ‘. Quando ti muore un animale con il quale hai convissuto si soffre molto di più che per la morte di un umano sconosciuto, fosse anche un bambino! È sbagliato dire che si soffre di più, si soffre e basta! Eppure ci sediamo ogni giorno assieme a persone che amano il loro cane mentre mangiano l’agnello. Quindi la vera domanda è: che fare? Temo che la soluzione non potrà mai passare attraverso il dialogo!