Mentre 80 piazze in tutta Italia si sono riempite pacificamente a sostegno dello sciopero generale indetto da Usb contro il genocidio in atto a Gaza, il governo ha scelto di concentrare l’attenzione sugli scontri avvenuti alla stazione Centrale di Milano. L’episodio, che ha coinvolto poche centinaia di persone, è diventato il pretesto non solo per ridimensionare il successo della mobilitazione, ma anche per rilanciare una proposta che rischia di colpire al cuore il diritto di sciopero, ipotizzando di chiedere una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni per fare in modo, in caso di danni, che siano loro a pagare. Una criminalizzazione che si nutre anche dell’atteggiamento passivo di non pochi cittadini, che da una parte denunciano il genocidio in corso, ma dall’altro attaccano sui social le manifestazioni che si tramutano in blocchi delle strade, delle ferrovie, della produzione. Come se lo sciopero dovesse essere solo una testimonianza di dissenso che non dà fastidio a nessuno anziché, come è da sempre e per definizione, un’azione collettiva che mira a rendere insostenibile lo status quo per costringere il governo a scendere a patti con le istanze popolari. Eppure, e come vedremo la storia d’Italia lo dimostra, proprio lo sciopero è da sempre il motore di gran parte delle conquiste e dei diritti sociali dei quali ancora possiamo godere.
Cos’è lo sciopero?
Lo sciopero è uno strumento collettivo di lotta e rivendicazione dei lavoratori, che consiste nell’astenersi temporaneamente dal lavoro per esercitare pressione nei confronti del datore di lavoro, del settore produttivo o delle istituzioni. Può assumere diverse forme: dallo sciopero generale, che coinvolge trasversalmente più categorie e settori, allo sciopero di categoria o aziendale, limitato a un comparto specifico; dallo sciopero politico, rivolto a decisioni governative, a quello a singhiozzo, con interruzioni intermittenti della produzione. Esistono poi varianti come lo sciopero bianco, in cui i lavoratori applicano rigidamente i regolamenti rallentando le attività, e lo sciopero a oltranza, che prosegue fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tutte le sue forme, rimane uno dei principali strumenti di partecipazione e conflitto sociale riconosciuti nelle democrazie moderne.
La storia del Primo maggio
Il 1° maggio 1886 a Chicago non è un giorno come gli altri. Migliaia di lavoratori, 200mila secondo le cronache dell’epoca, scendono in strada chiedendo una cosa che oggi ci sembra banale: otto ore di lavoro, otto di riposo, otto di tempo libero. La parola d’ordine nasce dal sindacato dei lavoratori edili – stanchi di lavorare dalle 12 alle 14 ore al giorno – e si diffonde come un lampo nelle fabbriche degli Stati Uniti. Il 3 maggio, davanti alla McCormick, una fabbrica produttrice di mietitrebbie, la polizia apre il fuoco sugli operai in sciopero: due morti, decine di feriti. Il giorno dopo, durante un comizio in Haymarket Square, esplode una bomba. La polizia reagisce sparando sulla folla. È il caos. Alla fine rimangono a terra una decina di morti. Quei giorni sanguinosi, passati alla storia come i moti di Haymarket, hanno un effetto imprevisto: trasformano la repressione in simbolo universale. Da allora il 1° maggio diventa la Festa dei Lavoratori per ricordare che ogni diritto nasce da una rottura, da un “no” collettivo. Da uno sciopero.
 Per anni le otto ore rimasero una rivendicazione. Solo con la Prima guerra mondiale e il rischio di rivoluzioni sociali, i governi capirono che bisognava dare una risposta. Nel 1919, con il Trattato di Versailles, fu creata l’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Alla sua prima Conferenza, a Washington, i delegati approvarono la Convenzione n. 1, che fissava per la prima volta un limite globale: otto ore al giorno, 48 alla settimana per l’industria. Era un compromesso difficile, ma segnò una svolta: dalle barricate di Chicago si arrivava a una norma internazionale vincolante.
Per anni le otto ore rimasero una rivendicazione. Solo con la Prima guerra mondiale e il rischio di rivoluzioni sociali, i governi capirono che bisognava dare una risposta. Nel 1919, con il Trattato di Versailles, fu creata l’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Alla sua prima Conferenza, a Washington, i delegati approvarono la Convenzione n. 1, che fissava per la prima volta un limite globale: otto ore al giorno, 48 alla settimana per l’industria. Era un compromesso difficile, ma segnò una svolta: dalle barricate di Chicago si arrivava a una norma internazionale vincolante.
Dalla fabbrica alla Costituzione
In Italia, lo sciopero ha un percorso tortuoso. Il primo sciopero generale del nostro Paese nell’età moderna risale al 1904, quando i sindacalisti e il partito Socialista guidato allora da Filippo Turati il 16 settembre guidarono una mobilitazione generale, nelle città e nelle campagne, portando i braccianti agricoli a smettere di lavorare. Le richieste comprendevano sia il miglioramento delle condizioni lavorative sia la fine degli “eccidi proletari”, riferendosi a diversi casi in cui, in proteste precedenti, le forze dell’ordine avevano sparato e ucciso contadini e minatori.
Durante il fascismo lo sciopero viene dichiarato illegale: le Camere del lavoro chiuse, i sindacati soppressi, gli scioperanti perseguiti. Ma già nel marzo 1943 gli operai della Fiat incrociano le braccia contro la fame e la guerra, mettendo in moto un processo che è passato alla storia come il “risveglio operaio”. Tutto ha inizio a Torino, il 5 marzo, con il fermo totale delle macchine alla Fiat Mirafiori, dando inizio a una serie di scioperi antifascisti che coinvolsero 100mila operai in tutto il nord Italia. È il primo grande sciopero di massa in un Paese sotto dittatura dove, alle iniziali richieste economiche si aggiunsero quelle di natura politica, chiedendo la fine della guerra. Dopo la Liberazione, la Costituzione del 1948 sancisce all’articolo 40: «Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano». È la prima volta che lo Stato italiano riconosce apertamente il conflitto come legittimo. È un passaggio epocale: lo sciopero smette di essere solo un atto di ribellione e diventa un diritto costituzionale.
“L’Autunno caldo” e lo Statuto dei lavoratori

Negli anni ’60 l’Italia cambia volto: il miracolo economico crea lavoro in fabbriche enormi e catene di montaggio, con masse di operai che migrano dal sud al nord. Ma le condizioni sono dure: turni lunghi, salari bassi, sicurezza scarsa. È in questo clima che esplode “l’Autunno caldo” del 1969: scioperi a catena, milioni di ore di lavoro sospese, piazze piene. A guidare le lotte non sono solo i sindacati confederali, ma anche consigli di fabbrica, delegati di reparto, assemblee spontanee. Lo sciopero diventa pratica quotidiana, strumento di democrazia diretta. I risultati arrivano: aumenti salariali, migliori condizioni contrattuali, ferie e malattia pagate. E soprattutto, nel 1970, lo Statuto dei Lavoratori. La legge n. 300 del 20 maggio 1970 riconosce libertà sindacale, la tutela contro i licenziamenti arbitrari, diritto di assemblea in fabbrica, divieto di controllo a distanza. È una rivoluzione civile. Senza gli scioperi di quegli anni, questa legge non sarebbe mai esistita.
Dagli operai ai rider: lo sciopero che cambia volto

Ogni conquista – dalle ferie pagate al salario minimo, dalla sicurezza sul lavoro al congedo di maternità – ha dietro di sé una storia di scioperi. Le otto ore non furono un dono, ma il frutto di sacrifici, carcere, sangue. Oggi, in molti Paesi, il diritto allo sciopero è eroso da leggi restrittive, preavvisi eccessivi, sanzioni. Nei servizi pubblici essenziali viene ridotto a simulacro. Si invoca l’interesse collettivo per negare la voce di chi rivendica soprusi e ingiustizie, dimenticando che senza quella voce non c’è equilibrio sociale, ma solo imposizione. La storia insegna una cosa chiara: i diritti non cadono dall’alto. Sono il frutto di conflitti, di scioperi, di mobilitazioni.
Ogni epoca ha il suo sciopero. Negli anni ’80 e ’90 lo strumento viene usato per difendere il posto di lavoro durante le grandi ristrutturazioni industriali. Ma la lotta subisce un cortocircuito. È il 14 ottobre del 1980 quando a Torino va in scena la Marcia dei Quarantamila, manifestazione organizzata dai dirigenti della Fiat contro i sindacati e i picchetti che da oltre un mese bloccavano le fabbriche, dopo che l’azienda – in crisi – aveva optato per licenziamenti e cassa integrazione per oltre 20mila operai. La Fiat ottiene la riduzione del conflitto, i sindacati escono indeboliti. Lo sciopero sembra perdere forza, ma non scompare.
Per arrivare a un’altra grande mobilitazione bisogna aspettare il 2002, quando milioni di persone scendono in piazza contro la modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: è una delle più grandi mobilitazioni del dopoguerra. È il 23 marzo quando la CGIL porta in piazza 3 milioni di persone che invadono pacificamente le strade di Roma per confluire al Circo Massimo, inaugurando una mobilitazione che salverà l’articolo 18. Almeno fino al 2012, quando venne profondamente modificato dalla riforma Fornero e fino all’abrogazione del 2014 con il Jobs Act voluto dal governo Renzi. Negli ultimi anni, la scena cambia ancora: a incrociare le braccia sono i rider delle piattaforme digitali, i lavoratori della logistica, gli addetti ai servizi essenziali. Con scioperi piccoli ma mirati ottengono contratti, riconoscimento di tutele, visibilità sociale che altrimenti non avrebbero.
Il senso dello sciopero per Gaza
I fatti del passato dimostrano una cosa chiara: i diritti non cadono dall’alto. Sono il frutto di conflitti, di scioperi, di mobilitazioni. Senza la possibilità di sospendere il lavoro, il singolo è inerme di fronte alle grandi aziende e alle multinazionali, capaci di imporre la propria agenda ai governi nazionali, figurarsi ai propri lavoratori. Quali armi avrebbero i lavoratori di Amazon in Italia se non potessero scioperare? Nessuna, perché lo sciopero è la leva che trasforma la disperazione individuale in forza collettiva. Cerchiamo di ricordarcelo quando, dopo uno sciopero, si punta il dito solo sui disagi vissuti dal resto dei cittadini. O quando siamo noi stessi a lamentarci perché una manifestazione ci fa perdere un treno o ci fa rimanere imbottigliati nel traffico: lo sciopero, per sua natura, nasce proprio per dare fastidio: è un atto di disturbo che interrompe la normalità del lavoro e dei servizi, perché solo così riesce a rendere visibile la forza e le rivendicazioni di chi protesta. È proprio in quel disagio che risiede il senso dello sciopero, nel costringere la società a fermarsi un momento e a riconoscere le condizioni di chi manifesta. Uno sciopero “indolore” sarebbe inoffensivo, e quindi inutile.
E qui arriviamo alla madre delle critiche che in molti hanno fatto sullo sciopero per Gaza, sostenendo che non avrebbe cambiato di un millimetro le politiche di Israele e il genocidio in corso nella Striscia. Questo è un ragionamento che dimentica un punto essenziale: nessuna protesta in Italia può incidere direttamente sulle decisioni di Tel Aviv, ma lo sciopero è uno dei pochi strumenti che i cittadini hanno per forzare i propri governi a prendere posizione, a riconoscere ciò che sta accadendo e ad agire di conseguenza. Non è un caso se, all’indomani delle manifestazioni, Giorgia Meloni abbia improvvisato un’apertura – pur di circostanza – al riconoscimento della Palestina. E non è un caso nemmeno che il ministro della Difesa Crosetto abbia inviato una nave militare per proteggere gli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che sta cercando di raggiungere Gaza: proprio una delle richieste che era al centro dello sciopero. È questo il punto: la pressione dal basso non abbatte i muri da sola, ma costringe chi sta in alto a muoversi, anche di pochi passi. E senza quei pochi passi, la storia insegna, non si arriva mai a un cambiamento vero.

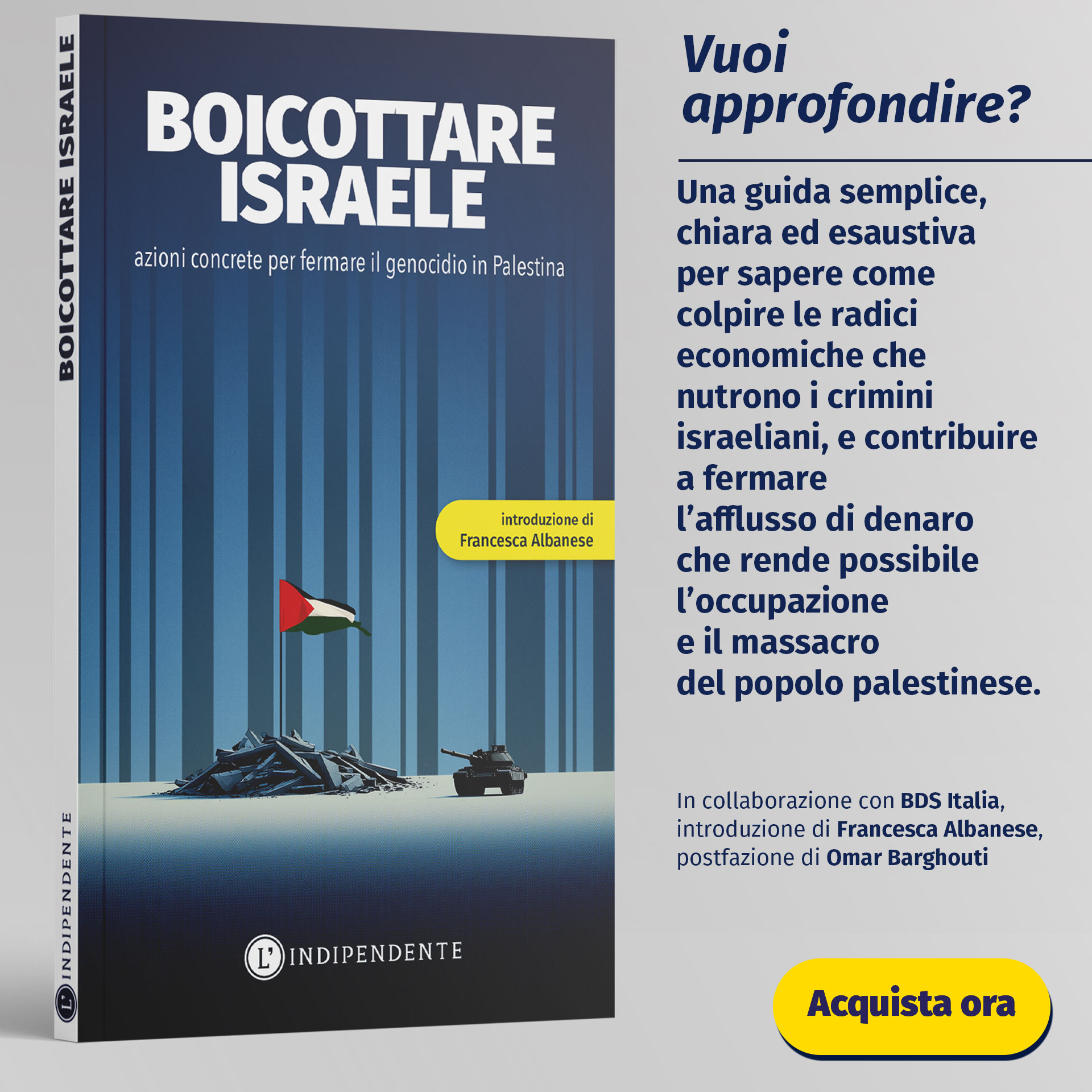





a minare l’utilità dello sciopero, in Italia, sono i lavoratori stessi, perché la giornata “scioperata” non viene pagata e normalmente chi sciopera fa lavori con stipendi che a stenti ti fanno sopravvivere, certo non vivere comodamente, quindi l’importo di una giornata, se non pagato, a molti da noia/problemi; poi c’è il menefreghismo dettato da apatia morale (si potrà dire?), ignoranza, sfiducia… e l’alibi del “tanto non cambierà nulla”, solo per non dover affrontare le conseguenze relazionali che poi porterà, in azienda, lo sciopero…
e oggi ci si mettono anche le minacce dei governanti.
Lo sciopero in Italia è una farsa. Nella tanto (di questi tempi) vituperata Germania è ancora un diritto sacrosanto e garantito di tutti i lavoratori senza abnormi decurtazioni dallo stipendio e senza orari tutelati come accade nel “Belpaese”.
bello l’articolo ma invito la redazione a una rilettura che a partire dall’immagine degli idranti ci sono errori di stesura nei paragrafi successivi