In Italia persiste il fenomeno dell’analfabetismo funzionale, che non riesce a essere scalfito nemmeno dal progresso tecnologico ed educativo della società. È quanto emerge dal Rapporto 2025 sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile pubblicato dall’ISTAT, in cui è stato dato ampio spazio al programma PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) dell’OCSE, che fornisce preziose informazioni relative alle competenze cognitive della popolazione adulta dei Paesi membri. «Il nostro Paese si colloca agli ultimi posti delle graduatorie internazionali, con rilevanti disparità territoriali che vedono le regioni del Nord Italia in netto vantaggio rispetto al Mezzogiorno», scrive l’ISTAT in riferimento all’esito dell’ultima rilevazione avvenuta nel 2023. Circa un italiano su tre presenta infatti significative difficoltà nella lettura e scrittura, così come nel calcolo e nella capacità di risoluzione dei problemi. Un trend che non registra segnali di ripresa rispetto alle rilevazioni effettuate nello scorso decennio, nonostante le grandi mutazioni dello spaccato sociale e tecnologico.
Nello specifico, il PIAAC valuta le competenze degli adulti tra i 16 e i 65 anni in tre ambiti fondamentali: la literacy (capacità di comprendere e utilizzare testi scritti), la numeracy (abilità di usare concetti matematici) e il problem solving in ambienti digitali. Il rapporto mostra che, in Italia, i punteggi medi in tutte e tre le aree sono ben al di sotto della media OCSE. Si stima infatti che quasi il 35% della popolazione possieda bassi livelli di competenza alfabetica e oltre il 36% presenti livelli insufficienti di competenza numerica. Un divario che riflette non solo carenze formative strutturali, ma anche un ritardo nell’adeguamento alle richieste di un’economia sempre più basata sulla conoscenza e sulle competenze digitali. La literacy, o competenza nella lettura, è uno degli ambiti più critici, registrando punteggi medi preoccupanti che segnalano una carenza generalizzata su questo versante. Un dato particolarmente allarmante è la stabilità (se non, almeno in determinate regioni, il lieve peggioramento) delle competenze di base nell’arco di un decennio: il confronto con il primo ciclo PIAAC del 2012 mostra infatti che le competenze medie della popolazione italiana sono rimaste sostanzialmente invariate. Anzi, mentre nelle regioni del Nord-ovest emerge un miglioramento delle competenze medie per literacy e numeracy, in alcune regioni del Mezzogiorno si registra addirittura un decremento nella literacy.
Le cause di questo fenomeno sono molteplici. L’invecchiamento della popolazione e l’aumento dei flussi migratori – con una quota significativa di adulti con bassa scolarizzazione – hanno certamente influito. Tuttavia, anche controllando questi fattori demografici, emerge che il sistema educativo e formativo italiano fatica a colmare il gap culturale di partenza e a promuovere l’apprendimento permanente. Le disparità territoriali sono un altro tassello fondamentale del quadro. Le regioni del Nord-ovest mostrano segni di miglioramento, mentre il Sud conferma un grave ritardo. Una vera e propria frattura geografica che costituisce il riflesso di divari socioeconomici più ampi e di un accesso disuguale a servizi educativi di qualità, con ripercussioni dirette su numerosi ambiti. L’analfabetismo funzionale non è infatti un fenomeno che attiene solo alla sfera culturale, ma che ha ricadute tangibili sull’economia e sulla coesione sociale.
Il Rapporto ISTAT sottolinea come il mancato miglioramento delle competenze degli adulti rappresenti un serio ostacolo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare il Goal 4 (“Istruzione di qualità”). Le conseguenze di questa carenza di competenze sono evidenti nel mercato del lavoro. Le persone con competenze basse sono meno competitive e hanno maggiori difficoltà a trovare impieghi stabili e ben retribuiti. Di conseguenza, il Paese perde parte del suo potenziale umano, riducendo la produttività e rendono più difficile l’adozione di innovazioni tecnologiche. Inoltre, minano la capacità dei cittadini di comprendere informazioni complesse, prendere decisioni consapevoli e partecipare attivamente alla vita democratica.





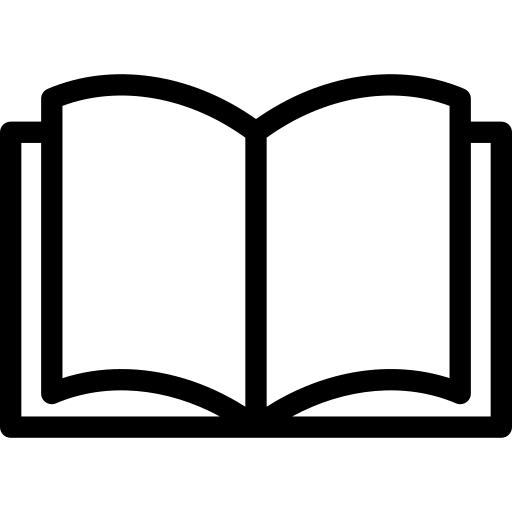

d’altronde sono anni che non si investe nella scuola e nella cultura, bisognerebbe che l’ISTAT dedicasse un’inchiesta su quanto il nostro paese ha investito nella scuola rispetto agli altri paesi europei.
Decenni di subcultura televisiva, social e telefonini mangiacervello, insegnanti incapaci e poco preparati… direi che è una situazione voluta per rendere innocui i cittadini. Queste statistiche sono lacrime di coccodrillo