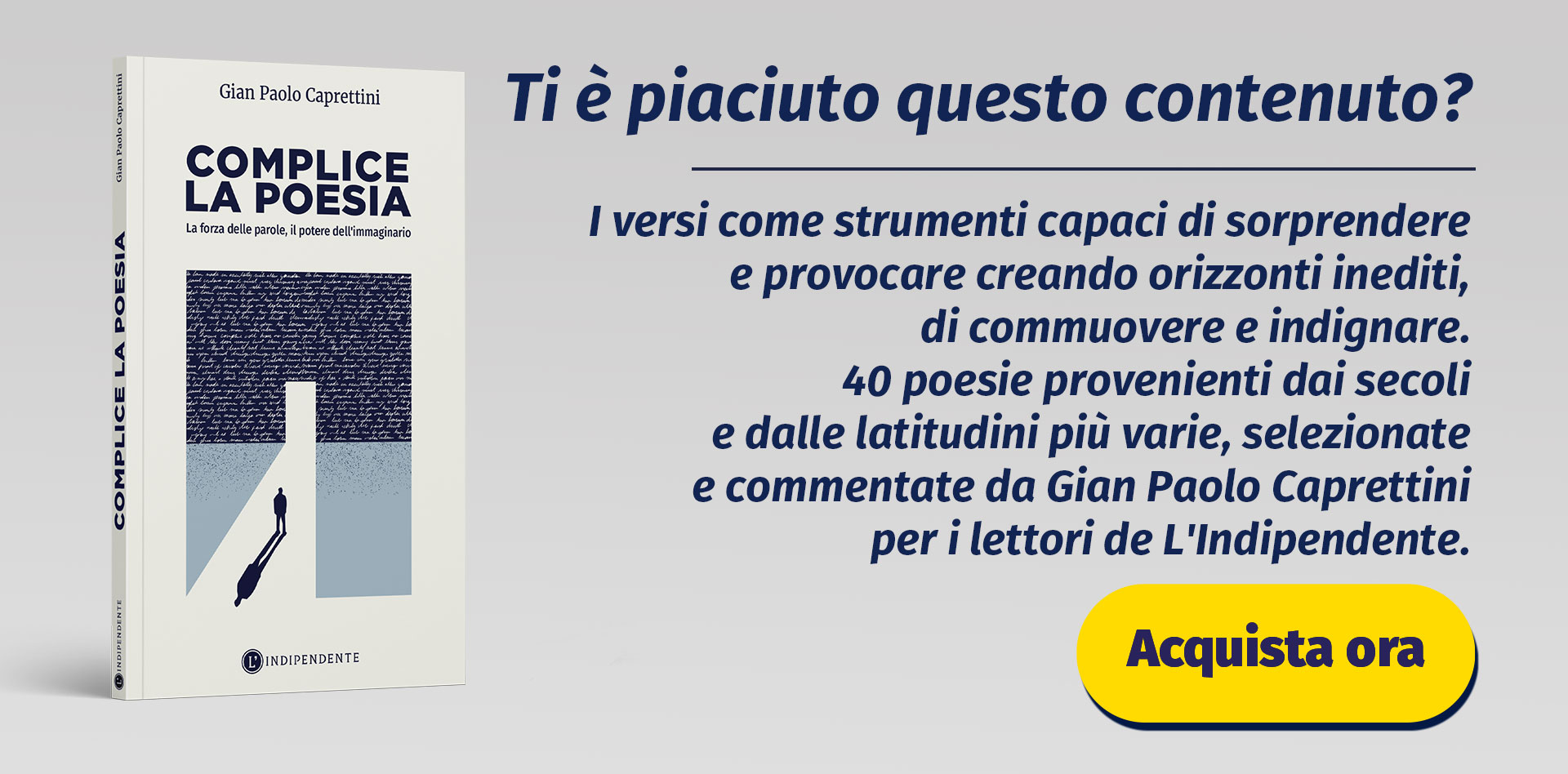Con le parole «I nostri pensieri e le nostre emozioni rimangono con noi come i solchi disegnati dalle onde sulla sabbia…» Satoshi Yagisawa conclude il suo romanzo Una sera tra amici a Jinbōchō (trad. it. Feltrinelli 2011). Jinbōchō, il quartiere di Tōkyō «dove quasi tutti i negozi vendono libri». E i pensieri e le emozioni sono quelle suscitate dai libri, cioè dalle parole che escono dai testi e ci vengono ad appartenere quando le leggiamo.
Tutto sta nella necessità di andare nelle profondità delle cose mostrandone però la leggerezza, la condizione di vuoto/pieno per cui le parole stesse smettono di connettersi a qualcosa, di concreto o di astratto: significano senza indicare. E quindi sono fallaci per definizione senza però volerci ingannare. Giocano quasi con la realtà, come un’immagine di qualcosa che non può restituirci perfettamente ciò che rappresenta.
Un’affermazione è zen – riferisce Giorgio Pasqualotto nella sua Estetica del vuoto (Marsilio 1992, p. 72) – solo in quanto produce un atto, non in quanto ci fa riferire a ciò che con essa viene affermato. Ecco che le parole sono diventate emozioni e poi solchi sulla sabbia. Si tratta allora di cogliere il significato in un atto, in un gesto, in uno stato di cose, dopo che le parole, avendo subìto una metamorfosi quasi poetica, illuminano con nuova luce angoli di spazio.
Che le parole si sottraggano a un compito descrittivo lo mostra bene la poesia dello haiku che va quasi a trasformare in pittura il contesto, sfumando gli oggetti in sensazioni: «languore d’inverno: / nel mondo di un solo colore / il suono del vento» (Matsuo Bashō), «guardo la luna: / nuvole se alzo gli occhi, se li abbasso / il sereno» (Miura Chora), «l’amore del gatto: / indifferente anche al riso / rimasto sui baffi» (Tan Taigi), «la baracca di un mendicante: / sopra si alza un aquilone / bellissimo» (Kobayashi Issa).
I capovolgimenti del pensiero richiesti in una tale concezione portavano Roland Barthes ad affermare che nella cucina del Giappone perfino la disposizione del cibo nei piatti restituiva qualcos’altro oltre a una idea di mise en place, di ordine: mostrava i segni di una scrittura. E questo in una visione apparentemente paradossale, almeno per noi occidentali, per cui lo scrivere (bella calligrafia, a parte) è la semplice applicazione di un saper fare, non l’esercizio di un’arte raffinata. Un’arte che scaturisce ad esempio anche dall’uso per il quale calligrafie e disegni venivano applicati su rotoli che andavano dunque poi srotolati per mostrare segni e immagini: una continua scommessa con una gestualità che è rivelatrice. Una dispositio, avrebbero detto i nostri antichi maestri di retorica, la quale però non attiene a una sintassi del discorso e dei ragionamenti ma fornisce un colpo d’occhio, la forma di una verità in un ordine. Anche nella direzione del sapere e del conoscere lo zen ci sorprende per accostare la sentenziosità alla inadeguatezza del dire [1], al suo tradimento necessario. Tradimenti, però, intrecciati a fraintendimenti, sorpresa intrecciata a saggezza.
In una storia di carattere zen si narra che un grande guerriero giapponese decise di attaccare un nemico molto più forte. Lui sapeva che avrebbe vinto ma i suoi soldati erano dubbiosi. Durante la marcia si fermò a un tempio shintoista e disse ai suoi uomini: «Dopo aver visitato il tempio butterò una moneta. Se viene testa vinceremo, se viene croce perderemo. Siamo nelle mani del destino». Nobunaga entrò nel tempio e pregò in silenzio. Uscì e gettò una moneta. Venne testa. I suoi soldati erano così impazienti di battersi che vinsero la battaglia senza difficoltà. «Nessuno può cambiare il destino», disse a Nobunaga il suo aiutante dopo la battaglia. «No davvero» disse Nobunaga, mostrandogli una moneta che aveva testa su tutt’e due le facce (101 storie zen, trad. it. Adelphi 1973, p. 76).
E ancora. «Un giorno Gasan istruiva i suoi seguaci: “Quelli che parlano contro l’assassinio e che desiderano risparmiare la vita di tutti gli esseri consapevoli hanno ragione… Ma che dire di quelle persone che ammazzano il tempo, che dire di quelli che distruggono la ricchezza e di quelli che distruggono l’economia pubblica? Non dovremmo tollerarli…”» (p. 77). Insomma, anche nei paradossi dello zen si nasconde, sorniona, una qualche forma di rivoluzione.