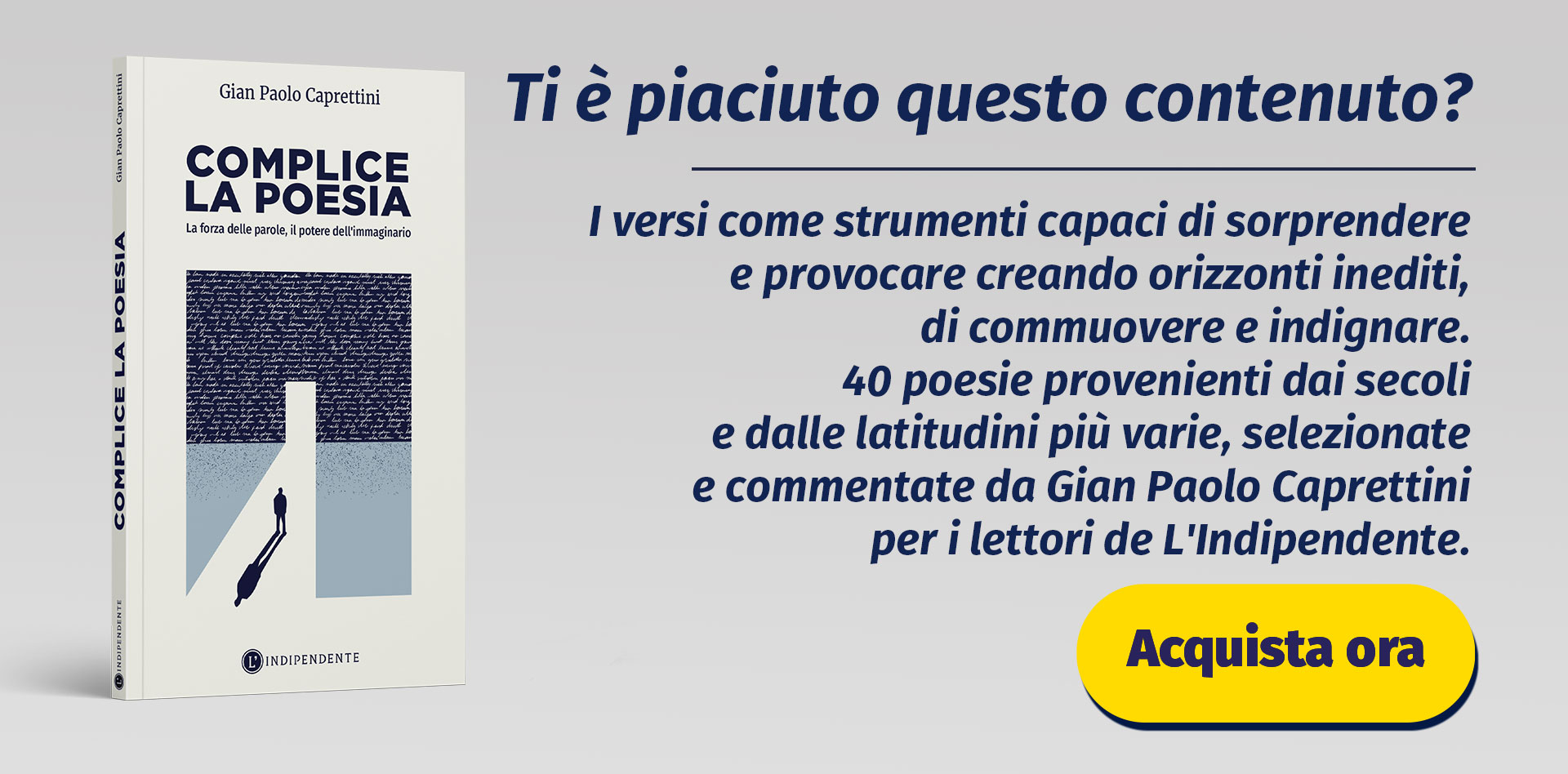Con i segni del gioco incontriamo gli oggetti e i soggetti, i procedimenti e i valori, i contesti e le regole che ne caratterizzano la struttura; ma i giochi sono spesso interattivi, prevedono il coinvolgimento di vari partecipanti, hanno funzione comunicativa. Il più delle volte chi gioca con noi è con noi solidale – nelle regole – ma avversario per il risultato, in quanto la meta, la vincita o la vittoria non è di tutti; e così per gli eventuali premi che non si dividono in parti eguali: si tratta insomma di una vera e propria comunicazione a un solo oggetto.
Ma è gioco anche l’enigmistica o il gioco in solitudine o simulato, dove l’avversario e chi si è proposto di giocare coincidono in un unico soggetto, che si è suddiviso in due distinti ruoli nell’atto stesso di mettersi alla prova, di sfidare le proprie capacità; in ultima analisi, si tratta di giocare non con un’altra persona ma con il Caso, quando ad esempio si tratta di gioco d’azzardo. In tale tipo di gioco-prova, l’ostacolo da superare è il gioco stesso, la sua capacità di autoriprodursi e di riproporre continuamente una posta, che non è il senso, ma il mezzo perché il gioco possa durare. Sotto quest’aspetto il senso del gioco e la sua durata coincidono: il senso del gioco è il tempo, null’altro che questo. Non si vince se non per acquisire il mezzo affinché il gioco possa continuare, non si gioca per vincere ma per continuare a giocare. Ecco dunque affiorare due distinte visioni. Nella prima, la competizione comporta una storia prevalentemente antagonistica, uno sviluppo dove si tratta di acquisire il bene, l’oggetto di valore, la posta in gioco sottraendola alla possibile vittoria di un altro. Nella seconda è in azione invece un meccanismo intracomunicativo, dove le sfide, le vittorie e le sconfitte coinvolgono un soggetto post-mitologico, “moderno”, che ritiene di potersi misurare con sé stesso. Si è detto che gioco è anche l’arena politica, con il suo perpetuo oscillare fra quel che è dichiarato e quel che è davvero sul tavolo: ma qui la posta è sempre tattica, mai strategica, in quanto la strategia va posta in essere non sul piano della comunicazione pubblica ma del progetto, che resta riservato a pochi (lo staff di un presidente, ad esempio).
La semiologia e la filosofia del linguaggio, con Saussure e Wittgenstein, hanno ripreso la metafora del gioco per spiegare il funzionamento del linguaggio e dei codici che producono senso; ma Wittgenstein, com’è noto, scelse quello che abbiamo chiamato “secondo modello”: «la parola “giuoco linguistico” è destinata a mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di un’attività, o di una forma di vita». Attività – e condotta – appunto, prima di tutto cognitiva, come fanno vedere i giochi d’immagine, dove si confrontano varie interpretazioni possibili a seconda che si focalizzino differenti punti di vista e dove l’idea stessa di realtà è messa in discussione dalla percezione che ne possiamo avere.
Gioco e giocattolo si distinguono in rapporto alla nozione di attore coinvolto, inteso in qualità di produttore, trasmettitore o ricettore. C’è la possibilità però che il giocattolo si trasformi in gioco, per mezzo della variazione del numero degli attori. Se qualcuno che gioca chiama qualcun altro a usare lo stesso giocattolo o giocattoli dello stesso tipo, il puro e semplice uso del giocattolo si trasforma in gioco, proprio per la presenza di più attori-giocatori. Il giocattolo è inoltre una merce, ha un suo prezzo, mentre il gioco no, non si può acquistare: non esiste una fase precedente a quella dell’usarlo, della pratica che lo riguarda, mentre nel giocattolo c’è una fase precedente a quella dell’uso che consiste nel suo acquisto. La conversione di giocattoli in giochi (e viceversa, ad esempio quando i giochi costituiscono prodotti da utilizzare successivamente) costituisce un problema semiotico, collegabile ai rapporti fra competenza ed esercizio delle facoltà linguistiche. Una ulteriore differenza consiste nel rapporto comunicativo con le regole: a questo riguardo nel giocattolo possiamo parlare di un donatore, nel gioco di un istruttore; in effetti nel gioco si può parlare di regole, nel giocattolo di istruzioni per l’uso. Ma l’esercizio delle regole richiede forme di controllo, e dunque la messa in campo di un potere che sovraintenda alla produzione del senso riconosciuta e accettata da una comunità. Queste componenti di tipo rituale si incontrano in forma residuale nei tradizionali giochi di carte, dove, per passare dalle norme al contesto, bisogna svolgere un pre-gioco che consiste nel determinare chi dovrà distribuire le carte, ma sono più accentuate in certi giochi infantili dove è percepibile chiaramente l’idea di una sacralizzazione dello spazio e di una definizione del limite. Prendiamo il gioco della grotta o campana, nel quale si disegna per terra un grande rettangolo suddiviso in una serie di quadrati sormontati da un semicerchio, si lancia una pietra, e si percorre la serie degli spazi contrassegnati evitando che nei rilanci successivi il sasso vada a finire nella tana, vale a dire nel recinto proibito.
Emergono così i significati di concesso-vietato, favorevole-sfavorevole, che contengono a livello profondo quell’opposizione vita-morte che il gioco vorrebbe esorcizzare attraverso la prova del percorso labirintico. Come mostra il gioco dell’Oca, una delle punizioni che si infliggono ai partecipanti consiste nel tornare indietro, nel perdere tempo, essendo il vantaggio primario quello di procedere in avanti per raggiungere per primi la meta. Con questo gioco il modello competitivo si intreccia con l’idea, in qualche modo pedagogica e iniziatica, che nel gioco come nella vita è meglio non compiere passi falsi; d’altra parte essi sono inevitabili, essendo vero quanto osserva l’antico detto taoista: «chi gioca spesso non può non perdere».