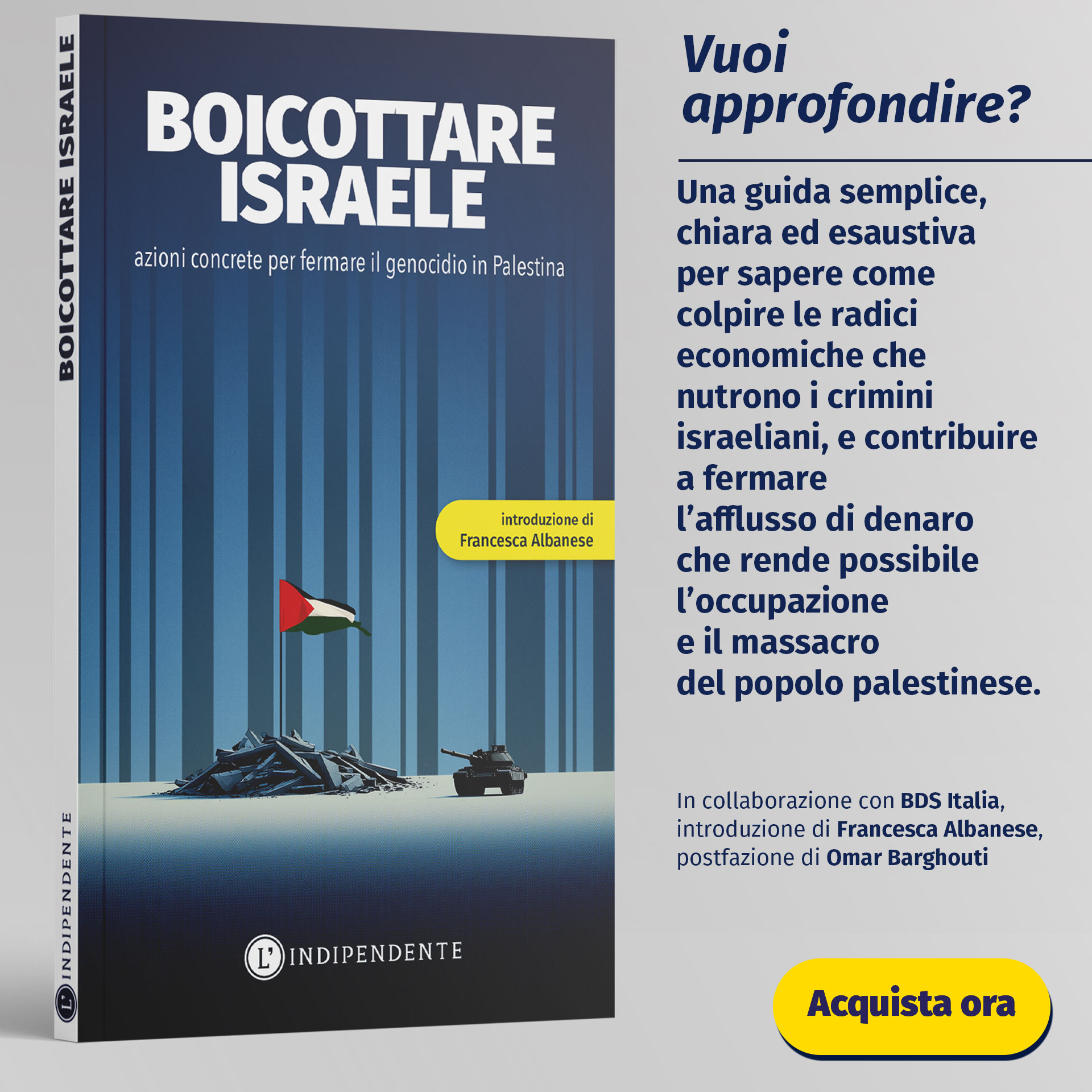Mentre Israele sta occupando militarmente la Striscia di Gaza, realizzando una deportazione de facto della popolazione palestinese, un attentato terrorista a Gerusalemme, rivendicato da Hamas, ha provocato sei vittime. Se dovessimo stilare una lista delle parole che suscitano un brivido di terrore in noi occidentali, la parola terrorista sarebbe in cima alla lista. Perché questa follia? Da dove nasce, perché nasce e come cresce questo male? Ma per capire davvero questo fenomeno, è necessario fare un passo indietro. Per capire non soltanto la genesi del terrorismo, ma perché il conflitto tra Israele e Palestina è durato per decenni fino a raggiungere il culmine con il genocidio in corso a Gaza.
Nel 1987 una donna israeliana di nome Arna Mer-Khamis fonda nel campo profughi di Jenin il Freedom Theatre, un teatro nato con lo scopo di dare ai bambini palestinesi un luogo dove poter immaginare qualcosa di diverso dalla guerra. I filmati registrati in quegli anni sono stati poi raccolti in un film-documentario I bambini di Arna. La prima volta che lo vidi rimasi scioccata. Fu anche la prima volta che vidi Jenin. Non ricordo di aver mai visto un posto simile prima, né la favelas, né le baraccopoli indiane, né i più sperduti e miseri villaggi africani hanno la bruttezza di Jenin. Una «città», distrutta e ricostruita più volte, che quando vennero effettuate le riprese era un cumulo di macerie. Letteralmente. E fu su un cumulo di macerie che venne trovato uno dei «bambini di Arna», il piccolo Ala che sedeva sullo scheletro della propria casa distrutta dai bombardamenti.
A poco a poco le riprese vanno avanti e facciamo la conoscenza degli altri bambini che Arna prende sotto la sua ala. Ashraf, Yuossef, Zakaria, Nidal, i loro nomi… Ma a restarti impressi sono soprattutto gli occhi tristi e rassegnati di Ala, la determinazione di Ashraf che diceva di voler diventare il «Romeo Palestinese», e il sorriso contagioso di Youssef.
Nel frattempo passano gli anni, il teatro viene chiuso e i bambini crescono. Quindici anni dopo il figlio di Arna, Juliano, nel bel mezzo della seconda intifada, torna a Jenin per scoprire che fine abbiano fatto.

Ashraf, che recitava la parte del principe che voleva catturare il sole, è stato ucciso durante la battaglia di Jenin. Ala invece è a capo della resistenza armata. Durante questa «battaglia» si vede gente in pantaloncini e maglietta che spara contro i carri armati. Chi non ha un fucile, lancia pietre. Un gesto che ad alcuni potrebbe sembrare un simbolo di resistenza, ma che visto in quei filmati che sono cronache in diretta di una guerra senza via d’uscita, trasmette un senso di disperazione.
Juliano intervista Ala, e quando gli domanda: ti arrenderesti? Ala gli risponde: «arrendermi mai». Libertà o morte, dice con un sorriso triste, ma in realtà sembra dire: la libertà è la morte. Da questo inferno. Muore poco dopo, poco prima della resa di Jenin. Infine ci viene mostrato Youssef, il bambino dal sorriso irresistibile.
Indossa una divisa mimetica, ha la barba e una bandana nera sulla testa, gli occhi vuoti come quelli di un morto che cammina. Del bambino sorridente che era prima non è rimasta traccia. Alle sue spalle c’è la foto di Reham Wared, la bambina di Jenin morta dissanguata dopo che una bomba aveva colpito la sua scuola. A restarti impressa è la sua voce mentre dice addio alla sua famiglia. Non c’è odio, né rabbia, né rimpianto, né disperazione, né tristezza o paura nella sua voce. Nulla.
Si è fatto saltare in aria una settimana dopo aver girato quel filmato, uccidendo quattro persone in un attacco suicida. E allora non puoi fare a meno di domandarti: cos’è successo a quel bambino che rideva sempre? Forse la risposta è lì, in quello sguardo vuoto, in quello sguardo piatto.
Il 29 novembre 2001 quattro israeliani sono stati uccisi da un attacco suicida a nord di Tel Aviv. Il primo dicembre, stavolta a Gerusalemme, due kamikaze hanno ucciso dodici persone e ne hanno ferite centottanta. Il giorno dopo un attentatore ha fatto saltare in aria un autobus a Haifa. Il 5 dicembre un altro terrorista si è fatto esplodere proprio nel centro di Gerusalemme.
Vi ho parlato di Jenin per farvi sentire cosa significhi essere un palestinese. Perché sentire è il primo passo per capire. Ma se volete davvero capire il conflitto tra Israele e Palestina, provate adesso a mettervi nei panni di un israeliano e a immaginare cosa si prova a vivere a Tel Aviv, a Gerusalemme o in qualche altre distretto d’Israele.
Impari innanzitutto a non frequentare certe strade. Ad evitare i luoghi affollati. Quando porti i tuoi figli a scuola, ti domandi: li rivedrò ancora?
«Il dito compone freneticamente i numeri degli ospedali dove sono ricoverati i feriti. È arrivata da voi la signorina…? Il centralinista scorre gli elenchi in suo possesso. Secondi lunghi come l’eternità. Pensiamo a lei. Pensiamo a come sarà senza di lei. Alla radio trasmettono le urla di giubilo registrate da radio Hamas a Nablus: «Vendicheremo la tua morte, Abu Hanud».
Allora dove sta il bene e dove sta il male? Chi dobbiamo condannare? Per chi dobbiamo parteggiare?

La politica giudica, il tribunale condanna, la Storia spiega, sviscera ed esamina le ragioni, i perché e i percome, e con il senno di poi assegna meriti e colpe. L’arte invece no, fa qualcosa di più: ti fa sentire. Ogni cosa. Ma torniamo a Youssef, il bambino che recitava in un teatro di Jenin e che da grande è diventato un terrorista. La domanda che non puoi fare a meno di porti è: perché? Da cosa nasce e perché nasce questo male?
La cattiveria che tu mi insegni io la metterò in pratica, dice Shylock nel Mercante di Venezia mentre pretende una libbra di carne di Antonio, suo rivale in affari e suo debitore, e in pratica chiede e pretende il diritto di ucciderlo. E una delle pagine più belle e drammatiche di tutta la letteratura è il momento in cui Shylock pronuncia queste parole: «Ha deriso delle mie perdite, ha schernito i miei guadagni, ha denigrato la mia nazione, ha intralciato i miei affari, mi ha gelato gli amici, mi ha acceso contro i nemici; e tutto questo perché? Perché sono un ebreo».
Nel XVI secolo, l’epoca di Shakespeare, quando compariva in scena l’ebreo era sempre descritto come un essere meschino, avido e inferiore, ma invece Shakespeare, essendo Shakespeare, rivoluziona questo stereotipo e ci costringe a sentire tutto il dolore di Shylock. E poi Shylock incalza: «Se ci pungete non sanguiniamo? Se ci fate il solletico, non ridiamo? Se ci avvelenate, non moriamo? E se ci fate un torto, non ci dobbiamo vendicare? »
Ecco il «manifesto» della vendetta. La vittima diventa Carnefice. E alle volte lo supera perfino in crudeltà, astuzia e perfidia, come ci mostra Shylock nel Mercante di Venezia. Tu hai ucciso me, ed io uccido te. Io ho sofferto, e tu soffrirai. Io ho sanguinato e tu sanguinerai. Quando David Grossman riporta le grida di giubilo di radio Hamas, il cerchio si è chiuso.
Violenza, condanna e rappresaglia e al termine della rappresaglia, una nuova spirale di violenza. Questa, volendo essere sintetici, è stata la storia degli israeliani e dei palestinesi negli ultimi settant’anni. Ma perché nessuno ha mai interrotto questo ciclo?
C’è un altro romanzo, I robot e l’Impero, di Isaac Asimov, che ci può aiutare a comprendere meglio quello che sta accadendo in Palestina. Una delle invenzioni più affascinanti di Asimov furono le sue tre famose leggi della robotica.
La Prima Legge recita: «Un robot non può recare danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno». Un robot che permetta, anche in modo involontario, che a un essere umano venga fatto del male si auto-distrugge. A un certo punto però accade che alcuni esseri umani, atterrati su un pianeta di nome Solaria, s’imbattano in un robot-supervisore. Il robot all’inizio li osserva con attenzione, senza fare nulla, li ascolta e poi di colpo esclama: «Tu non sei un essere umano». E li attacca.
Come può un robot, programmato e vincolato dalla Prima Legge, tentare di uccidere un essere umano? È un comportamento che altera le fondamenta stessa del mondo di Asimov. Ma ecco quel guizzo di genialità che irrompe in quest’opera di fantascienza e che ci fa capire tanto non sul mondo creato da Asimov ma sul nostro.
Un robot può uccidere tranquillamente un essere umano, senza violare la Prima Legge. «a patto di modificare la definizione di essere umano. Per il robot supervisore la proprietà basilare di un essere umano era il linguaggio. (…) qualsiasi cosa di sembianze umane era definibile come essere umano solo se parlava il Solariano. Mentre, a quanto pare, qualunque cosa di aspetto umano che non parlasse con accento solariano doveva essere distrutto senza esitare».
Geniale, no? Come può un soldato sparare a un uomo disarmato? Perché il fucile non esita? Perché la mano non gli trema? Come può un uomo farsi saltare in aria per uccidere, volontariamente e consapevolmente, altre persone? Perché la sua mano non esita? Perché i suoi occhi non tremano? Come possono delle persone che sono padri e madri, fratelli e sorelle, figli, mogli, compagni abituarsi a una carneficina di cui sono complici o artefici? Alterando la definizione di essere umano.
E c’è una parola perfetta per farlo: Nemico. Il Nemico non è umano, non quanto lo sono io. I suoi cari non valgono quanto i miei. Lui non soffre quello che soffro io, non ha amato come ho amato io, non sogna quello che sogno io e certamente non piange con l’intensità con cui piango io.

«Caio è un uomo, gli uomini sono mortali, quindi Caio è mortale», così pensa Ivan Ilijc in quel libro straordinario che si chiama La morte di Ivan Ilijc. Quel semplice sillogismo: Caio è un uomo, tutti gli uomini sono mortali, dunque Caio è mortale, era parso a Ivan Ilijc, «giusto soltanto nei riguardi di Caio. (…) Forse che Caio era stato innamorato come lui? Forse che Caio poteva condurre a termine l’istruzione d’un processo? Caio, sì, è mortale, ed è giusto che muoia, ma non io». Il Nemico è come Caio. La sua vita non vale quanto la mia; se non ha sentimenti profondi come lo sono i miei, posso ucciderlo. O vederlo morire, senza sentirmi in colpa. «Quando il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant» scrive Omar El Akkad, «dice che Israele sta lottando contro degli “animali”, non si tratta soltanto di una dichiarazione convinta, ma di un via libera».
In ogni guerra, in ogni conflitto c’è sempre un «noi» e un «loro». Non solo per chi la guerra la vive, la soffre e la patisce da vicino, ma anche per chi la guerra la osserva e la commenta da molto lontano.
Oggi Israele per molti ha il volto di Netanyahu. Ha il volto del Colono che con ardore fanatico vuole riportare Israele alla sua antica grandezza. Ha il volto del soldato che spara alla folla indifesa in attesa di ricevere aiuti. Per altri invece, per coloro che hanno preso le parti di Israele, la Palestina ha il volto di Hamas. Arabo, musulmano, terrorista: queste parole sono funzionali alla completa disumanizzazione del popolo palestinese che tiene in piedi la propaganda sionista. Ed è anche il motivo per cui in Occidente molti esitano, o più precisamente si sentono meno coinvolti emotivamente parlando, nel condannare Israele.
Il genocidio dei palestinesi viene ridimensionato nel tessuto collettivo ed emotivo per il semplice fatto che il palestinese non viene percepito come un essere umano a tutti gli effetti. La Storia è intessuta di categorie di persone, gli indios, i neri, gli ebrei, che furono percepiti come esseri inferiori, e dunque soggetti sui quali era possibile esercitare una violenza inaccettabile per la società civile. L’unico modo per far perdere terreno alla propaganda israeliana è nel riumanizzare il popolo palestinese, restituendogli quella complessità che la Storia gli ha sottratto. Peccato, che quando ciò avverrà, sarà comunque troppo tardi.