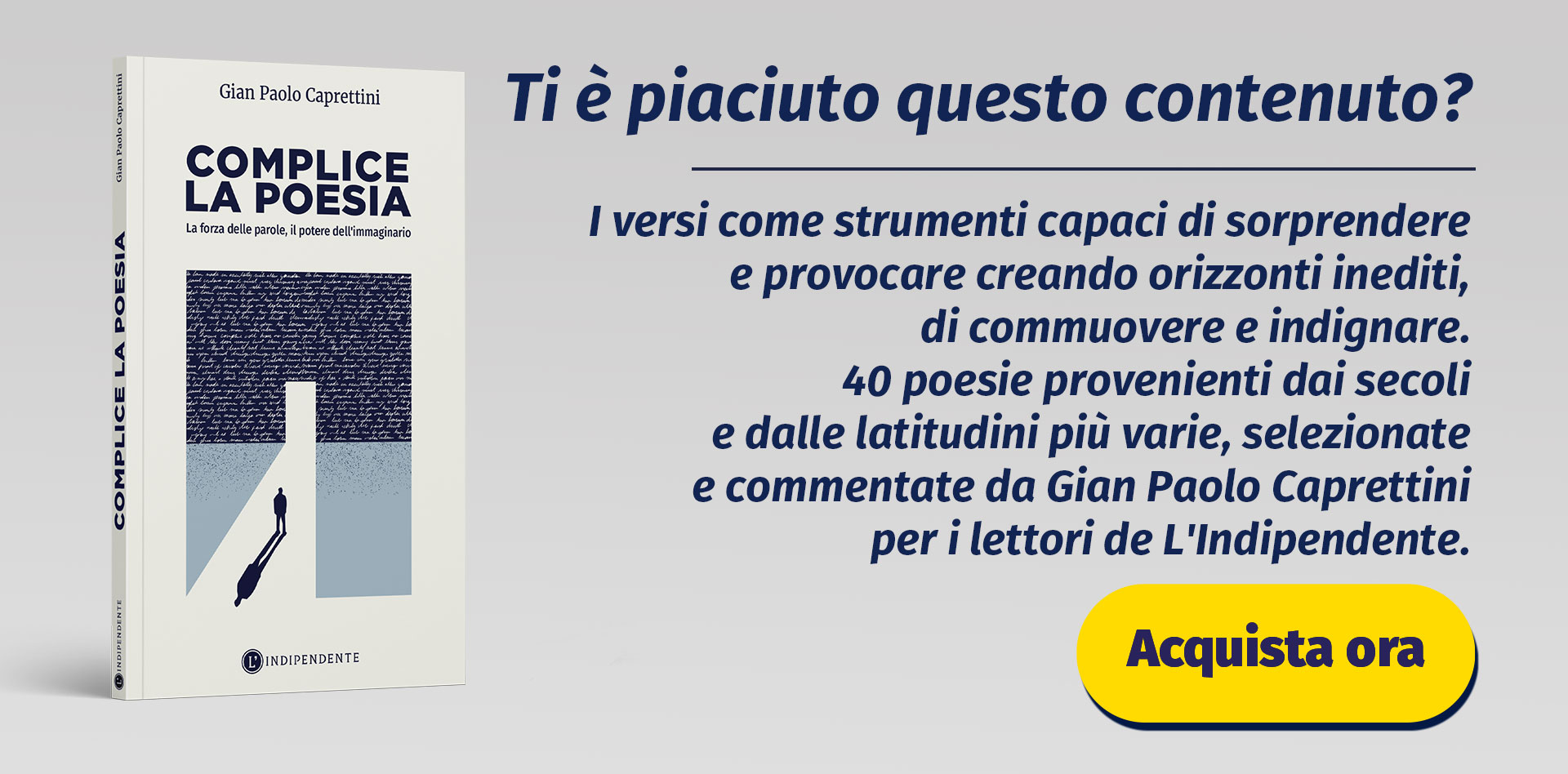Perché ‘società artificiale’? Heinrich Popitz, sociologo tedesco, ha espresso una delle molte teorie sullo sviluppo storico e sociale attraverso tappe evolutive. Una teoria suggestiva sicuramente, che implicitamente individua il nostro mondo come un organismo vivente che passa attraverso varie età e conosce fasi alterne di sviluppo e recessione, di crescita e malattia.
Nei suoi studi raccolti in Verso una società artificiale (Editori Riuniti 1996) Popitz rintraccia le tappe dell’umanità in una fase di caccia e raccolta, contrassegnata dal nomadismo, a cui succede la sedentarietà dell’agricoltura, dove si circoscrivono gli spazi operativi del lavoro, si fondano e si perpetuano agglomerati familiari e si fissa l’idea di tempo ciclico, generatrice a sua volta di una speciale idea di pazienza e attesa. Poi il periodo del fuoco, del vapore, dell’industria, rappresentato soprattutto, a suo parere, dall’artigianato e dalla ceramica, vero emblema dell’avvento borghese, con conseguente divisione del lavoro e ripartizione delle competenze nella società, ad esempio tra contadini e artigiani. E poi l’epoca delle città, del potere organizzato, dei compiti istituzionali. In ultimo la società artificiale, più difficile da definire, pensata più come una potenziale eventualità che come una evoluzione, dove si avvertono altre immagini di altri studiosi, la società aperta di Popper, la società liquida di Bauman, la società dell’automazione di McLuhan.
Ma, a guardar bene, tutte queste epoche e tutte queste teorie, nella postmodernità, non sono più alternative o ordinate in qualche successione: esse si sono fuse in un solo dominio, reale e immaginario. Sono dimensioni della vita, esigenze e prospettive interagenti. Non sappiamo fino a quando, ma l’attività della pesca è ancora in gran parte del tipo caccia e raccolta, la fase agricola, alla base della costituzione della famiglia, è minacciata ma permane. Minacciata da che cosa, però? Da malsane teorie, no, semplicemente dalla macchina, dalla industrializzazione che può trasformare i contadini in nomadi, in migranti. “La sera, seduti intorno ai fuochi, i cento diventavano uno. Imparavano a diventare comunità da bivacco, comunità da sera e da notte. Qualcuno estraeva una chitarra dall’involto di una coperta e la accordava; e le canzoni che tutti conoscevano si levavano nella notte. Gli uomini cantavano le parole, le donne modulavano piano la melodia”. Questi sono i contadini disperati, assediati dai debiti bancari, dai trattori e dalle tempeste di polvere, che fuggono in America verso l’Ovest, negli anni della recessione. È John Steinbeck, in Furore (1939), che racconta la loro epopea. “Dapprima le famiglie erano titubanti ma gradualmente … emersero capi, si stabilirono leggi, presero forma codici. E man mano che si spostavano verso ponente, i mondi diventavano più completi e meglio attrezzati, poiché i loro costruttori avevano maturato esperienza nel costruirli” (trad.it. Bompiani 2013, p. 271-73). Adattamento e ripartenza, come nei miti antichi del diluvio e della fine.
In questa rifondazione, all’orizzonte, si fa strada l’idea di città, la penultima tappa secondo Popitz. La cosmologia che si rimodella continuamente – scrive Joseph Rykwert ne L’idea di città (trad. it. Einaudi)- è quella che riparte da noi stessi, dalla costituzione e struttura della persona. Le città che nei secoli abbiamo costruito sono simboli di memoria, in cui ogni abitante partecipa a una serie di eventi e si identifica con la propria città, coi suoi fondatori e col suo passato. Funzione della città moderna è però anche quella di mettere in moto gli individui e i beni, favorendone la circolazione. Utopia, certo, messa oggi a dura prova, che Italo Calvino così presentava in Gli dèi della città (1975): “Ogni città ha un suo programma implicito, un suo elemento di continuità che deve saper ritrovare ogni volta che lo perde di vista, pena l’estinzione… Una città può passare attraverso catastrofi e medioevi, vedere stirpi diverse succedersi nelle sue case, veder cambiare le sua case pietra per pietra, ma deve, al momento giusto, sotto forme diverse, ritrovare i suoi dèi” (pp. 349-50).
L’ultima rivoluzione tecnologica, dopo l’agricoltura, la lavorazione a fuoco, le grandi opere edili e, aggiungiamo, le tecnologie del movimento e della comunicazione, dalla ferrovia alla posta, dall’aereo alla radio, dalla tivù ai new media, è quella attuale, dove ancora una volta si misurano nuovi rapporti tra progresso tecnologico ed evoluzione delle strutture sociali. Per tappe accelerate, l’uomo è arrivato a vivere in un mondo di oggetti che si è creato da sé, ma ormai la produzione industriale è finita sull’orizzonte, gli oggetti sono sempre più incorporei, “le relazioni di scambio diventano sempre più astratte, le dipendenze dai bisogni di altri anonimi sempre più imperscrutabili” (Popitz, p. 99). Il potere è diventato una specifica autonoma struttura, l’offerta di servizi sproporzionata e assillante; dietro la velocità di prestazione si nascondono le forme di controllo. L’informatica ha favorito, sì, i processi di automazione ma presto è diventata l’alleata del potere amministrativo, cioè del potere in sé che non produce ma organizza, amministra e reprime occultandosi dietro lo schermo della razionalizzazione, efficienza, disponibilità di informazioni, innovazione tecnologica e di rete.
Il potere è il nuovo meccanismo di produzione, il consumo è rappresentato dall’adeguamento degli individui e delle masse, la customer satisfaction coincide con il godimento passivo dell’obbedienza, il piacere sembra estinto. Ma questo, per fortuna, rimane soltanto un distopico obiettivo, remoto, che nessuna pandemia riuscirà a raggiungere.
Uno dei miei autori preferiti, Jurij M.Lotman, utilizza varie metafore per parlare del concetto di ‘semiosfera’, cioè della complessità e interdipendenza dei sistemi di segni che nessun potere è in grado di ridurre a suo piacimento. La vita sociale e simbolica è come quella di una lingua, impensabile senza sinonimi, senza alternative nelle scelte espressive, senza fraintendimenti, senza errori. La metafora è quella del museo. Immaginiamo la sala di un museo nella quale siano esposti oggetti ed opere appartenenti a secoli diversi, iscrizioni in lingue note e ignote, testi redatti dagli organizzatori del museo, schemi di itinerari per la visita della mostra, vari allestimenti ecc. ecc. “Se vi collochiamo anche i visitatori con i loro mondi semiotici, avremo qualcosa che ricorda il quadro della semiosfera” (La semiosfera, Marsilio 1985, p. 64).
Diventare spettatori, tenere le distanze, azionare i nostri orizzonti simbolici. Considerare il mondo anche come un museo di cui siamo, noi e tutti insieme, visitatori. Altro ancora ci aspetta, altri ancora ci aspettano all’uscita da quelle sale.
[di Gian Paolo Caprettini – semiologo, critico televisivo, accademico]